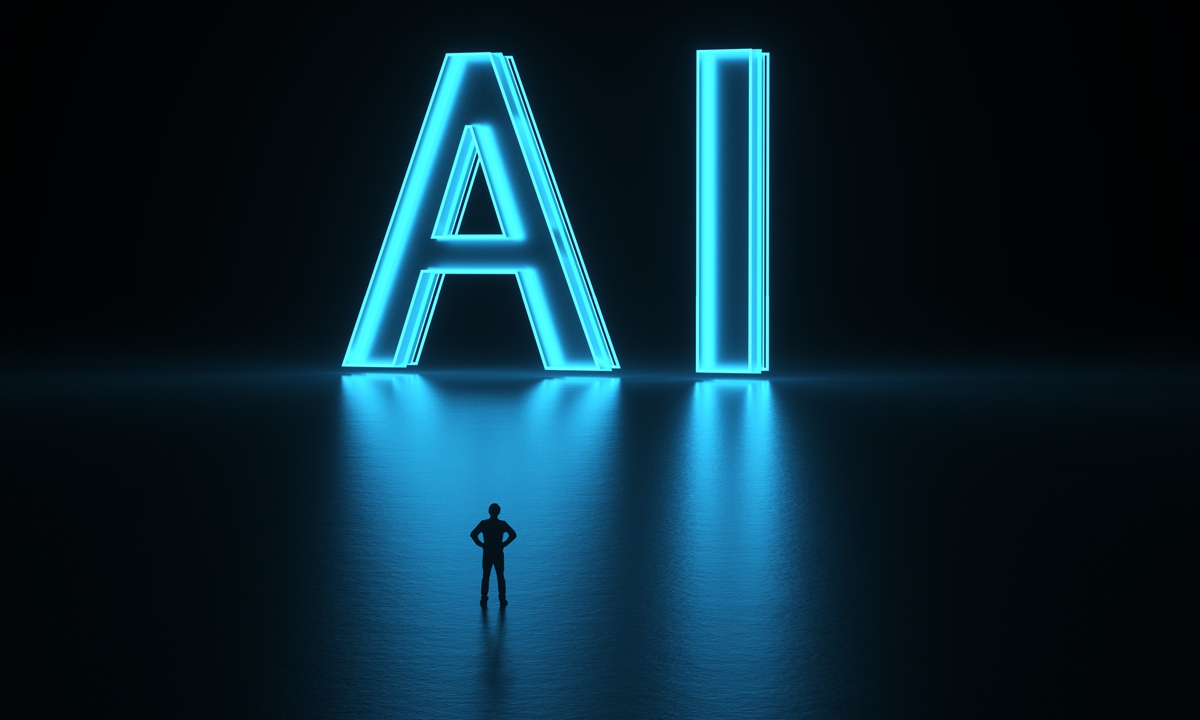
Will AI chatbots like ChatGPT replace writers in near future?
12 Febbraio 2023
Amélie e le sue sorelle
12 Febbraio 2023a cura di Alessia Rastelli
«Le tue parole odorano di bucato pulito». Lo pensa una madre quasi analfabeta, inghiottita dalla guerra e poi miracolosamente riapparsa, provando a leggere i primi testi della figlia che vuole diventare scrittrice, raccontare e rompere il silenzio. Una frase semplice, ma che dice già tutto. Le parole non sono solo parole. Le parole odorano, sanno di buono, di resistenza e di amore, curano e ricuciono anche se si è attraversato il male.
È una grande testimonianza di fiducia e riconoscenza per il linguaggio e la scrittura Cassandra a Mogadiscio, il nuovo libro di Igiaba Scego in uscita da Bompiani. Una genealogia accorata, appassionata, straordinariamente sincera della propria famiglia dispersa, vittima prima della dittatura e poi della guerra civile in Somalia. La storia e la geografia di uno sradicamento in forma di lettera a una nipote adorata, Soraya, figlia del fratello dell’autrice, la quale in fondo si rivolge anche a sé stessa. «Scrivere mi ha salvato più volte», confessa. E questa convinzione nutre una prosa corposa e ricca, materica. A impreziosirla, vocaboli attinti dal somalo. A sorreggerla, l’incedere incalzante di chi ha a lungo taciuto e vuole parlare; e insieme sa, come via via racconta, che i suoi occhi sono malati e potrebbe all’improvviso perdere la vista.
In questa conversazione Scego dialoga con Jhumpa Lahiri, scrittrice Pulitzer, americana di origine indiana che ha attraversato anche lei i confini tra identità e culture. E che, da circa un decennio, trasferitasi a Roma, ha adottato l’italiano come lingua letteraria. Tra le due autrici un retroterra fatto di esperienze che si somigliano, ma anche una posizione fortemente condivisa: «Se abiti davvero una lingua non sei né straniero né nativo, sei solo lingua, oltre ogni etichetta».
«Cassandra a Mogadiscio» pone fin dalle prime pagine il tema delle diverse lingue parlate dai membri di una famiglia dispersa. Soraya, la nipote destinataria del libro, vive a Montréal, usa il francese e ha difficoltà a comunicare con la nonna. «Vorrei imparare l’italiano — le dice —. Per starvi più vicina».
IGIABA SCEGO — Ovviamente mi auguro che abbia l’occasione di studiare anche il somalo, che è la prima lingua di mia madre e che io stessa ho sempre usato in famiglia. Ma per lei, che parla francese, imparare l’italiano è più facile, veloce. E per potere comunicare con sua nonna che è anziana, raccontarsi tutto e al più presto, questa rapidità è importante. L’italiano, inoltre, a casa mia ha sempre viaggiato su un doppio binario: se da una parte fu la lingua nemica imposta ai miei antenati dai colonizzatori, dall’altra è diventato anche, nel tempo, una lingua degli affetti. Certamente per me, che sono nata a Roma e lo uso nella vita e nella scrittura. Ma già anche per i miei fratelli più grandi, ai quali fu insegnato a scuola in Somalia: in classe studiavano Dante, Petrarca, Boccaccio… Autori che contribuirono a rendere il rapporto con l’italiano meno ostile, a creare un legame.
JHUMPA LAHIRI — Trovarsi a cavallo tra due idiomi, quello della propria casa e quello della scuola e delle esperienze fuori, è qualcosa che anche io ho vissuto negli Stati Uniti. C’era il bengali in famiglia e c’era l’inglese, la lingua della mia formazione, ma che era stata anche quella dei colonizzatori in India. Più di recente, a tutto questo si è aggiunto l’italiano, una lingua scelta. Un po’ come fece Samuel Beckett: quando era ancora in Irlanda studiò il francese, e anche l’italiano, poi si spostò a Parigi e lì decise di adottare le parole del luogo, senza abbandonare completamente l’inglese. Io ho avuto un innamoramento totalizzante, come se l’italiano mi stesse aspettando. Ora scrivere narrativa in inglese sarebbe strano, quasi fosse tornato la lingua aliena di una volta, di quando ero piccola.
IGIABA SCEGO — Il percorso per cui usiamo l’italiano è completamente diverso, ma nel mio caso ha significato anche molta libertà. La libertà di dire cose che in somalo non riuscirei mai a rivelare. Alla mia comunità, ai parenti, a mia madre…
JHUMPA LAHIRI — Per me l’immagine più chiara è l’innesto. Mi sono innestata in una nuova lingua, e questo comporta anche un taglio, una ferita. Con l’italiano vado più al dunque, all’essenza, soprattutto perché non possiedo il bagaglio che avevo in inglese. È una scelta di auto-impoverimento, per togliere. Ma io resto la stessa scrittrice. Come un musicista che passi dal pianoforte al violoncello: cambia strumento, ma fa sempre musica.
Nel caso di Igiaba Scego l’italiano sembra prestarsi a un’espansione del linguaggio, quasi un’esplosione piuttosto che una sottrazione.
IGIABA SCEGO — Il mio carattere e la mia scrittura sono effettivamente esplosivi, perché vengo da tanto silenzio. Per quasi tutta l’infanzia e l’adolescenza non parlavo mai e leggevo molto, mentre intorno mi accadevano fatti enormi. Sono nata a Roma da genitori scappati dalla dittatura in Somalia. Lì mio padre era stato un ministro ma qui vivevamo in povertà. Poi ci fu la guerra civile, con mia madre dispersa per due anni nel Paese d’origine, senza mai avere notizie. La svolta per me arrivò solo all’università.
Che cosa accadde?
IGIABA SCEGO — Fu allora che mi avvicinai ad altre due lingue, lo spagnolo e il portoghese, e quindi all’America Latina e alla sua letteratura. Compresi che i temi che riguardavano la mia vita non erano solo miei, ma già di Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Jorge Amado… E che potevo essere la me stessa non ancora uscita fuori. Amavo soprattutto il Brasile, poi più tardi capii perché. È uno degli Stati più neri fuori dall’Africa, ha una storia legata alla schiavitù, al colonialismo: tanto di ciò che sentivo mio, ma che non riuscivo a dire. La lettura prima e la scrittura poi mi hanno salvata. Scrivere è stata un’urgenza per uscire dal silenzio, per raccontare quanto aveva attraversato la mia vita: l’esilio dei miei genitori, la guerra, la pelle nera. Perché comunque in Italia c’è un razzismo non esplicitato, e io volevo che diventasse parola. Ecco, nella mia scrittura è come se ci fosse un tentativo di cura sia di me stessa sia di questo Paese meraviglioso, in cui però di alcuni temi ancora non parliamo.
JHUMPA LAHIRI — Io ho sempre avuto un legame ambivalente con ogni luogo. Mi sono sempre sentita una creatura ibrida: è il mio destino e di tanti miei personaggi. Appartengo, ma solo fino a un certo punto, perché poi subentrano un nome e un aspetto fisico che mettono un confine. Anche in Italia, Paese che amo e che scelgo, sono pur sempre parte di una presenza straniera. La mia raccolta più recente, Racconti romani (Guanda), parla proprio del sentirsi stranieri. Esplora una città che adoro, che accoglie e che però insieme respinge. La duplicità di Roma, la capitale, ma che vale in generale per l’Italia e altri Paesi. C’è sempre questa tensione tra accogliere e ostacolare il flusso delle persone, la migrazione, i cambiamenti. Eppure io sto traducendo proprio ora le Metamorfosi di Ovidio, e non parlano d’altro che di identità mutevoli, di una cosa che diventa un’altra di continuo. Sono queste la realtà e la storia del mondo. Infine, mi piace molto quello che dice Igiaba sull’usare la parola per rendere reale qualcosa che, altrimenti, potrebbe scivolare nel silenzio. Lei stessa tratta nel libro alcuni episodi di razzismo che purtroppo, anche nella nostra amata Italia, ci sono. Ce n’è uno in cui, nel bagno di una stazione, una donna spruzza qualcosa addosso a lei e sua madre, trattandole — racconta — come parassiti da disinfettare. Una scena dolorosa, brutale, che però la scrittura fa emergere e non lascia cadere nel vuoto del «non ne parliamo», «non è vero», «non è così».
Il silenzio è anche quello sul passato. L’Italia non sembra avere ancora fatto i conti con il colonialismo.
IGIABA SCEGO — Oggi sembra esserci una coscienza più aperta al voler comprendere. Ma il rischio è dividerci in tifoserie, quando invece il periodo coloniale è stato complesso. Io stessa ho alcuni zii che si arruolarono al fianco degli italiani in Etiopia, senza capire bene quello che andavano a fare. I carnefici sono tanti, ma tra loro ci sono carnefici che sono anche vittime. La memoria non dovrebbe essere statica né retorica. Sono le piccole storie che vanno recuperate, sia dei colonizzati sia dei colonizzatori. Ci sono lettori che vengono alle mie presentazioni con le foto dei nonni in Somalia, Eritrea, Etiopia, e mi chiedono quasi perdono. Mi commuove, ma non credo sia tanto questo ciò che si deve cercare, quanto la realtà dei fatti, capire quanto è successo per creare poi una nuova Italia, un nuovo modo di stare insieme. Ecco perché credo che gli armadi di famiglia vadano aperti.
JHUMPA LAHIRI — È sempre la curiosità che ci salva, lo studio, la lettura. Da bambina ad esempio andavo in India d’estate e quando tornavo a scuola nessuno, neanche l’insegnante, mi chiedeva dove fossi stata. Una rimozione totale, una chiusura mentale che è la cosa più triste e pericolosa che ci sia. Dunque anche per me la lettura è stata salvezza, perché mi portava fuori da quella dimensione. Ed è pure per questo che considero le traduzioni così importanti, perché permettono di sconfinare, capire altri mondi, tempi, Paesi, culture. Inoltre, sì, sono d’accordo con Igiaba, sono le piccole storie che fanno la Storia. In questo periodo in cui sono alle prese con Ovidio, rileggo anche Omero: nei suoi stessi versi la guerra è raccontata attraverso episodi, dettagli, situazioni di famiglia… È quello che dovremmo sempre fare, il nostro lavoro, la nostra chiamata.
IGIABA SCEGO — Il titolo del mio libro, Cassandra a Mogadiscio, attinge proprio dall’epica classica. Cassandra in fondo siamo tutti noi quando vediamo e non siamo creduti. Lo è persino il Papa, che è da poco stato in Congo e Sud Sudan, che parla di guerre dimenticate ma non sembra ascoltato. In questa fase si discute giustamente del conflitto in Ucraina, ed è bene che l’attenzione non cali. Al contempo dovrebbe riaccendersi su guerre in corso in altre parti del mondo, di cui nessuno pare curarsi.
Nel suo libro Igiaba Scego accenna al rischio che la vostra scrittura e le vostre stesse figure siano inserite in «gabbie contenutistiche», etichettate.
JHUMPA LAHIRI — Non mi piacciono le etichette. Capisco che alcune categorie siano necessarie per classificare le opere in biblioteca, in libreria… Ma mi colpisce molto ad esempio che qui, tuttora, in alcuni punti vendita i miei titoli in italiano siano considerati «Letteratura straniera». I libri infatti sono in italiano, però vengono esposti così perché sono io a essere straniera. Ma allora la domanda è: che cosa rende una lingua mia anziché tua? Anche negli Stati Uniti ho parlato apertamente di problemi simili, ad esempio del fatto di trovarsi in un «ghetto», come quello della cosiddetta «seconda generazione americana»… Ma che senso ha in un Paese come gli Usa dove, a parte chi ci viveva da sempre, tutta la popolazione viene da fuori? Che cosa succederà allora? Che io tra cinquant’anni sarò americana e ci sarà qualcun’altra che viene da chissà dove e sarà lei quella «nuova»? Non ha senso, le etichette tradiscono e falliscono.
IGIABA SCEGO — Una cosa che ho voluto fare nel libro è specificare ogni tanto la genealogia della lingua e della letteratura italiane. Cito Dante, Petrarca, Boccaccio certamente, ma anche le scrittrici: Dacia Maraini, Elsa Morante, Natalia Ginzburg… E poi autrici e autori il cui background è in un altrove, come Pap Khouma, Amir Issaa, Leila El Houssi, Takoua Ben Mohamed, Djarah Kan, la stessa Jhumpa… Pluralità, oltre le etichette. E penso sia proprio la lingua a distruggerle. Il suo uso, il fatto che la si abiti, non ti rendono né straniero né nativo, ma semplicemente lingua. L’editoria italiana però deve fare uno sforzo. Non soltanto nello scouting di nuove voci. Ma anche nell’integrare la complessità di classe, di appartenenza, di visioni. Per lungo tempo è stata molto borghese, altolocata, mentre deve farsi un po’ più vivere e abitare da quella che è l’Italia oggi.
Entrambe abitate a Roma e la definite «casa». Che cosa rappresenta per voi questa città?
JHUMPA LAHIRI — Roma mi ha chiamato e mi ha cambiato la vita. Ero fissata fin da bambina. La osservavo nei libri che prendevo in biblioteca, poi l’ho conosciuta meglio studiando. Infine, la prima volta che sono venuta qui, nel giro di pochissimo, ho capito che era il mio posto. Questo sentirmi a casa non l’avevo mai provato, perciò è preziosissimo e non ha niente a che fare con il mio passaporto, la mia identità, è una connessione che sento dentro. Ciò non vuol dire che Roma sia perfetta. È complessa, cangiante, ibrida, con un’anima sempre doppia. Nei Racconti romani ne restituisco un ritratto sfolgorante ma duro. In autunno usciranno in inglese e sarà interessante osservare la reazione nel mondo anglofono. Perché la visione all’estero di questa città è spesso stereotipata: un parco giochi con tanta storia e il sole, dove mangi, passeggi e te ne vai, senza un minimo di contatto con la realtà e la sofferenza.
IGIABA SCEGO — È vero, Roma è complessa, tentacolare, spesso anche raccontata male, ma nella mia vita io mi sono sentita romana prima ancora che italiana. E ancora adesso è forse l’unica identità che sento sicura. Non mi è mai stato difficile riconoscermi nel suo senso di eterno e di meraviglia, da subito è stata una seconda pelle. A differenza di Jhumpa, è la città in cui sono nata, non l’ho scelta. Però devo dire che non la lascio.




