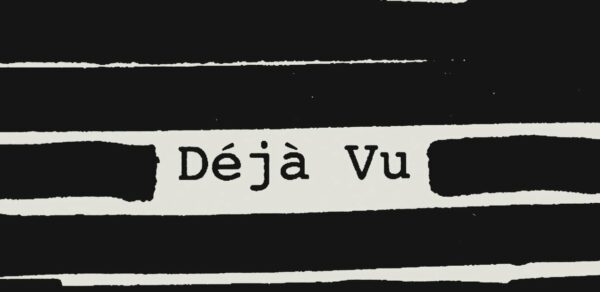di Paolo Lazzari
Quello sciabordio incessante si trascina appresso molto più che schiuma marina. I flutti restituiscono pezzi di lamiera rugginosa, frammenti di legno sbriciolati nello schianto, vestiti fradici e salvagenti improvvisati. Cumuli di oggetti che galleggiano sopra le increspature salate o si agganciano alla sabbia, come contenitori di storie colate a picco insieme alla speranza. Sono quelle che prova a raccontare, facendo la spola da tre anni tra la Toscana e Lampedusa, la viareggina Francesca Anichini, quarantasei anni, da venticinque archeologa. Di un genere forse inusuale per il sentore comune: lei e il suo team — è una ricercatrice del Mappa Lab dell’Università di Pisa — decodificano tracce contemporanee.
«È partito tutto dal mio progetto di dottorato, — racconta — che si basava sulla volontà di recuperare evidenze materiali delle migrazioni non documentate. Insieme ai colleghi Caterina Di Pasquale, Gabriele Gattiglia e Nicola Trabucco — un team multidisciplinare di archeologi, antropologi e documentaristi — abbiamo già classificato oltre duemila reperti».
Di progetti simili, nel mondo, se ne contano soltanto una manciata. Sono stati avviati lungo il muro di Tijuana, la barriera metallica che separa Messico e Usa. Nella allora “ Giungla di Calais”, prima del suo smantellamento. Sull’isola di Lesbo, per anni punto d’ingresso prediletto e sintomo del fallimento delle politiche migratorie dell’Ue, con ventimila persone stipate nel fango collinare, lontano dalla patina adagiata sulle pupille dei turisti. Storie diverse, stesse vite messe in stand by. Medesimi limbi artificiali.
E la prima percezione, anche a Lampedusa, è quella di un territorio di confine. Di una roccia di basalto poggiata sulla placca africana, lontanissima da Porto Empedocle, priva di ospedali, punteggiata da grovigli di filo spinato, cosparsa da una militarizzazione alla quale, spiega Anichini, è impossibile sottrarsi visivamente.
« Ma bisogna andarci per comprendere la situazione — prosegue — e per accorgersi che, salvo i momenti di tensione registrati di recente, non c’è proprio nessuna invasione. La gente del posto convive conquesti flussi da trent’anni. Tu scendi a Lampedusa e non incroci un solo migrante per giorni e giorni, perché vengono intercettati sulla banchina e, dopo gli screening sanitari, subito condotti verso gli hotspot. L’unica interazione pensabile è quella con gli oggetti che appartenevano a queste persone».
Così inizia una lunga ricognizione lungo spiagge, calette e scogliere, con un team di colleghi e studenti dell’Università di Pisa. I reperti vengono delimitati, spennellati e catalogati. Parti di stoffa, pezzi di plastica, legno e ferro che non riescono a raccontare ogni storia personale, ma trasmettono quella del viaggio collettivo. « È attraverso questi resti che realizzi il confine dentro al confine. La prima evidenza sono le imbarcazioni accatastate nel porticciolo. La maggior parte sono mezze affondate». Ed è qui che si raccolgono le primetestimonianze. «Se sono pescherecci, provengono dalla rotta libico — egiziana. Sono barche riciclate, spesso vecchissime, pensate per un viaggio one shot». Poi ci sono i natanti più piccoli, quelli che arrivano dalla Tunisia: « I trafficanti di esseri umani si sono dati da fare dopo che il presidente Saied ha dichiarato, lo scorso 23 febbraio, che la popolazione sub- sahariana non era più gradita. Hanno aumentato la produzione di barchette fatte in vetro- resina, pensate per otto persone al massimo. Ce ne caricano sopra cinquanta alla volta, chiedendo tra i 1400 ai 1700 euro a tratta. Se affondano, come è probabile, ci hanno comunque guadagnato molto ». Un fenomeno che è andato esasperandosi, fino a produrre gusci di lamiere saldate insieme, sottilissime trappole ferrose incapaci di solcare le onde. «Abbiamo ritrovato anche molti giubbotti di salvataggio che avevano la funzione opposta. Alcuni erano corpetti da equitazione. Altri erano ripieni di un tessuto simile alla spugna: chi li ha indossati è annegato».
E, ancora, plastica. Tantissima plastica: camere d’aria con annesse velleitarie pompette. Flaconi di detersivi e taniche legate alla vita con cordini di fortuna, nella speranza di non annegare. Tubetti di farmaci. Bottigliette piene di urina, l’ultimo liquido che resta da bere. « Poi ci sono le magliette, zuppe e rovesciate, di chi ce l’ha fatta. Alcuni le gettano una volta arrivati, per indossare un cambio che hanno fasciato dentro sacchi di plastica. Vogliono presentarsi con dignità».
All’opposto, giacciono le centinaia di corpi senza nome seppelliti nei cimiteri più vicini: « Anche le loro lapidi parlano e le associazioni del posto si danno da fare per capire chi fossero, per restituire lacrime e diritti ai loro cari». La spinta tellurica alla sopravvivenza, i corpi disidratati, i polmoni invasi dall’acqua e i sorrisi fragili di chi, stremato, ha toccato terra. Quante storie premute in quelle zattere vulnerabili. «Ognuno è libero di maturare il suo pensiero — conclude Francesca — ma è un fatto che gli oggetti ci raccontano vicende più complesse rispetto alla narrazione comune. Una volta scoperte, cercare di testimoniarle è necessario».