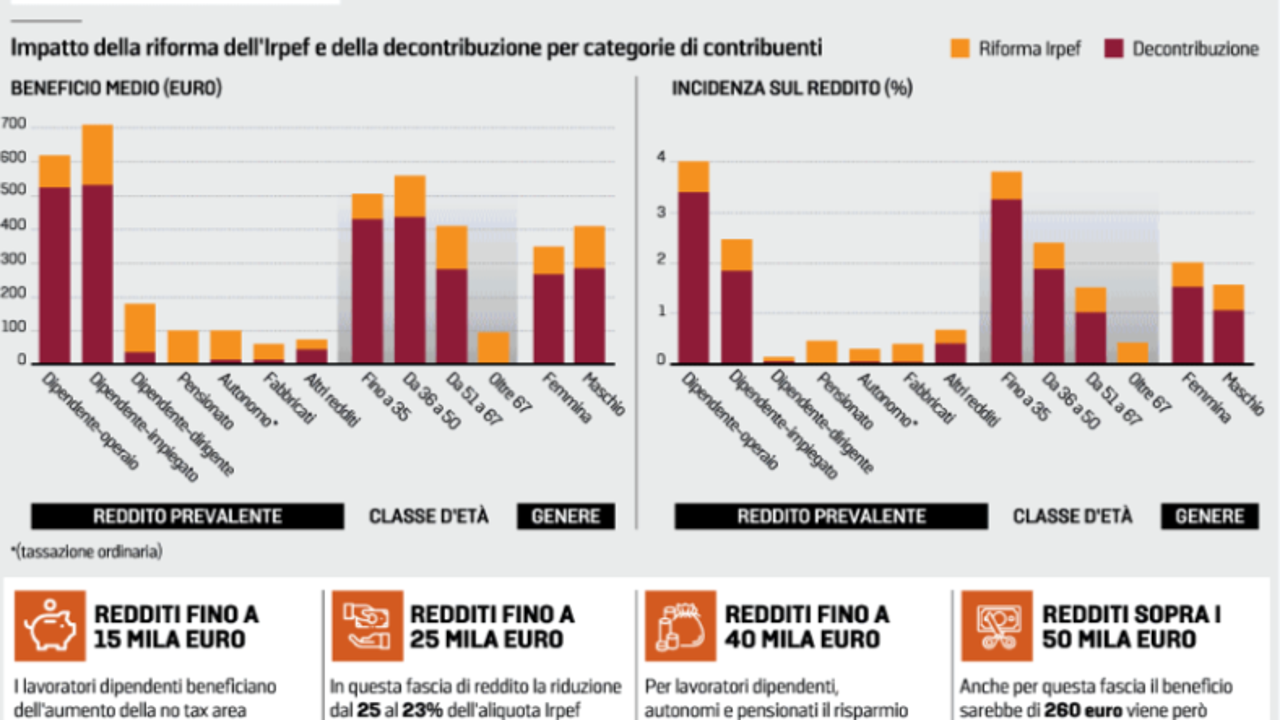Queste politiche riguardano soprattutto l’ambito fiscale – ossia le variazioni della spesa pubblica e/o della tassazione e, conseguentemente, del debito pubblico – mentre la politica monetaria dipende dalla Bce, istituzione indipendente dai governi dei singoli Paesi, con il compito tecnico di fornire al sistema una quantità giusta di moneta, che consenta il massimo sviluppo economico possibile senza inflazione.
La discussione riguarda, quindi, il grado di autonomia che il Patto di stabilità lascia alla politica fiscale, ossia la possibilità di aumentare la spesa pubblica o ridurre la tassazione, misure in sé espansive, rispetto a quanto il Paese avrebbe potuto ottenere con una più efficace conduzione della trattativa, che si è invece conclusa con un accordo tra Francia e Germania, al quale l’Italia ha aderito senza sostanzialmente contribuirvi. In particolare, la richiesta italiana di escludere dal disavanzo la spesa per investimenti è stata respinta, mentre soltanto una parte della spesa per interessi sarà deducibile, per i prossimi tre anni; poi bisognerà rientrare dal debito, sia pure con una dinamica meno severa di quella imposta ai tempi dell’austerità. In queste circostanze, sarà difficile, se non impossibile, trovare le risorse per la flat tax o per una controriforma pensionistica, peraltro entrambe inappropriate.
Ma perché l’Europa ci pone dei vincoli? In estrema sintesi, per il timore che nascano dubbi nei mercati sulla capacità di un Paese ad alto debito di onorare le proprie promesse di pagamento. Tali dubbi potrebbero condurre all’impossibilità di rinnovare il debito a scadenza o permettere di farlo soltanto a costi elevato e crescenti; il che, a sua volta, potrebbe determinare, attraverso il contagio, una crisi finanziaria complessiva, con effetti negativi sul sistema bancario (grande detentore di titoli pubblici), sul risparmio delle famiglie, e costringere a politiche molto restrittive.
Dire che l’Italia stia correndo questo rischio è certamente troppo; dire che possiamo ignorarlo è irresponsabile perché – come ha più volte ribadito il ministro Giorgetti – «il nostro problema è il debito pubblico» e, in particolare, la sua dimensione rispetto al Pil annuo, un rapporto oggi non lontano da 1,5 (quasi una volta e mezza il Pil). Nessuna teoria economica ha mai determinato una soglia massima per questo rapporto: gli indicatori economici non sono strumenti di precisione, e dunque un dato valore può essere superato senza necessariamente generare una crisi e, a parità di rapporto, un paese può essere considerato dai mercati finanziari in buona salute e un altro ad alto rischio. Perché questa diversità di diagnosi?
Qui entrano in scena altri due indicatori economici e il sentimento politico che, con le sue politiche, mantiene o riduce la fiducia dei mercati nel paese debitore. Per i primi, si tratta del tasso di interesse e del tasso di crescita del Pil. Se il secondo è superiore al primo si può tirare un respiro di sollievo perché la direzione di marcia è quella giusta e sostenibile: anche se non scende in valore assoluto, il debito cala in rapporto al valore della produzione, il che consente politiche espansive che, a loro volta, se ben indirizzate sorreggono la crescita. Quando, invece, il tasso di interesse supera il tasso di crescita del Pil (come sta succedendo oggi e come, secondo diverse previsioni, potrebbe continuare a succedere nei prossimi anni) il rapporto aumenta e, a meno di una correzione fiscale che riduca la spesa o aumenti la tassazione, la dinamica può rapidamente diventare insostenibile. Da qui nasce il rischio e la necessità di tenere il debito sotto controllo, come ha più volte sospirato Giorgetti, che di tale controllo porta sulle spalle la responsabilità, il che lo fa apparire ministro più tecnico che politico. Il nuovo Patto – un «compromesso ragionevole» secondo il ministro – recepisce queste preoccupazioni e impone un percorso di rientro dal debito più flessibile ma non su misura di ciascun Paese. Così il percorso per il nostro Paese non sarà agevole. La riforma del Mes, a sua volta, avrebbe rafforzato la dotazione di strumenti a disposizione per contrastare un’eventuale crisi, in particolare consentendo non soltanto il salvataggio di uno stato ma anche quello di singole banche. Non averla approvata – pure in presenza di un Patto di Stabilità che prevede percorsi abbastanza stringenti di riduzione del debito e quindi del rischio di crisi finanziaria – è prova di scarsa razionalità o, peggio, di manifestazione di ripicca per essere stati poco considerati da Francia e Germania nella fase di definizione del nuovo accordo. L’Italia si è comportata come un guidatore che, pur dovendo percorrere strade impervie, rifiuta la sicurezza dei rifornimenti e la polizza di assicurazione di soccorso in caso di bisogno. Le ragioni politiche, purtroppo, complicano le situazioni economiche con una intrinseca tendenza al deficit, nel presupposto che gli elettori preferiscano rinviare a domani il pagamento corretto di benefici che ottengono oggi dalla spesa pubblica (scuola, sanità, sicurezza ecc., per non parlare di bonus e superbonus). Domandarsi fino a quando potrà essere sostenuto l’inganno non è espressione di malaugurio ma doveroso senso di responsabilità, al quale la nostra classe politica sembra volersi sottrarre.