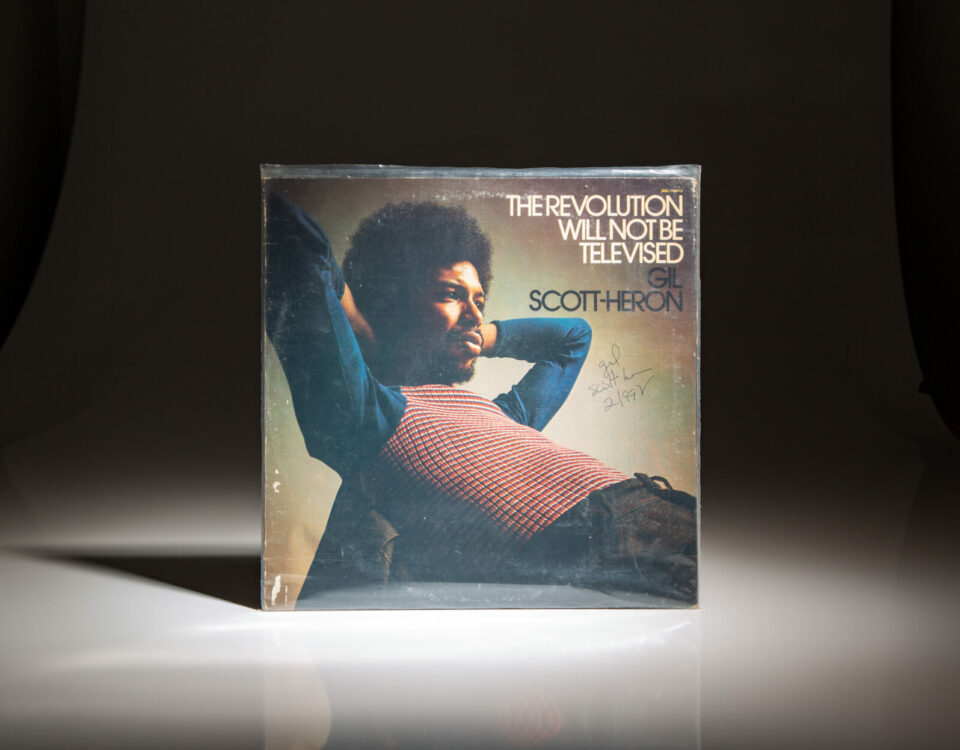Sezen Aksu – Begonvil
9 Gennaio 2024
Un augurio di buon lavoro
9 Gennaio 2024
di Sergio Locoratolo
“La cultura è presa di possesso della propria personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione della vita, i propri diritti, i propri doveri”. Chi, oltre cento anni fa, scriveva questa frase era certamente molto lontano dal tipo di società in cui, da contemporanei, siamo immersi.
Probabilmente il suo modello di riferimento sociale era più strutturato e certamente più definito, quanto a classificazioni e a categorie. Faceva i conti con molte certezze, a partire dalla politica e dalla religione, ma anche con molte chiusure, tipiche di aggregazioni ancora fragili, troppo distanti dalle successive esperienze delle democrazie europee postbelliche.
Ma la caratura morale di quella frase appare in tutta la sua pienezza anche oggi. A evidenziare che il ruolo e la funzione della cultura non può che essere di crescita civile. E che, nonostante si possa con buone ragioni parlare attualmente di una società sempre più individualizzata, in cui alle naturali tensioni all’autonomia e alla emancipazione dei singoli si aggiungono processi di deistituzionalizzazione e di desocializzazione, il tema della dimensione collettiva della cultura emerge con assoluta evidenza. Questo profilo deve essere ben presente quando si parla di politiche culturali pubbliche. Che per finalità e scopi si pongono in una logica completamente diversa rispetto all’agire dei privati.
E ciò per assumere anche una posizione chiara rispetto a quanto sovente si dice. Ovvero che il pubblico, promuovendo cultura spesso a costi minimi, se non azzerati, per i cittadini, attuerebbe una sorta di “concorrenza sleale” nei confronti di quanti, strutture private o anche a partecipazione pubblica, esercitano attività di impresa culturale producendo ricavi ma anche sopportando i costi della gestione.
L’osservazione appare infondata. Perché, e qui proprio a definire lo specifico ruolo della cultura promossa dal soggetto pubblico, diversi sono i destinatari finali e gli obiettivi dell’agire. Il denominatore comune è certamente la diffusione della conoscenza. Ma, mentre il privato si accolla l’onere e il rischio dell’impresa che esercita, al meno compensando e al più incamerando la differenza tra i costi e i ricavi, il pubblico persegue anche altre e distinte finalità. Che sono quelle di coltivare la coesione sociale, di limare e diminuire le disuguaglianze che impediscono a molti la possibilità di pagare perfino i biglietti dei teatri, dei cinema, dei concerti. Il soggetto pubblico deve poi perseguire l’innovazione sociale, la soddisfazione di bisogni immateriali che il mercato non può garantire, il rafforzamento delle relazioni sociali. Deve incoraggiare i processi di cambiamento e la realizzazione di politiche più eque e sostenibili, che riportino al centro le persone e la loro partecipazione alla vita delle comunità.
Ma spetta al pubblico anche affermare l’inclusione sociale, coinvolgendo nei processi di “creatività collettiva” tutti i cittadini, combattere gli squilibri territoriali, le disarmonie tra i luoghi. In tal senso, il disegno di città policentrica che si sta attuando a Napoli ne è viva rappresentazione. Basti pensare che, in città, nel 2023 per la prima volta gli eventi culturali che si sono svolti nelle zone periferiche hanno numericamente superato quelli svolti in centro. Tutto ciò, ovviamente, non significa rinunciare agli effetti economici della produzione culturale. Si pensi alla ricaduta eccezionale del sistema dell’audiovisivo o allo straordinario indotto sul territorio generato dalla programmazione del turismo musicale.
Anzi, economia e cultura sono legate più di quanto si pensi. E ciò tanto, ed è evidente, in positivo, per le ricadute di cui si diceva poco prima, ma anche sotto il profilo opposto. Povertà economica e povertà culturale sono spesso strettamente connesse e l’una e l’altra si rincorrono nel generare emarginazione. Si tratta, perciò, di intervenire per ridurre l’esclusione sociale, favorendo la più ampia e diffusa partecipazione ai contesti e ai contenuti culturali. E ciò implica anche la riduzione ai minimi termini delle difficoltà di accesso materiale ai luoghi della cultura, coinvolgendo nel processo di rigenerazione urbana, naturalmente connesso allo sviluppo culturale dei siti, anche i temi legati alla disabilità e al disagio. Difficoltà di accesso che possono essere superate anche con un procedimento inverso.
Ovvero, portando la cultura nei luoghi della sofferenza, della esclusione, della marginalità. Ospedali e carceri. E ovunque si viva il dolore. Quello è il luogo di elezione della cultura. È li che lo Stato deve essere. In primis, per una questione di consapevolezza del proprio ruolo, della propria funzione storica, civile e politica. Quella consapevolezza di cui parlava l’autore della frase di oltre cento anni fa, Antonio Gramsci.