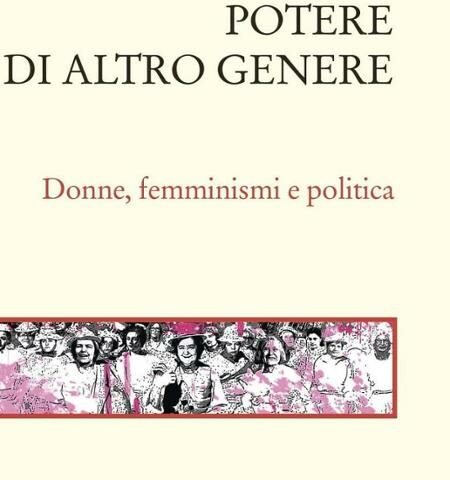Simonetta Sciandivasci
Un antico proverbio serbo dice che le donne hanno un problema per ogni soluzione. Nessuno meglio delle donne sa che il più grande generatore di problemi è il potere, anche quando risolve, soprattutto quando risolve. È come un medico: guarisce una malattia mentre ne trova un’altra, talvolta ne provoca una mentre ne cura un’altra.
Succede non tanto perché il potere logora chi ce l’ha (è più logorante non averlo), ma perché esso è il punto di inizio che tutti, o quasi tutti, rovesciano in punto d’arrivo. La metafora del Signore degli Anelli, opera assai cara alla cultura destrorsa, è questo che insegna: chi si infila l’anello del potere, lo accarezza, lo difende, lo guarda, lo ammira, lo venera, e difficilmente lo usa per altro scopo che non sia non perderlo, mantenerlo saldo al dito.
Quando l’ingresso delle donne in ruoli di vertice, comando, controllo, era soltanto un auspicio, si discuteva animatamente di come, una volta avvenuto quell’ingresso, le donne avrebbero cambiato tutto. Ci si divideva tra chi riteneva che le donne sarebbero state migliori perché di animo più nobile e/o incontaminato e chi, invece, riteneva che sarebbero state identiche, se non peggiori degli uomini, fintanto che si fossero limitate a esercitare il potere all’interno delle sue strutture convenzionali, essendo quelle strutture state pensate, realizzate e agite da uomini. Entrambe le ipotesi erano sostenute da una sottesa ma solida ingenuità: l’idea che il potere cambi a seconda di chi lo esercita. È stata quella ingenuità che ci ha fatto esultare quando Giorgia Meloni è diventata la prima presidente del Consiglio di questo Paese. Che ci ha fatto tifare per Hillary Clinton e ora per Kamala Harris (che per alcuni giorni è parso, in verità quasi solo nel dibattito italiano, potesse ambire a prendere il posto di Biden nella corsa alla Casa Bianca). Che ci fa tuttora palpitare di qualcosa che assomiglia all’orgoglio quando ci rendiamo conto che a dare forma all’Europa, come da copertina recente del Time, saranno Giorgia Meloni, Ursula von Der Leyen e Marine Le Pen (e gli ultimi risultati elettorali francesi, se pure la vedono sconfitta, non la rimuovono da questo triangolo, anzi). E poi c’è Elly Schlein, che ha risuscitato il Pd. E Angelina Mango, che ha vinto Sanremo. E Margherita Cassano, prima presidente della Cassazione. Tutti risultati personali, soprattutto nel caso di Giorgia Meloni, che però vogliamo leggere anche come risultati collettivi. La domanda che ci facevamo appena Meloni è stata eletta, e cioè se il suo fosse un risultato femminista, o almeno di tutte le donne, è quasi scomparsa dal dibattito pubblico. Eppure, ora ci sono tutti gli elementi per rispondere che, piuttosto indubitabilmente, l’elezione di Giorgia Meloni non è una vittoria delle donne, ma sua, e non ha portato vantaggi alle donne, non ha a che fare con il femminismo ed è, per restare nello spassoso paradigma del proverbio serbo, un problema generato da una soluzione. Non che nessuno avesse mai pensato che Meloni avrebbe risolto le questioni femminili, ma nemmeno, forse, che le avrebbe complicate.
In Potere di altro genere. Donne, femminismi e politica (Donzelli), Giorgia Serughetti scrive che «la crescita di protagonismo femminile non porta necessariamente con sé, come effetto automatico, una migliore rappresentazione delle esperienze plurali né degli interessi comuni delle donne; in alcuni casi può, contraddittoriamente, coincidere con l’affermarsi di idee e politiche contrarie ai diritti conquistati dall’attivismo femminista, in particolare quelli sessuali e riproduttivi». Una volta elette, le donne agiscono per conto o nell’interesse delle donne? Pur insistendo molto sulla sua identità di donna, cosa che le serve essenzialmente per tranquillizzare l’elettorato conservatore sulla sua impermeabilità alla fluidità e alla queerness, e sul non essere subalterna ai maschi – «Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?» -, Giorgia Meloni come anche Marine Le Pen e tutte le leader di destra, sottolinea Serughetti, intende il proprio ruolo come volto all’interesse generale, nazionale e non di genere, e infatti nel suo libro Io sono Giorgia, scrive: «Io non ho mai pensato che una donna debba fare politica per le donne, perché si fa politica per tutti, per il bene comune».
In sostanza Giorgia Meloni liquida, in apparenza risolvendolo ma di fatto disconoscendolo, il problema fondamentale della rappresentanza delle donne in politica, un problema che il femminismo, tra gli anni Sessanta e Settanta, ha evidenziato perfettamente: l’uguaglianza non risolve la questione della cittadinanza femminile, perché è il modello egualitario a essere il problema, dal momento che è modellato sugli uomini, e così alle donne non resta che subirlo oppure omologarcisi. L’omologazione è la strada intrapresa da Meloni, e non solo: è più che diffuso il voler accedere a tutto quello che gli uomini hanno avuto o hanno, e la trionfante dimostrazione che siamo capaci di conquistarlo anche stando alle regole maschili; le quote dalle quali non riusciamo ancora a svincolarci e che hanno però un enorme problema di fondo, ben evidenziato dalla giornalista Alessandra Sardoni quando, due anni fa, nell’incontro Il potere delle donne (recuperabile su Youtube), disse: «Le quote presuppongono una selezione fatta da uomini». Tutto questo, dice Serughetti, ci porta a «sacrificare al modello emancipativo il patrimonio di cultura, capacità, valori che provengono da, come scriveva Carla Lonzi, “millenni di assenza dalla Storia”». È piuttosto impressionante come la rivendicazione di quella diversità, del lusso del margine, si sia affievolita: ora che le donne sono arrivate in cima, è a quel margine che devono pensare e tornare, è di quel margine che devono sentirsi rappresentanti, e devono farlo per ideare modelli scaraventanti e non accomodanti, ribaltanti e non omologanti. Invece, il solo margine realmente magnificato e rivendicato è quello dell’underdog, dell’ex ostracizzato di estrema destra che ora usa le donne per mostrarsi ingentilito, secondo quel processo, soprattutto mediatico, che in Francia chiamano dédiabolisation.
Quello che la rappresentanza femminile in politica sembra, in larga parte, stia facendo in questo momento è de-demonizzare.
È assai evidente nella battaglia sul lavoro, quello dal quale le donne sono state le prime a cominciare a dimettersi, dichiarandolo incompatibile con una vita sana, giusta, dove l’equilibrio fra casa e ufficio fosse rispettato. Tuttavia, la radicalità delle grandi dimissioni, che sono state certamente un lusso che poche hanno potuto permettersi ma che hanno avuto il merito di sottolineare che, come scrive Irene Soave nello Statuto delle Lavoratrici, «le persone non vogliono o non possono più obbedire a regole di produttività, reperibilità, flessibilità, potere e gerarchia che attualmente informano la maggior parte dei nostri posti di lavoro», ecco, quella radicalità sembra essere confluita nella battaglia per salari migliori, paghe eque, abbattimento del soffitto di cristallo. Nella ridiscussione del lavoro, il tema predominante è quello economico. Il saggio di Azzurra Rinaldi, Come chiedere l’aumento. Strategie e pratiche per darti il giusto valore (Fabbri), è, come tutto il lavoro di Rinaldi, utilissimo per una rivendicazione che non può essere né precedente né successiva e deve bensì essere sinergica a quella di nuove condizioni, nuovi assetti, nuovi tempi. Cosa combattiamo a fare per un salario equo, se non miglioriamo il posto dove andiamo a guadagnarcelo? Ne La parità mancata. La lunga strada delle donne tra carriera e famiglia (Mondadori), Claudia Goldin, insignita l’anno scorso del Premio Nobel per l’Economia per i suoi studi sul gender gap, spiega che la ragione per la quale le donne continuano a guadagnare meno degli uomini non dipende da salari diversi (non succede quasi più che a parità di grado e mansioni un uomo venga pagato di più di una sua collega), ma dal fatto che le donne fanno meno carriera, rinunciano molto di più agli avanzamenti, alle promozioni, perché ogni nuovo tassello professionale ne debilita uno familiare. Succede perché il lavoro è diventato, scrive Goldin, “avido”: «Chi è disposto a fare straordinari, lavora nel fine settimana e la sera guadagnerà molto di più, così tanto di più che, anche volendolo calcolare su base oraria, il suo salario sarà più alto. Il valore dei lavori avidi è aumentato notevolmente con l’incremento della disuguaglianza di reddito, che è cresciuta in maniera esponenziale dai primi anni Ottanta. Le professioni caratterizzate da orari di lavoro virtualmente illimitati e flessibilità pressoché inesistenti, sono quelle che garantiscono un reddito di gran lunga migliore».
Ecco perché Meloni non può dire, come invece dice: «Non combatto la disoccupazione femminile in quanto semplice problema delle donne, ma in quanto questione nazionale». Ed ecco perché, forse, alle ultime elezioni, le donne hanno votato meno di tutti.
Nel suo In Metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire (Castelvecchi), Rosi Braidotti scrive che il soggetto del femminismo non è la donna «come alterità complementare e speculare dell’uomo, bensì un soggetto incarnato complesso e stratificato che ha preso distanza dall’istituzione della femminilità. “Lei” non coincide più con il riflesso privo di potere del soggetto dominante, che pone la mascolinità come universale. “Lei” è un soggetto in divenire, mutante». Questo soggetto politico mutante cosa chiede al potere che gli elettori consegnano, in molte parti del mondo, alle donne, oltre alla lotta contro la violenza di genere in tutte le sue forme (quella economica inclusa)? E perché, visto che è mutante, sembra aver smesso di esigere di “abitare la possibilità”, come diceva Emily Dickinson?
Barbara Alberti, nella postfazione alla nuova edizione del suo Vangelo secondo Maria (Bur), un libro degli anni Settanta in cui immaginava una Madonna che si sottraeva al destino assegnatole da Dio e Arcangelo Gabriele e scappava via, scrive: «Nella moltiplicazione dei compiti la libertà è ridiventata schiavitù, siamo sempre più lontane dall’invenzione del quotidiano. Coi maschi abbiamo raggiunto la parità nella volgarità, condividiamo una catastrofe spirituale. Il mondo non finirà mai perché le donne lo raccontano. Osare, testimoniare, resistere. Fuori dell’eresia non c’è libertà».
L’altro potere che abbiamo è quello di millenni di assenza dalla Storia: Carla Lonzi aveva ragione. È tempo di declinare quel potere, ricordandoci che «la cosa più stupefacente è che noi siamo parenti del niente» e siamo al mondo per vivere.