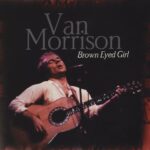Sono poco più di cento gli anni trascorsi dalla registrazione del primo disco di jazz. Era il 1917 e il cornettista bianco Dominic James «Nick» La Rocca, italoamericano di seconda generazione, lo incise per la Victor di New York cambiando la parola Jass in Jazz e datando così la nascita di un nuovo stile musicale. Oltre a lui, i protagonisti di allora erano il cornettista Joe Oliver e il trombonista Kid Ory ma soprattutto il bianco di origine tedesca Bix Beiderbecke e il discendente di schiavi africani Louis Armstrong.
Dovessimo invitare un amico a cena e raccontargli oggi cosa è il jazz potremmo mettere sul piatto (non a tavola) Satchmo e Bix assieme a Pat Metheny, Kamasi Washington, Brad Mehldau e Louis Cole ma sarebbe difficile spiegare cosa unisce questi straordinari artisti apparentemente così distanti.
Per comprendere quale è il legame bisognerebbe andare a ritroso ascoltando le opere di chi ha popolato e impreziosito la storia della musica afroamericana che sempre ha dimostrato di essere spugnosa e capace di scrutare nel presente.
Se i cicli di evoluzione della classica sono stati di decine di anni, quelli del jazz, ma anche del pop e rock, si evolvono con la impressionante velocità del presente captando i più minuscoli assestamenti tellurici del tempo moderno e legandosi ai molteplici movimenti culturali e politici che hanno mosso e scosso il secolo scorso.
Stupisce pertanto la ritrosia di alcuni all’accettare il cambiamento e al voler pensare che tale “stile” (posto che una parola di sole quattro lettere possa contenerne uno solo) sia morto con Parker e Coltrane senza ammettere che questa arte contemporanea incarna per antonomasia un cinetico movimento umano e raccoglie la spugnosa curiosità del meticcio.
Senza rischio di smentita si potrebbe affermare che il jazz sia stato, fino agli anni 80, una musica elitaria che veicolava un sound confortevole e riconoscibile, per certi versi borghese, seppure le vite dei suoi protagonisti fossero tutt’altro che lineari e piuttosto funestate dall’alcol e dalla droga.
È negli anni 90 che cambia pelle discostandosi gradualmente dalla matrice americana e trovando terreno fertile nelle varie e diversificate culture europee. Si delinea così una cifra stilistica originale che ingloba balli tradizionali e flamenco, musette e fado, canzone d’autore e arie barocche e si annuncia una nuova tendenza stilistica che riafferma la sua aspirazione popolare capace di parlare a tutti strizzando l’occhio alla cultura afroamericana ma piantando semi nel proprio terroir.
Era stato il ’68 a scuotere la società e, con essa, il jazz: ciò che porta alla nascita di kermesse come in Umbria e a Pescara, ad Antibes e a Montreux. Il pubblico cambia e il suono di sassofoni e trombe è alla portata delle nuove generazioni che si riconoscono in un sound di rottura al pari del rock di Jimi Hendrix e Carlos Santana. Proliferano i festival estivi e si svuotano le sale da concerto poco adatte alla fruizione di un nuovo suono che strattona il sistema e chiede sacchi a pelo in risposta al vestito buono del teatro cittadino.
Ma dove si colloca oggi il jazz e quale è la visione collettiva di questa musica? E, soprattutto, c’è una discussione in atto sulla sua identità?
Il dibattito, peraltro alquanto accesso, è sulle manifestazioni che programmano il pop che, a detta di molti, non ha non ha che fare con il jazz. Eppure il concerto di Sting con Gil Evans ad Umbria Jazz fu uno dei momenti più intensi di quegli anni e nei progetti di Peter Gabriel, Bon Iver o Kendrick Lamar il jazz è presente nei suoni e nel linguaggio come fu, per stare solo nel mondo anglosassone, con i Soft Machine, i King Crimson e i Nucleus del trombettista Ian Carr.
Un atteggiamento che non stupisce nel momento in cui lo stesso Davis, al ritorno dalla lunga malattia che lo tenne lontano dalle scene per diversi anni, venne criticato aspramente perché strizzava l’occhio al mercato e al pop con suoni acidi ed elettrici. Eppure nella sua musica il jazz era presente quanto il sound del suo strumento (parola di trombettista davisiano) era uguale a quello degli anni 50.
Ma forse ciò che più si criticava in Miles era il successo oltre che un’estetica che confliggeva con il bianco e nero delle immagini di William Claxton e uno stile di vita rocambolesco e tormentato che la star aveva abbandonato da decenni.
I musicisti che venivano in Europa vestivano elegantemente e suonavano in maniera stellare, ma dentro molti di loro covava un forte malessere che ha portato all’autodistruzione e all’annegamento nelle droghe o nell’alcol: Charlie Parker morì all’età di trentacinque anni e così è stato per il nostro Massimo Urbani. Altri transitarono nel tunnel ma fortunatamente riuscirono a uscirne. Ma parliamo di un’epoca trascorsa.
Il tempo è cambiato, molti musicisti sono vegani e bevono solo succhi di frutta e anche il jazz è profondamente cambiato. Difficile pertanto stabilire cosa sia questa creatura amorfa e di certo non lo si può definire dalla percentuale di swing o dal sound acustico che riporta ai club newyorkesi degli anni ruggenti.
Nei progetti di Theo Croker, Shabaka Hutchings e Svaneborg Kardyb c’è tutto questo seppure sia posto in una forma nuova come deve essere la musica di oggi. Soprattutto c’è una memoria stratificata che raccoglie il passato per consegnarlo al futuro e sono certo che Gillespie, Monk e Mingus sarebbero felici di sapere che il loro seme è stato bene innaffiato ed oggi innestato in una nuova pianta.
Se si è concluso il tempo delle orde di ragazze e ragazzi che partecipavano ai festival e dobbiamo chiederci perché è accaduto e come si possa costruire un nuovo pubblico attraverso proposte innovative e una programmazione più coraggiosa.
Perché i nuovi linguaggi guardano altrove ammiccando all’elettronica e al rap, all’acustico raffinato e di ricerca e alla canzone ma, soprattutto, creando ponti con altri mondi sonori e tessendo innovative relazioni con altrettanti idiomi artistici.
Mi domando se la mancanza di interesse da parte dei giovani non derivi anche da una problematica insita del tessuto culturale del Paese e nella scuola, alla quale contribuisce il bombardamento mediatico della televisione generalista (che passa il jazz di rado e ad orari improbabili) e non posso non sottolineare invece l’interesse e la vitalità dei paesi dell’Est e della Spagna dove accorrono numerosi perché amano le musiche di ricerca e di contaminazione.
Di certo il jazz continua ad essere un suono vivo che, più di altri, fotografa il presente.
Ne sono la prova i tanti junior (la lista risulterebbe infinita) che, in tutto il mondo, hanno abbattuto le barriere storiche e geografiche per fare della musica senza confini il luogo degli incontri e degli scontri che si sporca le mani con linguaggi dei movimenti giovanili che spesso provengono dai sobborghi delle grandi metropoli.
Le correnti sono quelle dell’Hip Hop, NeoSoul, Chillout, Dancehall, Jungle, Triphop, Amb, R&B, Lounge e che contengono al loro interno tutto ciò che il jazz ha respirato e trasmesso.
Non parlano di ciò che “è” ma di ciò che “si è” dando una concreta risposta al tema identitario che fa dell’idioma jazzistico un linguaggio d’arte che risponde ai loro bisogni offrendo un veicolo ai viaggi della loro mente.
Una transumanza generazionale simile a quella del Sud degli Stati Uniti quando le falde culturali africana ed europea si toccarono per dare vita a un nuovo stile che cambiò il corso del Novecento.
È forse questo melting pot la possibile risposta per chi vorrebbe mettere il jazz di oggi in un luogo morto?