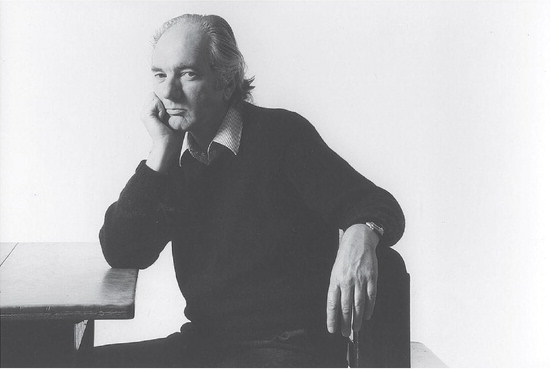«Quaderni piacentini», una storica rivista come laboratorio politico
16 Febbraio 2025
Orizzonte scarso, medietà suprema
16 Febbraio 2025LETTERATURA
Nella finzione ribolle il dramma autobiografico come in Gombrowicz, Canetti e Sebald Autori saliti alla ribalta dopo la fine della contrapposizione tra avanguardia e tradizione.
Torna il romanzo “Correzione” flusso magmatico in cui l’austriaco fa i conti con le ossessioni di uno scienziato e con Wittgenstein
Ora che il Novecento è definitivamente alle nostre spalle, anche le tradizionali contrapposizioni concettuali che lo hanno caratterizzato sembrano non funzionare più, implodere col secolo stesso, a cominciare da quella tra avanguardia e tradizione: troppo semplicistica per dar conto, nei modi d’una facile filosofia del progresso, della complessità dei tempi. L’effetto, quanto alla ridefinizione delle gerarchie letterarie, è stato benefico, se è vero che hanno potuto guadagnare il centro della scena scrittori di difficile classificazione, di certo non integralmente sperimentali relativamente alla lingua, epperò portatori originalissimi di visioni del mondo in felice sintonia con la loro drammatica contemporaneità. Mi riferisco – secondo l’ordine anagrafico – a Witold Gombrowicz, Elias Canetti, Thomas Bernhard e Winfried Georg Maximilian Sebald. Che cosa unisce questi scrittori, pur nella grande diversità? Senz’altro la disposizione autobiografica, poco importa quanto sia alto il grado di finzione delle loro pagine. Mi viene da ricordare un volume bellissimo apparso per Adelphi quasi quindici anni fa, Autobiografia, che raccoglie per la cura di Luigi Reitani i cinque libri autobiografici ove Bernhard, fra il 1975 e il 1982, sottopone la propria vita a un vero e proprio scuoiamento: L’origine, La cantina, Il respiro, Il freddo, Un bambino.
In quel plurale e struggente romanzo familiare – per un mate-riale che, allo stato grezzo, sarebbe utilissimo a uno psicanalista venivano restituiti i momenti di un’infanzia e un’adolescenza devastate dalla guerra; il sentimento d’una città, Vienna, intensamente patita, ma come accade per le grandi delusioni amorose («Vienna la odio,
ma Vienna è commovente»); la descrizione di istituzioni di vocazione concentrazionaria più che educativa o sanitaria, come i convitti austriaci e tedeschi o l’inquietante «trapassatoio » del sanatorio (per chi arriva allo stadio terminale), che lo scrittore, per esservi stato ricoverato, conosceva bene. Oltre, ovviamente, a una serie di straordinari ritratti, per così dire, da vicino. Cito da Il respiro: «Mia madre era stata una persona musicale». Che è la frase con cui Bernhard ci introduce al racconto di quel «martirio danzante» cui il nonno, ambizioso e melomane, sottopose la figlia. Se, tra gli scrittori sopra citati, mi sono riferito al solo Bernhard, ciò si deve al fatto che ho avuto tra le mani – approdato di nuovo in libreria – quello che viene considerato, e non solo dalla critica, il suo capolavoro: Correzione (Adelphi, pagine 292, euro 20,00), pubblicato per la prima volta nel 1975.
Cominciamo da qui, dando per inteso che è quasi impossibile isolare una citazione compiuta nel magma ipnotico della prosa dello scrittore, percussiva e dilagante com’è, eppure sempre rigorosamente circostanziata: «Nella soffitta di Höller, in cui adesso mi ero trasferito con gli scritti di Roithamer, in gran parte relativi alla costruzione del cono, dovetti convenire che occuparmi di Roithamer e delle sue opere postume dopo la mia lunga malattia era addirittura una terapia ideale, sentivo proprio che questo lavoro era l’ideale». Si aggiungerà solo che quel cono – perfetto come lo sono le utopie, progettato per la sorella, «da lui amata come nessun altro», «in tre anni di ininterrotto lavoro intellettuale e costruito nei tre anni seguenti» al centro della foresta di Kobernaus serwald – era stato concepito da Roithamer proprio in quella soffitta, là dove ora si trovavano tutti i suoi documenti. Come si vede, sono tre i personaggi fondamentali sui quali Bernhard concentra la sua narrazione: l’anonimo narratore, che, guarito, ritorna in Austria per dedicarsi agli scritti del suo amico d’infanzia Roithamer, suicida poco dopo la morte della sorella; Höller, un imbalsamatore figlio di imbalsamatore; e infine Roithamer, docente di scienze naturali a Cambridge proprio come Ludwig Wittgenstein, cui il personaggio sembra ispirato. Figura centrale, per Bernhard, quella del filosofo viennese, come testimonia del resto il romanzo Il nipote di Wittgenstein. Un’amicizia (1982), là dove l’amicizia in questione è quella con Paul Wittgenstein. Occorrerà aggiungere che il romanzo è diviso in due parti: La soffitta di Höller, appunto, ed Esaminare e riordinare.
L’orizzonte della scrittura di Bernhard si apre sin da subito a quella glaciazione antropologica che ritroviamo già allusa nel titolo del suo stupefacente romanzo d’esordio, Gelo (1963), imperniato sulla figura psicotica del pittore Strauch e ambientato in un paesaggio cupo e desolato da finis terrae. Una glaciazione che, mentre si pone in una prospettiva di stremato realismo, sul baratro d’un arreso e disperato nichilismo, si prova però a riconfigurare il dato nudamente refertuale in direzione – dopo Kafka, Eliot e Caproni – del simbolo. Il titolo stesso del romanzo, Correzione, ha a che fare con l’aspirazione alla perfezione di Roithamer, col desiderio di concentrazione assoluta, con l’ossessione di emendare di continuo il proprio testo. Si tratta d’una sontuosa logomachia in cui il pensiero, pur consapevole della sua inanità, continua a sfidare una realtà sempre sovrastante. Non sfuggirà il fatto cha l’«insonnia » affligga i personaggi. Fatto inquietante (e assai emblematico), se è vero che proprio «di notte tutto è mostruoso». Ecco il punto: «Per quanto un fatto sia insignificante, di notte è mostruoso».