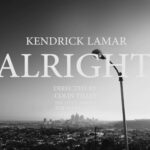Raccolte in volume le storie per il cinema della grande sceneggiatrice Una voce di donna che cambiò per sempre un mondo tutto maschile
di FRANCESCO PICCOLO
Suso ha cominciato a scrivere sceneggiature quasi per caso, come succedeva di frequente. Traduceva testi per editori e per il teatro, spesso a quattro mani con suo padre Emilio Cecchi; e a un certo punto ha cominciato a scrivere un copione su richiesta del produttore Carlo Ponti, dal titolo incredibilmente profetico per la storia del cinema, Avatar , insieme ad altre tre persone: il regista Renato Castellani, amico di Suso e di suo marito; e poi Alberto Moravia ed Ennio Flaiano. Essendo un lavoro, essendo retribuito, non esitò nemmeno un istante ad accettare. Quella sceneggiatura non arrivò da nessuna parte, ma Suso si divertì e appassionò al tempo stesso, non ebbe (come non ha avuto mai) l’atteggiamento di chi passa per la riunione e se ne va, al contrario si incaponiva, prendeva appunti e cercava soluzioni. E così si è trovata quasi subito di fronte alla domanda se questo sarebbe stato il suo mestiere. Ha deciso di sì piuttosto in fretta, si è messa a studiare un manuale della sceneggiatrice di Cecil B. DeMille, Jeanie MacPherson, che si era fatto spedire dagli Stati Uniti, e poi, come ha raccontato, si è messa a studiare anche la scaletta di un film che aveva visto: «Avevo letto in passato molte sceneggiature, di cui non avevo però mai analizzato la struttura. Ho ritrovato in un quaderno di quel tempo la scaletta che mi ricostruii de L’orgoglio degli Amberson , per studiare la costruzione di quella sceneggiatura. Vidi più di una volta i primi due film alle sceneggiature dei quali avevo partecipato per capire sbagli e meriti di cui incominciavo a condividere le responsabilità. Venni così sempre più convincendomi che, come scrive il mio collega Carrière, la sceneggiatura è il bozzolo, e il film la farfalla. Il bozzolo ha già in sé il film, ma è uno stato transitorio destinato a trasformarsi e a sparire. Lo sceneggiatore deve quindi impadronirsi al meglio della materia da trattare, e lavorarci poi con il regista evitando il pericolo di fare letteratura. Lo sceneggiatore non è uno scrittore; è un cineasta e, come tale, non deve rincorrere le parole, bensì le immagini. Deve scrivere con gli occhi».
Intanto però il lavoro incalzava da subito, e lei scrisse a suo marito Fedele, che era in un ospedale in Svizzera a curare la tubercolosi: «mi sa che sto diventando brava». Aveva superato i trent’anni, e con l’inconsapevolezza della vita nell’immediato dopoguerra, scriveva uno dietro l’altro copioni che in seguito sarebbero diventati film da storia del cinema. Lo faceva con la stessa predisposizione che aveva avuto i primi giorni, e che ha conservato fino all’ultimo: un’infinità di riunioni insieme ad altri, a volte tanti; la testa calata sugli appunti che ogni tanto prendeva per fermare le cose buone delle chiacchiere.
Quasi subito, quando ha cominciato a fare il mestiere della sceneggiatrice, ha messo a disposizione il salotto della sua casa di via Paisiello, dove ancora adesso ci sono i divani e le sedie dove si sedevano Visconti, Flaiano, Monicelli, Scarpelli, Antonioni, Blasetti, Medioli, Moravia… È un luogo sacro, ma tutti lo trattano come se non lo fosse. Nella stanza accanto adesso ci sono i cassettoni con il suo archivio, da cui abbiamo tirato fuori questa antologia. Questa quindi è la casa delle riunioni di sceneggiatura.
«Le riunioni si svolgono di solito sempre nello stesso ambiente: ci piace restare nello stesso posto, occupando anche le stesse sedie. Quando una medesima formazione si ritrova a distanza di anni per lavorare a un’altra sceneggiatura (mi succede con Leo Benvenuti e Piero De Bernardi) scambiati i saluti di rito ognuno torna ad accartocciarsinella sua poltrona, e se qualcun altro ci si è intanto accampato viene fatto sloggiare senza pietà».
Masolino, il suo figlio maggiore, racconta che quando erano piccoli, se il padre lavorava non si poteva disturbare (Fedele era musicologo), «mentre mamma sì, entravamo chiunque ci fosse e si mettevano a giocare con noi…».Questo è il mestiere che faceva Suso. È come se fosse il mestiere della confusione, del chiasso, della concentrazione in mezzo agli altri. E dentro questa confusione, bisogna trarre sostanzao, meglio ancora: concretezza. Di conseguenza, aver avuto l’idea di fare l’antologia di una sceneggiatrice potrebbe sembrare una pazzia. Come scorporare il lavoro di Suso da quello degli altri? Con quale algoritmo, operazione logica o aritmetica? Se pure fosse un compito, sarebbe difficile smarcarla per distinguerla da tutto il resto dei compagni di lavoro e dei loro modi di lavorare. Ma proprio per questo bisogna rinunciare a districare i fili, riuscendo a fondare un’idea di autorialità della sceneggiatura che non è l’idea di individuare (come ingenuamente molti cercano di fare quando vanno a cercare la mano degli sceneggiatori) dov’è la mano di Suso, ma è al contrario quella di accettare l’autorialità di un singolo dentro il lavoro collettivo.
Quindi, in realtà, l’intento vero di questo libro è opposto: non mira affatto a slegare Suso dalla scrittura collettiva, bensì a dare luce al suo lavoro dentro la scrittura collettiva.
Il malinteso sullo sceneggiatore è proprio questo, secondo il mio parere: che per dargli dignità autoriale, si ritiene di dover risalire al suo contributo visibile, al netto degli altri. Non credo sia così. Credo molto a un’autorialità di secondo grado della sceneggiatura — e cioè credo assolutamente che la sceneggiatura abbia dignità d’autore completa, complessa e specifica. Ma allo stesso tempo la ritengo di grado secondo per il semplice fatto che alla fine di una sceneggiatura è ancora tutto da fare e quindi lo specifico filmico ancora tutto da costruire: è ancora in gioco una percentuale enorme del possibile valore dell’opera. È il bozzolo, appunto, non è ancora la farfalla.