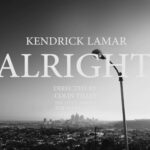
Kendrick Lamar – Alright
29 Aprile 2025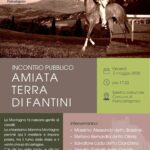
AMIATA TERRA DI FANTINI
29 Aprile 2025Il documentario Il regista fiorentino Francesco Tomè ne «La Restanza» ha raccolto le voci di chi ha scelto di vivere ad alta quota. Ma con note dolenti: assenza di servizi e istituzioni lontane
di Caterina Ruggi D’Aragona
Un atto d’amore verso la propria terra, verso la natura, verso luoghi che non si scambierebbero per niente al mondo. Una scelta consapevole, che si rinnova di giorno in giorno superando le difficoltà, e si rafforza contemplando un panorama o ascoltando i rumori del silenzio. C’è tutto questo dentro la parola «restanza» che, secondo la Treccani, indica «in senso proprio e figurato, ciò che resta e permane; anche, ciò che avanza o non si consuma». Termine che è stata utilizzato soprattutto per descrivere il fenomeno antropologico di chi ha scelto di restare a vivere nel Sud d’Italia, non per rassegnazione, ma con un atteggiamento propositivo.
La prospettiva resta la stessa seppure cambiano le coordinate geografiche, spostandosi in alta quota, in altre zone difficili e incantevoli al tempo stesso. Raccoglie racconti di vita tra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano il documentario La Restanza — Storie di montagna tra Toscana e Emilia di Francesco Tomè, che viene presentato lunedì 12 (ore 21) al Cinema Astra di Firenze in un incontro promosso dal Cai Firenze a cui interverranno l’antropologo Paolo de Simonis e dell’urbanista Carlo Natali, oltre al giovane regista, di rientro da una trasferta sulle sponde del Lago Maggiore per documentare l’apertura del Cammino del Lago Maggiore, nuovo itinerario ad anello lungo 240 chilometri che abbraccia Lombardia, Piemonte e Svizzera. «Un progetto completato da un gruppo di ragazzi che hanno scelto di abitare lì. In questo senso, il mio prossimo documentario ha un filo rosso di collegamento con La Restanza , in cui racconto storie di uomini e donne, giovani e anziani, che hanno deciso di rimanere sulle montagne tosco-emiliane, o hanno scelto di lasciare le città per trasferirsi lì», spiega Francesco Tomè, 25enne di Bagno a Ripoli.
La Restanza è stato il suo progetto di tesi per la laurea magistrale all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove ora sta facendo la specialistica in Cinema e Video. «La lettura del libro La restanza di Vito Teti si è incastrata con il mio amore per le montagne toscane, che frequento fin da quando mi ci portava mio padre nello zaino, e con la curiosità che da sempre nutro verso le storie di chi ci abita», racconta Francesco Tomè. Primo tra tutti, in ordine di apparizione, Andrea Conti, pastore 35enne di Resceto (Massa Carrara), che da oltre venti anni cura gli animali ricevuti in eredità dal nonno. «Tanta gente le scambia per macchine da guerra. Invece hanno un cuore, hanno un’anima anche loro», dice lui presentando le pecore nere massesi, una razza locale, da lui lasciata a una gestione semi-brada. Una scelta che riflette uno stile di vita rispettoso dei tempi e dei limiti della natura. «Andrea vive a Resceto con la moglie, che tutti i giorni scende a valle a portare i figli a scuola. Non nasconde le difficoltà, determinate non tanto dalla fatica fisica (che anzi a fine giornata appaga) quanto dall’assenza di supporto da parte delle istituzioni locali», riferisce il regista. «Nessuno di noi dovrebbe ritrovarsi a elemosinare aiuti. Dal mio punto di vista — dice Andrea nel documentario — dovrebbero esserci politiche in sostegno degli allevatori che, senza reddito da altre attività, hanno scelto di restare in posti “scabrosi”». L’estrazione del marmo non è percepita come ricchezza da Andrea, e neppure da Mauro Tavoni, 63 anni, che gestisce il rifugio Il puntato a Stazzema, dove si arriva solo a piedi. «Siamo nell’alpeggio più grande delle Alpi Apuane: non ci sono strade e speriamo che non ci saranno mai. In una società frenetica in cui devi sempre correre un posto incantato come questo ha una ricchezza umana da preservare». Mauro, che viene da Marina di Massa, ha scoperto quel rifugio durante le scorribande scanzonate di gioventù, e assieme agli amici ha impiegato sei anni per rimetterlo in piedi, portando a piedi per il sentiero sacchi di calce e di cemento. «Avevo 24 anni quando ho deciso di vivere qui, e non potrei essere più felice di così», dice Mauro spiegando che chi arriva al Puntato, dopo un’ora e mezzo di sentiero Cai, ha il cervello predisposto all’ascolto e al dialogo. Un potenziale di ricchezza da riscoprire. Come quello di un silenzio frequentato dal canto degli uccellini e dal fruscio delle foglie.
Le dolenti note sono comuni a tutti gli intervistati: assenza di servizi e latitanza delle istituzioni. La signora Franca, a Monteacuto delle Alpi, confessa che tutti i mercoledì prende il bus per scendere a valle, anche quando non ne ha necessità. «Sennò nessuno lo prende più ci tolgono il servizio», spiega. Il documentario, così come l’omonimo libro fotografico in uscita a maggio con la Libreria Editrice Fiorentina, raccoglie storie di pastori, agricoltori, artigiani, e perfino di chi una formatrice che ha scelto lo smartworking per rispondere al richiamo della montagna. Non una resa; ma una scelta che — sottolinea il regista — è proiettata verso il futuro.




