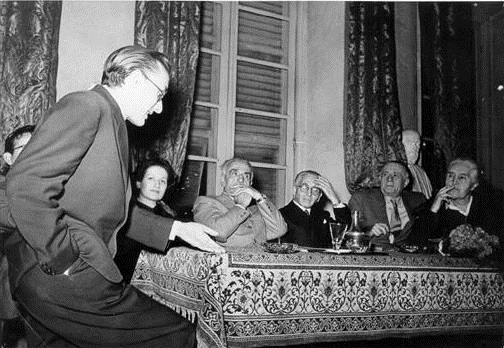La disfida Bobbio-Togliatti
11 Luglio 2025
I luoghi del rito. Dallo spazio alla presenza
11 Luglio 2025«Vien fatto di credere che non ci sia alcuno che, dotato di un minimo di sensibilità e giudizio, non si accorga o almeno sospetti che noi, oggi, viviamo veramente in un’epoca meravigliosa». Così Galvano della Volpe nell’articolo L’azione e il pensiero apparso su «Primato» il primo ottobre del 1940, l’Italia da quattro mesi in guerra a fianco del Terzo Reich.
«La realtà rivoluzionaria in cui ci muoviamo è di una tale intensità e profondità ideale», continua Della Volpe, «da superare, forse, le più orgogliose previsioni, anche dello stesso popolo che, nell’azione, è consapevole, e perciò filosofo, in grado estremo: il tedesco, naturalmente».
L’«operazione chirurgica in corso sulle istituzioni e costumi borghesi» ovvero la guerra promossa da Hitler, Führer «consapevole, e perciò filosofo» che, sostiene della Volpe, «si annuncia talmente profonda e radicale che, andando oltre gli obiettivi politici e sociali in se stessi, investe la generale visione della vita, rovesciando addirittura le concezioni filosofiche tradizionali, nel loro insieme».
In primo luogo, a livello filosofico, si impone tassativa, nell’opera di rovesciamento delle istituzioni e dei costumi borghesi, l’assunzione d’un’articolarsi nuovo del rapporto tra pensiero e azione. Sta qui, nell’attuale situazione storica, secondo della Volpe, la «prova eccezionale delle interferenze vitali dell’azione col pensiero (anche il più astratto), della politica, diciamo pure, con la filosofia, contrariamente a quanto è abituale credere».
Tale la meravigliosa «realtà rivoluzionaria» in atto nell’Europa che, avverte della Volpe, «porta seco la scoperta di nuovi problemi per i tecnici del sapere in genere, e di quello filosofico (cioè più generale) in ispecie».
Un compito che, tuttavia, i filosofi sono chiamati a svolgere in punto di teoria quando siano pienamente consapevoli della ‘lezione filosofica’ che viene loro impartita dagli «uomini di azione o comunque vivamente partecipi della realtà che si svolge sotto i nostri occhi», come si legge in I ‘chierici’ e la storia, ancora su «Primato», il primo luglio del 1940, allorché della Volpe confessa «mi è difficile esprimere tutto il senso di fastidio e spesso di disgusto che suscita in me la maggior parte degli scritti tecnici di filosofia (la filosofia dei ‘competenti’ o ‘specialisti’) in cui si tratti della storia e della realtà umana nel suo complesso, oggi, in un momento in cui si fa, per eccellenza, della storia». E prosegue: «Quanta sensibilità umana, quanta filosofia, sia pure non esplicita, quanta saggezza, nella prosa passionale di questi ‘laici’: osservatori politici, cronisti, giornalisti, cui mi rivolgo proprio per colmare il senso di vuoto e di triste fastidio che mi lasciano le pagine dei ‘chierici’, dei professori con o senza cattedra».
Della Volpe, a esplicitare il suo convincimento (e il suo ‘fastidio’ e il ‘disgusto’) fornisce al lettore un esempio scelto «a caso», dice. Chiede: «Chi più sollecito veramente della serietà della storia, delle sue ragioni profonde: quei filosofi storicisti che si sbarazzano della Germania di Hitler additando in essa il regno trionfante della ‘bruta vitalità’ che ‘vuol sopraffare e sostituire lo spirito’ – o non piuttosto quello scrittore politico che scrisse sul suo giornale, in occasione del suicidio del capitano della Von Spee, che, se la redenzione è un ‘problema’, la croce, cioè il sacrificio, l’eroico sacrificio, è ‘verità’, l’unica verità?». (Il comandante della Admiral Graf Spee Hans Langsdorff si suicida in una stanza d’albergo di Buenos Aires il 19 dicembre 1939, dopo l’autoaffondamento della corazzata da lui deciso ed effettuato il 17 dicembre).
Infine della Volpe consente poi con Camillo Pellizzi che, ricordando l’Elogio della pazzia di Erasmo, scrive: «il vecchio Erasmo era troppo italianizzato e troppo umanista per non essere un tantino in malafede» giacché, nell’esaltare la Pazzia, «par dire: vedete come io son savio!», mentre, continua Pellizzi, «sembra venuto, oggi, il momento della pazzia vera, che è furore e sterminio, quella che forse Erasmo non sospettava e che è il segreto e la forza stessa del vivere, e che riprende sede e fortuna presso di noi».