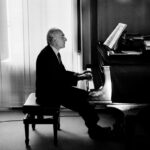di Joshua Evangelista
Incontriamo Ekaterina Schulmann in un albergo della periferia milanese. Per ascoltare la sua lezione a teatro, il giorno prima centinaia di persone hanno speso l’equivalente del biglietto di una rockstar internazionale. Sono arrivati da tutta Italia e oltre, qualcuno anche da Spagna, Praga e Varsavia. Tutti russi in esilio, in cerca di una lingua comune per orientarsi nel disastro politico del proprio Paese. Ossessionati dai video di questa professoressa severa ma ironica che senza mai arringare spiega anche i più complicati concetti della politologia di ieri e di oggi. Un milione di follower su YouTube, sempre in tour nei teatri e nelle università di mezzo mondo, a qualcuno della diaspora fa storcere il naso questo racconto pop delle disgrazie russe. A Mosca, invece, il suo nome è ormai nei registri del Ministero degli Interni: “agente straniero”, su di lei c’è un mandato di cattura. Oggi si divide tra l’insegnamento a Berlino e la divulgazione online e a teatro.
La Russia oggi è uno Stato totalitario?
«Dobbiamo fare una premessa. Democrazia e totalitarismo hanno un elemento in comune: entrambi si basano sul coinvolgimento dei cittadini. Il coinvolgimento democratico è, ovviamente, volontario, diversificato e competitivo: ai cittadini è chiesto di interessarsi agli affari pubblici, votare, candidarsi, esprimersi pubblicamente. Nel totalitarismo, invece, il coinvolgimento è obbligatorio e monopolizzato: esiste un solo partito al quale devi aderire e per il quale devi marciare, cantare, dimostrare lealtà. Migliorare la propria comunità o organizzare un pogrom sono entrambe forme di azione collettiva. Quindi, se una società democratica si sposta verso il totalitarismo, è come iniettare veleno nella sua circolazione sanguigna: la trasformazione è rapida e letale. Non è così per le autocrazie».
Perché?
«Perché esse, al contrario, si basano sull’apatia, sulla depoliticizzazione, sull’assenza di cittadini coinvolti. Ecco perché tutte le autocrazie sono diffidenti verso l’iniziativa civica».
È quello che succede in Russia?
«I russi amano pensarsi come unici, nella grandezza e nella disgrazia, ma questo è narcisismo. In realtà hanno un modello politico che è il più primitivo tra le autocrazie: quello personalistico. C’è un leader e il suo entourage che controlla le risorse dalle quali si arricchisce. Distribuisce parte di queste ricchezze per mantenere la popolazione docile e paga esercito e servizi di sicurezza per controllarla».
Ma concretamente cosa cambia, in termini di repressione?
«In un’autocrazia, ti reprimono per quel che hai fatto, o per quel che dicono tu abbia fatto. La repressione totalitaria mira all’annientamento. Ti uccidono per quel che sei. E se non corrispondi, perché sei ebreo o rom, o qualsiasi altra cosa, devi sparire. Nella politica russa contemporanea, l’esempio più vicino alla repressione totalitaria è quella verso le persone LGBT. Per il resto, non abbiamo un’ideologia ufficiale, non abbiamo confini chiusi. Anzi, il governo incoraggia l’emigrazione. I partiti totalitari permeano ogni strato della società cercando engagement. Il governo russo, al contrario, odia l’entusiasmo».
Ci faccia un esempio.
«Coloro che nel 2014 furono ingaggiati per portare avanti le prime azioni pro-Russia nell’Ucraina orientale: quasi nessuno di loro è ancora vivo. I cosiddetti “z” blogger e corrispondenti militari filo-russi vengono uccisi non da forze ucraine, ma da attori interni come il gruppo Wagner. Quello che sorprende è che non c’è stata nessuna trasformazione di regime in Russia. Il funzionamento del potere è lo stesso di prima».
È stato sempre così, dal crollo dell’Unione Sovietica?
«No. Prima eravamo una democrazia debole e ancora oggi conserviamo qualche vestigia di competizione elettorale, soprattutto a livello municipale dove, pur con un partito dominante, si vede qualche forma di competizione tra i candidati per i seggi rimanenti. Ma dal 2012 in poi non c’è stata più competizione interna per il potere supremo».
Qual è stato il punto di svolta?
«La reazione violenta del regime alle proteste del 2011-2012. Ma questi modelli primitivi hanno un difetto: firmi un contratto con il diavolo, ti dà tutto, ma alla fine il perno su cui si regge il sistema si rompe».
Come?
«Le élite sono sotto attacco. Dopo le presidenziali del 2024, le repressioni sono aumentate. Ed è iniziata una grande redistribuzione di beni da “proprietari sbagliati” a persone vicine al potere. Finora questa campagna ha colpito le élite regionali: governatori, senatori, ex sindaci. Nel tempo i loro protettori federali sono caduti e ogni settimana ci sono arresti. Ad esempio nella regione di Rostov: è come se avessero arrestato tutta l’amministrazione regionale».
Però, il regime è ancora in piedi.
«Sì, ma invecchia. Sembra proprio che i vertici stiano cercando di accumulare proprietà e potere in vista della fine. Lo schema sembra essere questo: quando il presidente se ne andrà, non ci saranno regole. Il sistema dovrà reinventarsi. È già accaduto in passato. Dopo Ivan il Terribile ci fu il “periodo dei torbidi”, ma poi arrivò una nuova stabilità. Dopo Pietro I ci furono colpi di Stato, ma alla fine salì al potere Caterina la Grande. Dopo Stalin, l’Unione Sovietica – fino alla sua fine – ha cercato di tenersi lontana dalle grandi guerre».
Quindi come immagina il post-Putin?
«Non sarà necessariamente una democrazia, ma potrebbe essere più prevedibile e meno repressivo».
Nel frattempo…
«Centinaia di persone vengono arrestate ogni settimana per motivi politici, la maggior parte comuni cittadini. Chi ha scritto “no alla guerra” in una chat, chi ha letto il sito sbagliato, chi ha fatto una donazione. L’automatismo della repressione è inquietante, quasi banale: ogni gesto può portare a un’incriminazione. E poi c’è la militarizzazione totale della società: tutto viene orientato verso il culto della guerra e della lealtà al potere. I bambini vengono portati in campi di addestramento paramilitare, si insegna loro a costruire granate artigianali, a marciare in uniforme. Il sistema educativo è diventato strumento di indottrinamento. Eppure la società russa non è omogenea. Esistono sacche di resistenza, forme di dissenso sotterraneo, anche solo nell’ironia, nel linguaggio cifrato, nella cultura indipendente. Le persone trovano modi per comunicare, per non essere complici».
Ci sarà una memoria collettiva di tutto questo male?
«La Russia, purtroppo, ha spesso rimosso i suoi traumi: dopo Stalin, dopo la guerra in Cecenia, dopo ogni ondata repressiva. Ma oggi niente può essere cancellato del tutto. I documenti restano. I video circolano. I bambini di oggi diventeranno adulti e chiederanno conto di ciò che è stato fatto in loro nome. La speranza, allora, in un sistema che ti vuole cinico e rassegnato, è un atto radicale. Continuare a raccontare è una forma di resistenza. Possiamo scrivere le regole per il dopo, anche se ora sembrano lontane. Perché la storia è piena di momenti in cui ciò che sembrava eterno è crollato in un attimo. E chi era pronto ha fatto la differenza».
Chi guarda i suoi video su YouTube?
«In Russia non ci si può più organizzare pubblicamente. Ma le persone si riuniscono lo stesso, per esempio nei circoli di lettura, diventati molto popolari. Anche i miei video continuano a essere visti in Russia, tramite i VPN. Prima del blocco il 65% delle visualizzazioni proveniva dalla Russia, anche dopo la mia uscita dal Paese».
E poi c’è il pubblico della diaspora che viene ai suoi spettacoli…
«Le mie conferenze permettono a queste persone di ritrovarsi. Non sono eventi politici, ma si crea una comunità. E le comunità sono istituzioni».