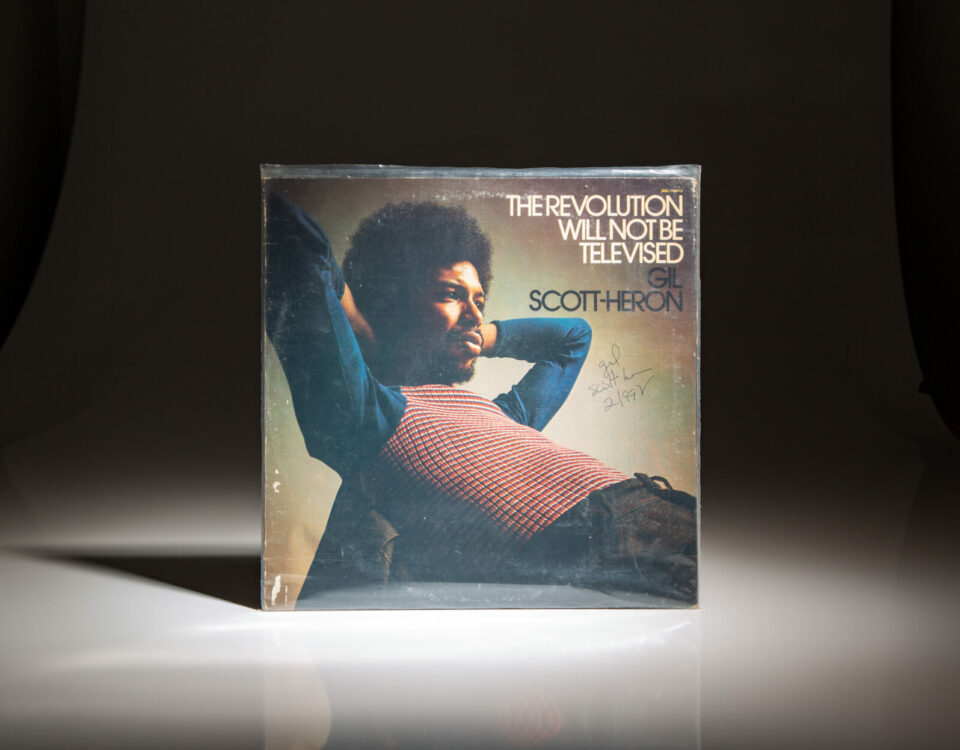“Putin mi considera un agente straniero ma io mi limito a spiegare i meccanismi del potere”
13 Luglio 2025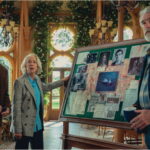
SPETTATORI PER UNA SETTIMANA
13 Luglio 2025A un anno dalla scomparsa, comincia forse a delinearsi con maggior nettezza l’autentico rilievo di Maurizio Pollini, ultimo rappresentante di una civiltà musicale che sembra destinata a sprofondare nel mondo di ieri come tante altre forme della nostra vita sociale e culturale.
Per Alfred Brendel, suo gemello astrale assieme a un altro leggendario pianista del Novecento come Arturo Benedetti Michelangeli, tutti nati il 5 gennaio, i pilastri su cui poggia l’arte di Pollini si chiamano integrità e umanità.
Così scrive il pianista austriaco, infatti, nella prefazione al libro di Angelo Foletto La musica non si ferma Maurizio Pollini, pianoforte e battaglie civili (Libreria Musicale Italiana, pp. 267, € 22,00), arricchito da un’impareggiabile nota critica di Giorgio Pestelli, illuminante sintesi delle caratteristiche che hanno reso tanto memorabili e uniche le interpretazioni di Pollini.
Il titolo è una frase dello stesso pianista, tratta da una delle interviste riportate nel volume, assieme alle numerose recensioni dei concerti e dei dischi, ai commenti giornalistici, agli scritti di Foletto a lui dedicati e accumulati in un lungo rapporto di vicinanza e condivisione, da vero critico militante, dei valori etici e sociali del far musica iniziato nel fatidico 1968.
La musica non si ferma, infatti, richiama l’archetipo del Wanderer, che per Pollini, come per Schubert e Luigi Nono, è l’immagine stessa della condizione moderna. L’idea che il viaggio sia il fine stesso del viaggio significa la necessità esistenziale di non interrompere mai il processo di ricerca, nemmeno quando le forze per proseguire il cammino sembrano scemare in maniera irreversibile.
Sarà sicuramente un caso, ma il fatto che l’ultimo disco pubblicato da Pollini, registrato assieme al figlio Daniele, sia interamente dedicato a Schubert è in un certo senso emblematico di questo istinto a guardare sempre oltre la siepe, a non accontentarsi mai di quel che si è raggiunto. Massimo Mila diceva che ci sono due modi di andare in montagna, uno è di cercare sempre nuovi sentieri e l’altro di trovare sempre cose nuove sugli stessi sentieri.
Pollini apparteneva a quest’ultima categoria essenzialmente. Il suo repertorio non era sterminato, sebbene la strabiliante caratura tecnica gli permettesse di affrontare qualsiasi partitura. Pollini non ha mai portato in sala da concerto o in studio di registrazione autori come Scriabin, Ravel o Rachmaninov, e di altri ha suonato soltanto alcuni lavori, come il I Libro del Wohltemperierte Clavier, unico sconfinamento nel regno di Bach e della musica cembalistica. Integrità e rigore nelle scelte, certamente, ma forse anche il desiderio di scavare più a fondo nella musica che sentiva vicina e il bisogno di interrogarla di nuovo, a cominciare naturalmente da Beethoven ma allargando il compasso agli autori che formavano la sua costellazione: gli amati Schumann e Chopin, l’indispensabile Schubert, i maestri del Novecento da Debussy a Bartók, i compagni di strada Boulez, Nono e Sciarrino.
La cronaca frammentata ma viva di Foletto ci permette di seguire Pollini in oltre quarant’anni di strada musicale, percorsa fino all’ultimo con un’incrollabile fiducia nel proprio tempo, consapevole che i valori universali dell’arte non sono mai veramente separati dall’agenda che il mondo propone quotidianamente, dal Vietnam alla pandemia, dalle fabbriche occupate ai populismi reazionari.
La stella polare di questo cammino è stato Beethoven, il primo compositore della storia a scrivere non per un particolare gruppo sociale ma per l’umanità intera, per i Millionen di Schiller. Beethoven non è stato soltanto il destinatario dei progetti più importanti di Pollini ma anche la pietra di paragone di tutte le sue interpretazioni, come se in ogni altro autore, per quanto lontano e diverso nel carattere e nello stile, Pollini cercasse di trovare la stessa ansia di infinito, un’uguale urgenza di parlare al mondo.