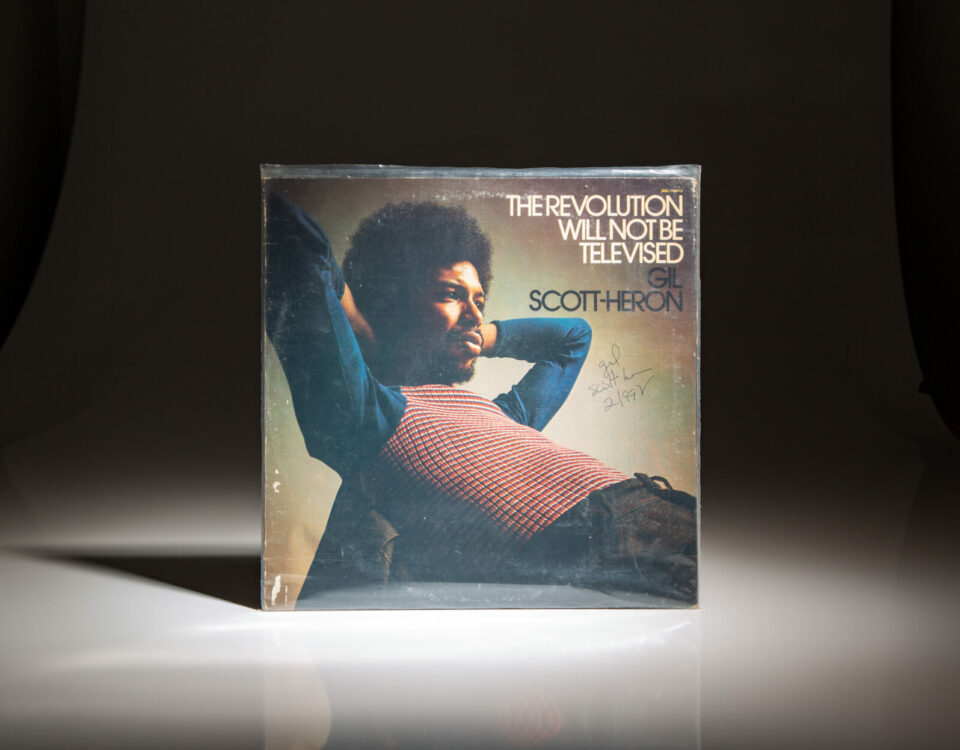𝐎 𝐓𝐇𝐈𝐀𝐒𝐎𝐒 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎𝐍𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀. Bagno degli Ebrei – Piancastagnaio
7 Agosto 2025
Mediobanca, l’assemblea si avvicina: nuovi ingressi e mosse strategiche spingono l’Ops su Banca Generali
8 Agosto 2025
Donald Trump ha dato il via a una nuova fase di protezionismo aggressivo, imponendo dazi tra il 10% e il 50% su importazioni da 92 Paesi, i più alti negli Stati Uniti da quasi un secolo. Secondo il segretario al Tesoro, il gettito per il 2025 potrebbe arrivare a 300 miliardi di dollari e superare questa cifra l’anno successivo. Alcuni prodotti, come il succo d’arancia brasiliano o il rame cileno, hanno ottenuto esenzioni, ma la mappa delle tariffe è frutto di negoziati caotici e spesso incompleti, con accordi non ancora formalizzati o interpretati in modi divergenti dalle parti.
La novità rispetto alle guerre commerciali del passato è la loro natura permanente: i dazi non hanno più un inizio e una fine chiara, ma possono essere introdotti, alzati o rimodulati in qualsiasi momento e per qualunque ragione. È successo con l’India, che in pochi giorni ha visto raddoppiare le tariffe a causa degli acquisti di petrolio russo, mentre altri Paesi – come la Svizzera – non sono riusciti a ottenere riduzioni e valutano contromosse, persino in ambito militare, come la cancellazione dell’ordine per gli F-35 americani. Trump ha già annunciato possibili tariffe fino al 100% su semiconduttori, farmaci e altri prodotti, salvo esenzioni per le aziende che si impegnano a produrli negli Stati Uniti.
I rapporti con l’Unione europea sono particolarmente tesi. L’intesa del 27 luglio, che prevedeva il taglio al 15% delle tariffe su auto, chip e farmaci, non è stata attuata: Washington ha aggiunto nuove condizioni legate alla completa rinuncia agli acquisti di petrolio russo, mentre continua a premere per lo smantellamento del Digital Services Act, considerato un ostacolo per le big tech americane. La Commissione europea, irritata, denuncia l’inaffidabilità del partner e teme che i dazi possano presto salire invece di scendere. La Bce, nel suo bollettino, ha avvertito che l’accordo non riduce le incertezze su crescita e inflazione, anzi le prolunga.
Sul fronte energetico, la presidente von der Leyen ha promesso a Trump che l’Ue acquisterà prodotti energetici americani per 750 miliardi di dollari in cinque anni, pari a 250 miliardi all’anno tra gas, petrolio e tecnologie nucleari. Ma il traguardo appare fuori portata: nel 2024 l’Europa ha importato dagli USA energia per soli 76 miliardi, e la capacità produttiva statunitense – così come la domanda europea, destinata a calare nel lungo periodo – non rende credibile un balzo simile. Inoltre, il mercato del gas liquefatto è guidato da logiche commerciali e non da patti politici, e le rotte di fornitura seguono i porti con le condizioni economiche migliori, non le agende diplomatiche.
Di fronte a questa situazione, in Europa si aprono due strade. Da un lato, la tentazione di accettare compromessi per proteggere alcuni settori e limitare i danni immediati. Dall’altro, la spinta – sempre più forte – a rifiutare quella che molti definiscono una “politica dell’appeasement 2.0”, paragonata agli errori di chi cedette a potenze autoritarie nel secolo scorso. Le voci critiche chiedono di difendere i principi fondativi dell’Unione anche a costo di un calo temporaneo del Pil, rafforzando la coesione interna, superando il diritto di veto su fisco e politica estera e agendo come un vero attore politico globale.
La sfida è esistenziale: restare nell’orbita di una superpotenza che usa il commercio come arma di pressione, o dotarsi della capacità di agire autonomamente, anche a rischio di pagare un prezzo economico nel breve periodo. In un contesto in cui le decisioni americane arrivano senza preavviso e riscrivono le regole del gioco, la stabilità dell’economia europea e la sua capacità di dettare la propria agenda sono messe alla prova come non accadeva da decenni. L’esito dipenderà da quanto l’Unione saprà trasformarsi da gigante commerciale a soggetto politico in grado di resistere e di dettare le proprie condizioni.