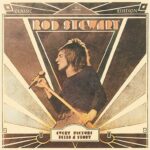Le lezioni anni ’80 del filosofo francese, ora edite in Italia, riflettono sulla relazione tra arte e caos. Spiegando come tutti i grandi, da Van Gogh a Turner, rifondano lo sguardo
di MASSIMO RECALCATI
«Una lezione significa avere dei momenti di ispirazione, altrimenti non significa niente». Così Deleuze alla voce “Professore” nel suo celebreAbbeCedario .
Di questi momenti di ispirazione offre una testimonianza davvero formidabile il Corso dedicato al tema della pittura tenuto dal filosofo presso l’università di Vincennes nella primavera del 1981 e recentemente pubblicato da Einaudi (Sulla pittura. Corso marzo-maggio 1981 è il titolo del libro). La domanda che lo apre evidenzia da subito la posta in gioco: cosa ha la pittura da insegnare alla filosofia?Dunque, in gioco non è la formulazione di una filosofia della pittura, ma la filosofia che è possibile attendersi dalla pittura. Ebbene, quale è secondo Deleuze la lezione radicale della pittura che può servire alla filosofia?
La sua tesi è che la pittura è una esperienza della catastrofe. Questo significa, come insegnano esemplarmente pittori come Turner o come Van Gogh, che «la catastrofe è al cuore dell’atto del dipingere» poiché in quest’atto le forme consolidate, oggettive, già stabilite del mondo, tendono a disfarsi e a svanire.
L’esempio di Turner è assai significativo. In un primo tempo il pittore inglese dipinge le catastrofi — valanghe e tempeste per esempio —, ma nella sua maturità è la pittura stessa che si rivela catastrofica minando l’integrità di ogni forma già definita.
Il quadro assume così l’aspetto di un «braciere» o di una sorta di «fornace» che produce il dissolvimento di ogni visione consolidata del mondo. Sì perché al fondo dell’atto catastrofico del dipingere è in gioco unanuova nascita. Innanzitutto quella del colore, che però significa, ancora più radicalmente, la nascita di un nuovo mondo: «i pittori non fanno altro che dipingere una sola cosa, l’inizio del mondo». Nondimeno, il primo tempo della creazione artistica è quello del caos. È necessario il suo attraversamento preliminare per poter giungere a dare forma a un nuovo mondo.
Qualcosa infatti è tenuto a fuoriuscire dall’incandescenza del caos. È una istanza già presente nel Nietzsche teorico dell’arte: «Ogni artista mira a costringere il proprio caos in una forma». Più di preciso, l’inizio del processo creativo mira a spazzare via tutto ciò che è già stato visto e saputo. Deleuze insiste nel mostrare che il vero confronto non è quello del pittore con la tela bianca, con il carattere illimitato del suo spazio, ma coi fantasmi che la assediano, ovvero con tutti i cliché che in essa si sono rintanati «come delle bestie che si precipitano sulla tela prima ancora che il pittore abbia afferrato il suo pennello ». Dunque il passaggio necessario attraverso il caos è reso possibile solo dal crollo catastrofico di tutto ciò che è già stato detto e dipinto. Si tratta, in altre parole, di rendere la tela davvero bianca, di un azzeramento di tutti i cliché che la parassitano, di porre al suo centro, come si esprime poeticamente Deleuze, l’esperienza del Sahara. È, infatti, solo da questo deserto che può sorgere una nuova presenza.
Diversamente «una pittura che non comprende questo abisso, che non passa da quest’abisso, che non lo instaura sulla tela, non è pittura». È quello che Deleuze definisce «diagramma », ovvero una specie di «caos-germe» che rende possibile la realizzazione di quell’«abisso ordinato» in cui consiste un’opera d’arte. Ma inizialmente si tratta, appunto, di ripulire la tela, di sottrarla dai preconcetti e dagli stereotipi, di svuotarla, di lottare per non cedere al già visto. Se non si attrav ersa il caos-catastrofe si resta fatalmente prigionieri dei cliché. Inquesto senso la pittura deve liberarsi da ogni riferimento all’illustrazione e alla narrazione. Un quadro ha il suo referente solo in se stesso, non deve rappresentare null’altro che la sua propria immanenza. Questo significa, per usare le parole di Deleuze, che «la pittura genera da sé il proprio fatto».
Più di preciso, l’atto del dipingere implica la cattura di una forza: «Non si tratta di rendere il visibile, si tratta di rendere visibile». Ma ogni forza comportanecessariamente l’alterazione o la deformazione delle forme già costituite. Catturare la forza di un grido, per esempio, come accade nella pittura di Francis Bacon, o quella della luce, come accade con Vincent van Gogh.
Lo sforzo della pittura resta allora lo stesso della filosofia: liberarsi dalla rappresentazione, immergersi nel flusso anarchico della forza, «disfare la rappresentazione per far sorgere la presenza». Si può, si chiede Deleuze, per provare a esemplificare il suo pensiero, rappresentare un’operazione chirurgica? Coloro che hanno fatto questa esperienza portano nei loro occhi la traccia indelebile di questo incontro. La nostra carne haincontrato qualcosa che ha lasciato un segno. Ebbene, il pittore è colui che riesce a catturare e a restituire la forza di questo incontro che si è iscritto misteriosamente nella carne del nostro corpo.
In questo senso egli può affermare iperbolicamente che «non c’è mai stata pittura figurativa » poiché il suo compito non è mai stato quello di illustrare ciò che già esiste — un «modello » — ma di fare sorgere dal caos una Figura (termine che egli preleva con profitto da Lyotard) inedita. Il rischio della pittura è però quello di neutralizzare il caos riducendolo al minimo, sottoponendolo, per esempio, a un codice ottico — è quello che accade nell’astrattismo “alla” Kandinskij — oppure è quello di sprofondare in esso — come accade nell’espressionismo astratto “alla” Pollock. Nel restare impigliati in questo doppio rischio — «rischio codifica» e «rischio offuscamento» — ciò che si perde è il compito più alto della pittura e della filosofia stessa: creare un nuovo inizio del mondo, nuove figure o nuovi concetti, in grado di ordinare l’abisso.