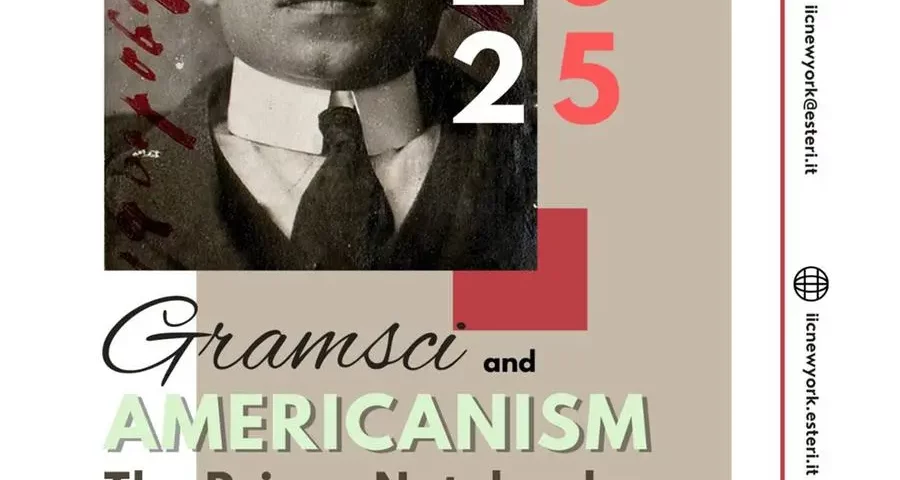Leggere Gramsci a New York, a Park Avenue. Leggere Gramsci sull’America, nell’America di Trump, quel Donald Trump che perseguita «Antifà», qualsiasi cosa sia. Succede per colpa di recondite alchimie del calendario degli eventi, il caso ci ha messo la coda. La mostra Gramsci and Americanism. The Prison Notebooks non era certo pensata come una provocazione (culturale, s’intende) dell’Istituto di cultura italiano, nel cuore della New York che resiste alla slavina trumpiana. Ma è andata così.
Spiega Silvio Pons, presidente della Fondazione Gramsci, che ha inaugurato la mostra – quattro Quaderni, sei volumi, due fascicoli di riviste, edizione digitale e integrale dei trentatré Quaderni del carcere; postazione per consultare la Antonio Gramsci Digital Library, un documentario – mercoledì 22 ottobre.
«La coincidenza fra la mostra e la presidenza di Trump è casuale. L’abbiamo progettata da tempo. Dal 2017, l’anniversario dell’80esimo della morte di Gramsci, abbiamo organizzato eventi e esposizioni con gli originali dei Quaderni, con tutto il loro impatto simbolico. In Italia ma anche fuori. Un percorso che conferma come Gramsci sia un autore globale. Gli eventi espositivi sono stati pensati in questa chiave, a Londra, a Parigi, a Mosca. Ora a New York. Ciascuno di questi luoghi è intrecciato con la biografia o con la fortuna di Gramsci nel mondo. Ovunque è stato un successo strepitoso».
C’è, dunque, un Gramsci americano, cioè studioso degli Usa. Qual è la sua analisi del ruolo degli Usa?
Sì, esiste un Gramsci analista dell’America pur non essendo lui mai stato in America. L’interesse gli nasce già negli anni della Prima guerra mondiale, al momento dell’intervento degli Stati Uniti. E culmina nel carcere. Negli ultimi anni di vita Gramsci incentra la sua attenzione sul tema dell’americanismo e del fordismo, che è il titolo poi del Quaderno 22, scritto nel 1934.
Come nasce quest’attenzione?
È un interesse intellettuale che può essere fatto risalire addirittura agli anni giovanili. In un tema liceale si dilunga sul tema dell’«americanarsi dell’Europa». Il momento decisivo è l’inizio del 1918, il programma dal presidente Woodrow Wilson sulla pace attraverso la democrazia, l’autodeterminazione nazionale, la proposta di una Società delle nazioni. È il momento dell’enorme impatto politico di Wilson in Europa. E Gramsci, giovane militante socialista, e pubblicista, recepisce questo impatto, in particolare sul mondo del socialismo europeo. Gramsci riconosce la capacità attrattiva del «mito di Wilson»: è una nuova politica rispetto a quella vecchia europea. Nell’ultimo anno di guerra, riconosce che il wilsonismo non è solo una “religione dell’umanità”, in continuità con il pensiero di Mazzini, come veniva presentato, ma l’ideologia di un nuovo blocco egemonico che emerge dalla guerra, costituito dagli Usa e dalla Gran Bretagna. La sua è un’analisi in chiave marxista, ma non ortodossa. Non liquida il Wilsonismo come un mero inganno, lo considera invece un progetto liberale di unificazione dei mercati mondiali. Con le parole di oggi, potremmo dire la nascita del capitalismo globale. Nello stesso tempo, Gramsci invita i socialisti ad affrancarsi dal mito wilsoniano e contrappone alla Società delle nazioni la tradizione internazionalista del movimento operaio.
Gramsci considera allora Wilson e Lenin i «due geni politici» del Dopoguerra. Perché?
Perché sono ai suoi occhi, come per molti altri della sua generazione, le uniche personalità possesso di un progetto politico autentico. Pace attraverso la democrazia, per Wilson; pace attraverso la rivoluzione e il socialismo, per Lenin. Gramsci ovviamente aderisce alla visione del bolscevismo, anzi contrappone il mito della rivoluzione russa a quello wilsoniano, in nome di un internazionalismo proletario, che si deve contrapporre all’internazionalismo liberale e borghese. La stella di Wilson si spegne presto, perché il presidente americano accetta la visione britannica e francese della pace punitiva verso la Germania e applica la promessa dell’autodeterminazione solo in Europa ma non nel mondo colonie. Si può dire che la piena adesione di Gramsci al bolscevismo si consolidi proprio in rapporto al declino e alla fine del “momento wilsoniano”.
Insomma, è un comunista affascinato dall’America?
Gramsci è affascinato dalla Rivoluzione russa, ma non rinuncia mai all’analisi come fondamento della politica. E per lui ogni analisi politica deve avere un profilo internazionale. Non è certo l’unico a sottolineare la modernità e il potere dell’America, lo fanno vari dirigenti bolscevichi, per esempio Trockij. Ma le risposte più originali di Gramsci arriveranno dal carcere. Il tema dell’americanismo e il fordismo è presente già nell’apertura del primo Quaderno. È l’8 febbraio 1929, quindi prima del crollo di Wall Street. L’americanismo per lui non è una categoria solo economica, riguarda trasformazioni sociali e politiche di dimensioni mondiali. Il fordismo non è solo il disciplinamento del lavoro in fabbrica, ma investe l’intero sistema delle relazioni sociali, un nuovo modello di un capitalismo.
Nel Quaderno 22, sviluppa la propria analisi in due direzioni: quella delle cosiddette «economie programmatiche», cioè le risposte interventiste e regolatrici alla crisi del ‘29; e il tema della «rivoluzione passiva»: l’idea cioè che nella storia moderna, dopo la Rivoluzione francese, siano state realizzate trasformazioni profonde portate avanti dalle stesse classi dirigenti, in reazione alle sfide rivoluzionarie. Insomma, la rivoluzione senza rivoluzione, che Gramsci vede come l’aspetto principale del dopoguerra e della crisi europea, essendo ormai giunto alla conclusione che il 1917 sia stato un episodio irripetibile e che l’Unione sovietica di Stalin sia uno stato di polizia. L’americanismo come «rivoluzione passiva» presenta una supremazia anche sul fascismo in Europa.
Nasce qui l’“antiamericanismo” della sinistra comunista?
Esiste un antiamericanismo comunista degli anni Venti, che deriva dall’anticapitalismo e che Gramsci condivide. Ma ciò non gli impedisce di vedere il carattere dinamico dell’americanismo, persino nel pieno della Grande depressione. Poi, certo, ritiene che non possa fondare una nuova civiltà umana. Ma l’antiamericanismo per come lo intendiamo ancora oggi nasce piuttosto con la Guerra fredda e l’egemonia americana in Europa dopo la Seconda guerra mondiale.
C’è qualcosa di “utile” nel Gramsci sull’America, per leggere l’America di Trump?
Le domande che si pone Gramsci sull’americanismo come vettore globale hanno un senso anche oggi, nell’epoca del declino che Trump sta rivelando al mondo. Le risposte appartengono invece alla sua epoca. Gramsci non ha una visione della società dei consumi e non può immaginare L’americanizzazione del Secondo Novecento. Ma si interroga sull’americanismo come fenomeno trasformativo della società, capace di modificare i caratteri del consenso, legato al senso comune, eclettico e sfuggente sul piano ideologico.
Come il trumpismo?
In un contesto storico completamente diverso, il trumpismo non è una semplice replica, ma rivela un’eredità lunga. Indubbiamente c’è un aspetto simbolico della mostra di Gramsci nell’America di Trump. Anche per un’altra ragione: negli ambienti della destra radicale americana, Gramsci è identificato come l’ispiratore di quello che loro chiamano il “marxismo culturale”. Uno stereotipo dell’anticomunismo del 21esimo secolo, che identifica le culture progressiste di ogni tipo e la loro reale o presunta influenza nelle scuole e nelle università. Nello stesso tempo, esiste una vaga idea di appropriazione della nozione di egemonia da parte della destra radicale, ma è un’idea di egemonia che non ha niente a che vedere con quella di Gramsci, perché questo termine viene usato come semplice sinonimo di manipolazione e di controllo.
Dunque quella di Trump è una destra egemone, ma non in senso gramsciano?
La teoria dell’egemonia in Gramsci è una strategia complessa, basata sui nessi tra classi dirigenti consapevoli, elaborazione degli intellettuali, coscienza di massa. La sua evocazione non ha senso dinanzi all’esercizio del potere come dominio, prepotenza, interesse. Dall’altro lato, la visione di una riforma intellettuale e morale della società può forse essere ancora vista come una forma di resistenza allo svilimento di ogni dimensione progettuale, alla povertà culturale dei governanti del nostro tempo e agli stereotipi demonizzanti, ivi compresa la demonizzazione dell’antifascismo. Tutti fenomeni che qui, nell’America di Trump, stanno varcando ogni limite.