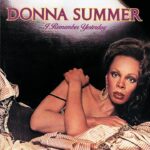
DONNA SUMMER I feel love
11 Maggio 2025
Cultura a Siena: ora servono visione e strategia
11 Maggio 2025Patrimonio Un percorso di letture per difendersi dalla retorica trionfalistica che scambia musei, siti e monumenti per «miniere»: da Erbani a Guzzo fino a Montanari, Pavolini e a diverse voci di archeologi e archeologhe, tutti gli effetti nefasti della cosiddetta Riforma Franceschini
Lo scorso 4 maggio, come in ogni prima domenica del mese, il pubblico ha potuto accedere gratuitamente agli oltre 500 siti archeologici e musei statali italiani. Gli scavi di Pompei sono stati presi letteralmente d’assalto, al punto che fin dalla mattina la direzione del Parco ha dovuto sospendere gli ingressi, limitati da un provvedimento del novembre 2024 a 20mila visitatori al giorno (la media quotidiana è di 15mila, ndr). Una circostanza che ha spinto varie sigle sindacali delle guide turistiche operanti in Campania a denunciare lo stato di disagio (file lunghissime, assembramenti nonché insufficienza di casse, personale di accoglienza, tornelli e totem) causato dall’introduzione del biglietto nominativo e delle fasce orarie. Dispositivi che hanno peggiorato una situazione già al collasso, con flussi in costante aumento che si aggirano intorno ai 4milioni di turisti l’anno.
QUEST’EPISODIO obbliga a riflettere ancora una volta sull’opportunità di riservare la gratuità a un’unica giornata mensile (la «domenica al museo» è stata istituita il 1 luglio del 2014 dall’allora ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini) e più in generale sulla politica di gestione dei beni culturali, che continua a convogliare attenzioni e risorse soprattutto sui «grandi attrattori». Basta scorrere la Top 30 dei musei, monumenti e aree archeologiche statali (gli ultimi dati disponibili risalgono al 2023) per rendersi conto del divario abissale tra il Parco archeologico del Colosseo, primo della lista con 12.298.246 presenze e musei e aree archeologiche «minori» quali il Museo nazionale romano e il Parco archeologico di Ostia antica, che superano appena i 300mila visitatori. Eclatante anche il distacco tra il Parco archeologico di Pompei e quello di Ercolano, che nello stesso periodo hanno accolto rispettivamente 4.087.164 e 563.165 utenti. Il Colosseo, Pompei, gli Uffizi ma anche il Pantheon (secondo in classifica con 5.196.106 visitatori dopo l’introduzione, a luglio del 2023, del biglietto a pagamento) costituiscono gli ingranaggi di un sistema perverso, oliato da scoperte sensazionali, eventi e mostre perlopiù commerciali. Un meccanismo finalizzato a incrementare gli incassi, che affonda le sue radici nella Riforma Franceschini e più nello specifico nell’autonomia finanziaria e scientifica concessa nel 2015 a 20 istituti di «rilevante interesse nazionale», lievitati a 60 durante il breve mandato al ministero della Cultura di Gennaro Sangiuliano (sostituito il 6 settembre del 2024 da Alessandro Giuli). Staccando i musei dalle soprintendenze e separando così la tutela dalla valorizzazione, quest’ultima ha finito per prevalere e condizionare l’intero quadro culturale del paese con la ricerca spasmodica della performance economico-finanziaria. In altri termini: o numeri o morte.
Di questi temi ragiona Francesco Erbani in Lo stato dell’arte. Reportage tra vizi, virtù e gestione politica dei beni culturali (Manni, pp. 208, euro 16). L’autore fa risalire lo spartiacque tra un interesse elitista nei confronti del patrimonio e la (presunta) democratizzazione della cultura al 1981, quando il presidente della Repubblica dell’epoca Sandro Pertini decise di esporre al Quirinale i due bronzi recuperati nel 1972 nel mare di Riace (le maestose sculture del V secolo a.C. sono peraltro balzate nuovamente all’attualità in seguito a un controverso speciale del Tg1, andato in onda la scorsa settimana, che vorrebbe spostarne la scoperta in acque siciliane). Di quell’evento si ricordano le code interminabili e anche gli spintoni, sebbene il fatto che l’arte fosse scesa dal piedistallo sembrò ad alcuni, tra cui Beniamino Placido, solo un fenomeno emozionale di massa. Nello stesso decennio in cui nacquero espressioni quali «giacimenti culturali» e «petrolio d’Italia», «l’allargamento del pubblico – sottolinea Erbani – diventava in prevalenza una faccenda di reclutamento a strascico e non tanto di interpretazione dei bisogni o delle aspirazioni, culturali e non solo, dei potenziali fruitori ai quali andare incontro. Insomma, non interessava tanto come fosse articolata quella domanda di cultura, ma la sua progressione».
DA LÌ A CONSIDERARE i beni culturali come miniere da cui estrarre valore monetario il passo fu breve e si consolidò l’idea che essi avrebbero potuto procurarsi da sé le risorse e persino generare profitti. Era sufficiente venderli come una qualunque merce e attirare investimenti privati. Il saggio di Erbani, che estende l’analisi anche a centri storici, archivi e biblioteche, mette in evidenza le storture della Riforma Franceschini, riassumibile nello slogan «meno Stato, più mercato». Un vessillo neoliberista che, per l’autore, mal si adatta alla realtà concreta di musei, siti archeologici e monumentali.
Alle politiche per il patrimonio è dedicato anche il volume Dieci anni dopo. Riflessioni sparse sulla «riforma» Franceschini (Scienze e Lettere, pp. 140, euro 15), a cura di Pier Giovanni Guzzo e con la premessa di Tomaso Montanari. Oltre a Guzzo, Emanuele Greco, Caterina Bon Valsassina, Leonardo Bison, Irene Berlingò, Alfredo Balasco e Mirco Modolo offrono il loro contributo critico sugli effetti della suddetta riforma del 2014, che – malgrado il successivo riordino del ministero della Cultura in quattro dipartimenti da parte di Sangiuliano – influenzano ancora oggi le sorti di musei, aree archeologiche e archivi.
NELLO STESSO LIBRO, Luigi Malnati, Raffaella Poggiani Keller e Alessio De Cristofaro propongono alcune idee per un rinnovamento dell’archeologia italiana, scienza che da ormai un secolo mira a ricostruire il contesto storico, socio-economico, territoriale e ambientale con un rigoroso metodo di ricerca e scavo ma che è sempre più prigioniera di una concezione – almeno a livello di comunicazione – tesa a enfatizzare le grandi scoperte e a privilegiare una visione di tipo estetico / antiquario o prettamente economica.
Carlo Pavolini si concentra invece sulla valorizzazione «virtuosa», ovvero quella che dovrebbe aspirare al pieno recupero dei luoghi storici particolarmente attrattivi ai fini di conoscenza, per diffondere una «pedagogia civile» e stimolare la partecipazione democratica. L’autore – una delle poche voci militanti e resistenti dello spento dibattito pubblico sui beni culturali – aveva già approfondito l’argomento in Quale valorizzazione (Robin, pp. 244, euro 20), un testo che senza ambiguità politica respinge le accuse di «visione ideologica» rivolte a coloro che cercano di opporsi al pensiero dominante (anch’esso intriso di ideologie, come d’altronde ogni atteggiamento verso il mondo).
IN QUEST’ULTIMO SAGGIO, di cui il contributo nel volume collettaneo costituisce una sintesi aggiornata, Pavolini aveva stilato una lista avvilente di esempi di «mala-valorizzazione» – dal Colosseo al Museo archeologico nazionale di Napoli –, i quali derivano dallo sfruttamento spregiudicato del patrimonio a scopi spettacolari e di lucro. Una valorizzazione intesa dunque come «valore monetario di scambio» e non come consapevolezza storica.
I casi recenti del party per i sessant’anni di Madonna nel Teatro grande di Pompei o della festa di matrimonio nelle sale affrescate dell’Archivio storico di Napoli, dimostrano che il trend mercantile non sembra esaurirsi. Opere iconiche, che nel 2022 sono persino servite da arredi per sfilate di moda, continuano a girare il mondo, come ora per l’Expo di Osaka. Il futuro di Caravaggio, che tra resse e polemiche viene ora celebrato nella mostra di Palazzo Barberini, sarà al Vinitaly?





