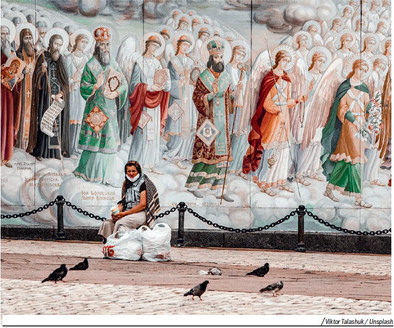giulia zonca
A seguire le parole di Gianni Minà si arriva in un posto che non c’è e che pure non è affatto immaginario. Non è l’isola di Peter Pan, anzi, è un luogo denso di vivacissimi incontri, popolato da campioni e comandanti, che Minà aveva il vezzo di chiamare “perdenti”. Uomini di potere e di gloria definiti però dal loro rapporto controverso con il sistema, alternativi, ribelli, rivoluzionari, populisti. Gli piacevano così ed erano tutte persone importanti riconosciute dalla storia, tutte facce di talento capaci di spiccare però, comunque, “perdenti”, almeno secondo la geografia di questo giornalista audace e gentile che non ha lasciato mappe e non può avere eredi, però ci ha portato dove è giusto passare, dentro la “fame di storie” che ora, non a caso, è il titolo del libro che lo racconta per immagini, finora inedite.
Chi è stato Gianni Minà lo sappiamo. Giornalista appassionato fin da ragazzino, figlio di un segretario della federazione di calcio e quindi immerso da sempre dentro lo sport che adorava e pure abituato a guardarlo e assaggiarlo dietro le quinte. Nasce a Torino, lavora a Tuttosport, poi lo dirigerà, ma scrive per tante testate nella sua movimentata vita che a un certo punto lo porta a fare l’autore televisivo, a lavorare con Arbore, a declinare la passione per il cinema, il Sudamerica, a inventare le interviste di Blitz con cui racconta l’Italia vista dagli Anni Sessanta e non è solo un dettaglio anagrafico, una coincidenza legata al periodo più affascinante, è un legame profondo con un tempo preciso che lui negli ultimi anni ha percepito così: «Abbiamo sperato tutti in quel tempo, credevamo di raccogliere i frutti di tanti combattimenti e invece no». E invece no. Da lì la nostalgia, e da lì la “Fame di storie” che dovevano riempire, traghettarci in una democrazia compiuta, in una società evoluta e purtroppo ci lasciano disincantati, divertiti e disorientati ed è normale che sia così perché sappiamo chi è Gianni Minà e pure che cosa ci ha lasciato, ma non lo possiamo e nemmeno vogliamo seguire. È un unico e questo libro lo spiega bene.
Voleva essere amico dei soggetti del suo lavoro, una scelta che ora, con tutti i filtri aggiunti per schermare chi è popolare, con tutti i passaggi obbligati per comunicare con chi ha un ruolo e i social usati per dare una linea senza un tramite, sarebbe già complicata di suo. E c’è altro i suoi rapporti privatissimi sono pure lontani dall’idea di intervista contemporanea. La neutralità non esiste, però i rapporti personali condizionano, se poi diventano amicizia svelano e limitano insieme, inevitabile, solo che Minà voleva essere meravigliosamente coinvolto e lui poteva permetterselo anche perché si era disegnato così. Un infiltrato. Un sincero e affidabile infiltrato. Partiva da alcune idee da difendere e lo faceva con le persone che potevano sostenerle: con chi aveva la voce per farsi ascoltare, le spalle per reggere gli attacchi, la confidenza con la scomodità e ci vuole mestiere ed empatia per entrare nella cerchia di Ali e Maradona, di Mennea e Castro, De Niro e Tognazzi, doti che Minà ha affinato e perfezionato all’infinito, fino a possedere strumenti quasi magici.
Non ammetteva critiche per i suoi eroi, Fidel è la controcultura e la scuola buona per tutti e la sanità tanto accudente da consentire al Pibe in disarmo di disintossicarsi nel nome di Che Guevara. Il Sudamerica opposto alle brame de Stati Uniti era il suo giardino, eppure New York restava casa, gli Stati Uniti un pozzo di suggestioni. Non ne amava il governo, ma si lasciava trasportare dalla gente e, questo sì, resta e ci resta. La capacità di ascoltare e quell’entusiasmo che sposta, che permette una sintonia tutt’ora valida per i tanti contagiati dalla voglia, dal bisogno, dalla fame di raccontare. Quello è il terreno comune, la “Fame di storie” poi c’è tutto un sentimentalismo spinto che era il suo bello e resta suo, privato, incondivisibile, molto lontano dai Duemilventi. Qui si devono per forza fare altri conti e in parte prima di morire li ha fatti persino lui, senza spostare di una virgola le proprie convinzioni e consapevole però che l’illusione di un mondo nuovo mosso dalle imprese da lui narrate era evaporata. Giustamente questa rivelazione non ha portato tristezza: Minà è stato in mezzo al più e al meglio, dentro le chiacchiere, nelle cene intime, nelle confessioni di cui, con etica ammirabile, prendeva solo i bordi per avvicinare i miti ai lettori, ai telespettatori, agli osservatori. Gli dobbiamo parecchio, non l’imitazione.
«Di tante cose ero vorace, volevo frequentare tutto e tutti e non si può fare, ma è classico dei perdenti credere di poterci riuscire e nel mentre realizzare, accumulare», lo ha detto in una lezione alla Normale di Pisa e si è tratteggiato come faceva con i personaggi famosi di cui si prendeva cura. Poche parole, nessuna condiscendenza, sincera ammirazione, grande intimità a cui arrivava con pensieri diretti e gesti spontanei e attese educate e rispetto assoluto. Poi faceva semplicemente parte di quella cricca, di quella élite per niente snob ma di sicuro disabituata alla quotidianità. Lui li frequentava, una gioia per lui e un sorriso partecipe per chi si è goduto certe chiacchiere. Ancora si può fare, basta scrivere Minà su Youtube, cercare in RaiPlay. Le conversazioni con Troisi dopo il primo scudetto del Napoli, tutti quei punti di sospensione negli scambi complici con Volonté. Minà aveva dei maestri e li nominava spesso: Maurizio Barendson, Sergio Zavoli, ma non aveva allievi e sapeva che li avrebbe portati a incroci complessi. Che li avrebbe mandati a sbattere. Sapeva che non c’era più l’illusione dei Sessanta a proteggere la fantasia, il vento della rivoluzione se ne era andato, la necessità di prendere una parte e sventolarla restava questione sua, un lavoro da portare avanti senza alcuna volontà di passarlo ad altri. Niente testimone da consegnare, quella folle corsa finisce con lui.
Minà era certo che la “Fame di storie” restasse, e infatti è così, oltre schieramenti ormai troppo rumorosi per essere assecondati. Avventure che si rifiutano di fermarsi alle tesi preconfezionate, ritratti, un modo di guardare, più che di comunicare: Minà ce lo ha insegnato senza imporlo. Invece di fissare dritto in faccia la notizia, cercare di capire tutto quanto le gira intorno, ogni dettaglio che sembra allontanare dal centro dei fatti, che di certo allunga la strada per ottenere il senso eppure lo rende pieno, ne restituisce i colori, i motivi. Poi lui ci si perdeva dentro con una dolcezza che solo la memoria rende stucchevole. Ci siamo incantati sul tormentone «Eravamo io Gianni Minà, Alì, Scorsese, Paco Pena», la filastrocca è infinita e si è fatta un po’ meschina, eravamo io qualche cantante gospel, qualche anima tradita, qualche ego lesionato, un microcosmo isolato nel rimpianto di decenni ricchi e ruspanti e bigotti. Sfoggiare amicizia contro giudizi era un antidoto, l’autoreferenzialità era concessa a Minà perché prometteva ai suoi interlocutori di non abusarne e si metteva nella galleria dei perdenti di successo, «i giornalisti sono vanitosi». Ecco, non dovrebbero perché l’eco dei Sessanta si è esaurito e tra le cose da ricordare ci restano i baci tra Minà e Alì e la scoperta di un posto che non c’è e che fa venire tanta “Fame di storie” e di vita. Con meno io, ce ne è fin troppo in questi Duemilaventi.