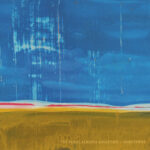Perché il pensiero di Antonio Gramsci continua a essere periodicamente scoperto o riscoperto, anche se negli ultimi tempi l’interesse sembra essersi focalizzato più a destra (si veda il libro di Alessandro Giuli Gramsci è vivo. Sillabario per una egemonia contemporanea) che a sinistra? Al di là del concetto di egemonia, a cui si fermano molti commentatori, la vera ragione del revival gramsciano l’ha colta Angelo d’Orsi, suo eccellente biografo e studioso. “La grande novità gramsciana”, ha scritto, “è, ancora una volta, l’allargamento dello spettro dell’analisi, dal mero terreno dell’economia (…) a quello più complesso, oltre che più vasto, del governo dei corpi, e delle passioni e pulsioni umane”.
Che Gramsci fosse molto più avanti nelle sue analisi del mondo, e della natura del capitalismo, di altri intellettuali e politici del suo tempo, lo dimostra l’aureo saggio di Roberto Franchini intitolato Gramsci e il jazz, che sarà in libreria da fine settembre per le edizioni Bibliotheka. Scrittore e giornalista, autore di vari libri tra cui il notevole L’ultima nota. Musica e musicisti nei lager nazisti (Marietti 1820), nel suo nuovo lavoro parte da poche righe che Gramsci dedicò al jazz, in una lettera, per ragionare non solo sulla musica da “incubo negro” (come la definì il futurista Anton Giulio Bragaglia), ma per parlare di egemonia culturale (quella vera), di cultura di massa, di razzismo, di ribellione giovanile, di passato e presente.
Che cose scrisse sul jazz l’uomo che era stato tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia, che il regime fascista aveva sepolto in un carcere e che i suoi compagni comunisti stalinisti avevano isolato e pressoché abbandonato? Intanto che “questa musica ha veramente conquistato tutto uno strato della popolazione europea colta, ha creato anzi un vero fanatismo”, e che “è impossibile immaginare che la ripetizione continuata dei gesti fisici che i negri fanno intorno ai loro feticci danzando (…) rimangano senza risultati ideologici”.
Gramsci, spiega Franchini, intercettò “la capacità prensile del jazz di fare breccia nei gusti degli europei: musica sì, ma per ballare. Europei, certo, ma di una precisa classe sociale: la borghesia colta e più internazionale”. Però temeva che attraverso il jazz, che peraltro poteva conoscere soltanto marginalmente dalla sua cella di Turi, finisse “per prevalere una cultura elementare e ripetitiva, poco incline alla riflessione, capace di impadronirsi del corpo prima ancora che della mente”. Paventava dunque “una società massificata, consumista, semplificata, meccanizzata, dove il jazz si intreccia con le fabbriche tayloristiche e le città americane popolate di grattacieli”. La società massificata, che oggi possiamo definire come quella globalizzata, è certamente arrivata, ma non per colpa del jazz. Anzi: la musica dei neri è stata non solo occasione di riscatto, ma strumento di lotta per diversi movimenti che quel mondo massificato volevano (e forse vogliono ancora) sovvertire. Gramsci, rammenta Franchini, in quelle poche righe sul jazz aveva intuito “che la possibile ‘rivoluzione’ sarà globale e sarà giovanile, come avverrà, in effetti, altre volte nel secondo dopoguerra”. Ecco la modernità di Gramsci.