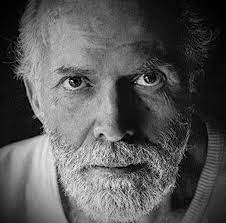
Review | Robert Adams looked past despair and found the truth of America
10 Luglio 2022
La “Distruzione pubblica” e il ridicolo concetto di arte
10 Luglio 2022Il collo di bottiglia
Entra in vigore la riforma del precariato universitario. Ma senza finanziamenti e fondi per la ricerca ogni buona intenzione è destinata a naufragare
Una riforma del precariato universitario. Così si può definire l’insieme di norme approvate dalla Camera nei giorni scorsi ed entrate in vigore il 1 luglio: una serie di misure sicuramente migliorative delle condizioni di lavoro di migliaia di ricercatori e ricercatrici, ma senza liberarle dal loro problema principale, cioè la precarietà.
La trasformazione dell’assegno di ricerca in un vero contratto e l’ampliamento della tenure-track a tutti i ricercatori a tempo determinato sono sicuramente passaggi positivi. A fare la differenza, però, sarebbero congrui investimenti nel reclutamento. Il precariato si accorcia e assume forme dignitose, ma resta la norma, in un’università che sta lentamente provando a ripartire, grazie alle pur limitate risorse stanziate negli ultimi anni, sulle macerie lasciate dal decennio post-Gelmini. Nel frattempo, a valle della riforma, si apre l’assalto alla diligenza, tra docenti che piangono il morto per non avere più a disposizione manodopera a bassissimo costo, e un governo che non accenna a voler aumentare i fondi, ma anzi, surrettiziamente, li taglia. Eppure non dovremmo essere costretti a scegliere tra contratti dignitosi e la possibilità di avere un posto di lavoro: l’università italiana, tuttora sottodimensionata rispetto al resto d’Europa, potrebbe tranquillamente essere potenziata, crescere, diventare una forza decisiva all’interno della nostra società, di fronte a sfide come la pandemia e il cambiamento climatico.
Il precariato universitario dalla Legge Gelmini in poi
Questa riforma viene da lontano. Un intervento sul cosiddetto «pre-ruolo», cioè la giungla di contratti precari con cui è regolato il lavoro della ricerca universitaria, è al centro delle rivendicazioni di sindacati e movimenti da almeno un decennio, per tappare almeno alcune delle falle gigantesche aperte dall’offensiva dell’allora ministra berlusconiana Mariastella Gelmini tra il 2008 e il 2010. Fu letale, allora, il combinato disposto tra la legge 133 del 2008, che tagliava un miliardo e mezzo dalle casse dell’università (una cifra abnorme per i già ristretti bilanci degli atenei italiani), e la legge 240 del 2010, la famosa «riforma Gelmini», che (tra le altre cose) sostituiva i ricercatori di ruolo (lo scalino più basso della carriera universitaria, a cui seguono professori associati e professori ordinari) con due diverse categorie di ricercatori a tempo determinato: quelli di tipo A (rtd-A), cioè con contratto di 3 anni + 2, al termine dei quali il rapporto si chiude, e quelli di tipo B (rtd-B), con un contratto di 3 anni di tipo tenure-track, cioè al termine del quale, sulla base del conseguimento del’Abilitazione Scientifica Nazionale e di una valutazione positiva del lavoro compiuto, arriva la stabilizzazione come professore associato.
Di fatto, in conseguenza dei tagli di cui sopra, nei primi anni post-Gelmini gli atenei bandirono pochissime posizioni rtd-B in sostituzione dei docenti che andavano in pensione, con il risultato di perdere in pochi anni oltre 20 mila posti di lavoro, un quinto dell’intero corpo docente. Una devastazione senza precedenti, che ha avuto ovvie conseguenze su quantità e qualità della ricerca e della didattica, e che negli stessi anni ha bloccato migliaia di persone in un precariato senza fine. Gli anni post-Gelmini, infatti, vedono una proliferazione del cosiddetto «assegno di ricerca», una tipologia contrattuale che non è neanche un vero e proprio rapporto di lavoro, non prevede orari, ferie, malattia, tredicesima, versa pochissimi contributi alla gestione separata Inps e fa percepire al ricercatore circa 1.400 euro al mese. L’assegno di ricerca diventa popolarissimo dopo il 2010 negli atenei italiani, sostanzialmente per due motivi: il primo è che è precarissimo, può durare anche solo un anno, senza dover assicurare alcuno sbocco al termine del rapporto; il secondo è che, non essendo un vero contratto di lavoro, è esente dalla tassazione e quindi agli atenei costa pochissimo. Nel giro di pochi anni, un esercito di migliaia di assegnisti, manodopera a basso costo per i progetti di ricerca (e spesso, impropriamente, per la didattica) dell’università italiana, popola gli atenei, insieme a qualche centinaio di rtd-A (il contratto 3+2 di cui sopra, pagata un po’ meglio e con più tutele) e rarissimi rtd-B.
Il percorso verso il ruolo (e quindi, molto banalmente, potersi stabilire in una città con una certa prospettiva, poter accedere a un mutuo, potersi concentrare sulle proprie ricerche senza l’ansia continua di fare domanda a decine di concorsi ogni mese in vista della scadenza del contratto) diventa lunghissimo: all’uscita del dottorato, la legge Gelmini stabiliva che ognuno potesse fare assegni di ricerca per un massimo di 4 anni, poi prolungato a 6; se si aggiungono 5 di rtd-A e 3 di rtd-B si arriva a 14 anni, anche se la legge stabiliva un tetto massimo di 12, da raggiungere quindi evitando di arrivare al tetto previsto per ogni tipologia. Un purgatorio infinito, passato in gran parte con tipologie contrattuali, come l’assegno, che non prevedevano neanche il sussidio di disoccupazione, fino alla battaglia dal basso che ha portata all’estensione della Dis-Coll agli assegnisti nel 2017, per i periodi di non lavoro, tra un contratto e l’altro.
In tutti questi anni, l’università è rimasta una terra di nessuno in cui non si applicano le normali regole di diritto del lavoro. Mentre le imprese private, dopo 3 anni consecutivi di impiego precario, a certe condizioni, sono obbligate alla stabilizzazione, e mentre la legge Madia del 2015 ha applicato meccanismi simili anche alla pubblica amministrazione, compresi gli enti pubblici di ricerca, l’università è rimasta l’eccezione: si può stare anche 6 anni consecutivi a fare lo stesso lavoro, nello stesso dipartimento, con le stesse mansioni, dimostrando quindi concretamente la natura continuativa di quel rapporto di lavoro, e non solo l’ateneo avrà comunque il diritto di mantenere precario il rapporto: qualsiasi meccanismo di stabilizzazione sarà assolutamente vietato dalla legge. Un’anomalia assoluta nel diritto del lavoro italiano, che è stata interiorizzata e trasformata in una feroce e radicata ideologia del «merito», della «mobilità» e della competizione.
Considerare però la lunghezza del precariato come il suo aspetto peggiore, come molti dei cantori della nuova riforma hanno fatto in questi giorni sui media, rischia di essere fuorviante. Non si tratta semplicemente di un purgatorio ma di un processo costantemente selettivo e competitivo, che a ogni passaggio taglia fuori qualcuno dai continui colli di bottiglia che si formano. Il problema non è tanto che si resta precari a lungo, ma che a un certo punto si smette di esserlo perché si finisce, per carenza di risorse, espulsi dal sistema. Migliaia di persone in questi anni si sono trovate o a vivere ai margini del lavoro universitario, attraverso tipologie ancora peggiori rispetto all’assegno (co.co.co., co.co.pro., borse di ricerca, docenze a contratto), compreso il lavoro gratuito per ingraziarsi l’istituzione in attesa di concorsi futuri, o a lasciare del tutto il sistema. Un lungo collo di bottiglia, quindi, che seleziona i pochissimi che arriveranno a un posto di ruolo, mentre gli altri man mano, pur lavorando, pubblicando, insegnando, spariscono dagli uffici da un giorno all’altro, cambiano mestiere, cambiano paese, vengono sacrificati sull’altare della carenza cronica di risorse e, quindi, del numero esiguo di posti tenure-track banditi.
Una novità positiva, in questo senso è arrivata dal 2016 in poi, con una serie di piani straordinari per il reclutamento di rtd-B messi in campo con numeri relativamente esigui dai governi Renzi, Gentiloni e Conte 1, e poi con risorse più massicce, in piena pandemia, da parte del Conte 2. Il piano più significativo, quello appunto varato dal governo Conte 2 nella primavera 2020, ha fornito le risorse per 5.000 posti: niente rispetto ai 20 mila persi nel decennio precedente, ma di sicuro una boccata d’ossigeno per atenei strutturalmente a corto di personale (l’Italia ha il terzo rapporto studenti/docenti più alto d’Europa) e per una parte consistente, seppur minoritaria, di una generazione di precari. Ovviamente si è trattato di misure una tantum, senza una reale programmazione del reclutamento negli anni commisurata al fabbisogno e quantomeno alla sostituzione di chi va in pensione.
Contemporaneamente, nel corso di questa legislatura, si è iniziato a parlare sempre più insistentemente di una «riforma del pre-ruolo», cioè del precariato universitario. La piattaforma «Ricercatori Determinati» lanciata da Flc-Cgil e Adi (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) nel 2018, in particolare, girava intorno a quattro rivendicazioni principali: la stabilizzazione dei precari che hanno tenuto in piedi l’università negli anni post-Gelmini; un sistema di reclutamento ordinato e ciclico, fuori dalle una tantum e dai piani straordinari; una riforma del reclutamento che arrivasse a una figura unica pre-ruolo, con diritti e tutele; e finanziamenti in grado quantomeno di restituire quanto sottratto nell’ultimo decennio e rilanciare l’università italiana.
Nel corso della legislatura, diversi parlamentari hanno proposto disegni di legge sul tema del pre-ruolo (ignorando le altre tre rivendicazioni di ricercatori e ricercatrici), in particolare nel Movimento Cinque Stelle e nel Partito Democratico. Per anni si è lavorato, nelle commissioni istruzione di Camera e Senato, con audizioni, interlocuzioni, assemblee, sfociate in un testo unificato partorito lo scorso anno e ormai svuotato di ogni contenuto innovativo, tanto da rischiare di essere addirittura peggiorativo rispetto alla disastrosa situazione esistente.
La riforma del precariato universitario: cosa cambia
È a quel punto che è intervenuta la ministra dell’università Maria Cristina Messa, ex rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, perfettamente interna ai meccanismi dell’università neoliberista e attenta conoscitrice del sistema che è chiamata a governare. Sotto la sua egida, il senatore Pd Francesco Verducci ha proposto una serie di emendamenti alla legge di conversione di un decreto legato al Pnrr, rapidamente approvati da Senato e Camera. La riforma del pre-ruolo, o, in termini più onesti, la riforma del precariato universitario, contenuta in questi 24 commi, raccoglie molte delle idee e delle rivendicazioni emerse dal basso in questi anni, seppur non cambiando l’impianto generale dell’università post-Gelmini. I punti centrali sono sostanzialmente quattro, tutti generalmente migliorativi rispetto al presente, anche se, come vedremo, non mancano i rischi e le questioni aperte.
Il primo elemento di novità è l’abolizione dell’assegno di ricerca, sostituito con un «contratto di ricerca» che è, finalmente, un vero rapporto di lavoro subordinato, per quanto a tempo determinato. Un contratto vero, con i contributi, la tredicesima, e una retribuzione demandata alla contrattazione collettiva (una novità interessante, dato che ricerca e docenza universitaria sono invece generalmente escluse dalla contrattazione) ma che comunque non può essere inferiore a quella dei ricercatori a tempo indeterminato part-time pre-Gelmini (a occhio e croce, il netto mensile minimo dovrebbe aggirarsi sui 1.500 euro). Cambia anche la durata minima del contratto, non più annuale come l’assegno ma biennale, rinnovabile poi per un altro biennio (o per un anno, nel caso sia finanziato da progetti di ricerca di durata triennale), fino a un massimo di 5 anni totali, anche tra più atenei. Cambiano inoltre i requisiti d’accesso, rendendo obbligatorio il dottorato. In generale, si trasforma l’assegno di ricerca in un vero contratto di ricerca post-doc come quelli presenti nel resto d’Europa, con una retribuzione più dignitosa, contributi e tutele. Resta, chiaramente, un contratto precario che non dà alcuna garanzia di sbocchi futuri.
La seconda novità è l’abolizione di rtd-A e rtd-B, sostituiti da un’unica tipologia di ricercatore a tempo determinato (rtd), con tutte le caratteristiche principali dell’rtd-B, cioè la tenure-track che permette, previa abilitazione e valutazione, il passaggio in ruolo a professore associato, e la retribuzione, tranne la durata: il nuovo rtd durerà 6 anni, ma a partire dal terzo si potrà già chiedere il passaggio in ruolo. Molto si è discusso di questa lunga durata del nuovo rtd, che rischia effettivamente di vanificare l’obiettivo di accorciamento del precariato che la riforma si pone. Il problema è, però, che anticipando il momento della tenure-track, aumenta il rischio che il ricercatore o la ricercatrice non abbiano ancora conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (meccanismo a tratti perverso che meriterebbe un altro approfondimento). Lasciare la possibilità, se per caso non la si raggiunge in 3 anni, di continuare a lavorare per altri 3 prima del momento finale della valutazione, dovrebbe essere una tutela sufficiente in questo senso.
La terza innovazione introdotta dalla legge è la figura del «tecnologo a tempo indeterminato», tipica finora degli enti pubblici di ricerca. È davvero presto per capire come funzionerà a regime, ma già il fatto di veder tornare all’interno dell’università una figura di ricerca, senza compiti didattici, a tempo indeterminato, a 12 anni dalla riforma Gelmini e dalla conseguente messa a esaurimento del ruolo dei ricercatori, va apprezzato. Così come va apprezzato il fatto che si tratti di una figura inquadrata, come il contratto di ricerca, nella contrattazione collettiva: si aprono spiragli di contrattazione nel mondo corporativo dell’università.
Infine, la riforma prevede, una volta tanto, norme transitorie che tutelano almeno in parte i precari e le precarie di oggi, sempre a rischio di finire triturati da un nuovo processo di riforma. Per prima cosa, per i prossimi 3 anni, il 25% dei concorsi per i nuovi rtd banditi in ogni ateneo dovrà essere riservato a chi ha fatto un rtd-A o 3 anni di assegno. Inoltre, sempre per i prossimi 3 anni, gli rtd-A o assegnisti da almeno 3 anni che vinceranno un posto da rtd, saranno inquadrati rispettivamente al quarto e al terzo dei 6 anni previsti, accorciando il periodo di precariato.
Il collo di bottiglia si accorcia, ma non si allarga
Nonostante questi indubbi miglioramenti, che riprendono alcune delle proposte emerse da un decennio di mobilitazioni, sempre di una riforma del precariato universitario si tratta, e non di un suo superamento. La legge lascia aperte questioni centrali per la vita degli atenei e di chi ci lavora, e addirittura ne apre di nuove.
Per prima cosa, l’abolizione dell’assegno di ricerca e dell’rtd-A, cioè delle due forme di contratto precario più comuni nell’università, non significa l’abolizione del precariato. Oltre al nuovo rtd con tenure-track, infatti, resteranno in vigore borse di ricerca e co.co.co, per non parlare delle docenze a contratto. Ovviamente ci sono anche buone ragioni per non vietare qualsiasi forma di contratto breve, in un mondo in cui esistono anche esigenze puntuali e microprogetti. Ma è evidente che queste forme andrebbero, se non completamente eliminate, quantomeno regolate in termini molto restrittivi. Il rischio che, ora che non esiste più l’assegno, si finisca in qualche modo per abusare delle altre forme precarie esistenti è concreto, e merita attenzione e mobilitazione.
In secondo luogo, le misure transitorie presenti, pur apprezzabili, rischiano di non essere sufficienti a permettere il passaggio al nuovo sistema a tutti quelli che da anni lavorano nell’università con contratti precari. Gli atenei hanno appena assunto, negli ultimi mesi del 2021, migliaia di rtd-A di 3 anni per progetti «speciali» legati al Pnrr in collaborazione con le aziende, senza alcuno sbocco successivo. Basterà davvero quella quota del 25% ad assorbirli? Per non parlare del fatto che la stessa riforma dà agli atenei la possibilità di bandire nuovi rtd-A dello stesso tipo per i prossimi 3 anni: continuiamo a reclutare un esercito di precari anche nella stessa riforma in cui abroghiamo quella figura precaria. Il rischio è che, in questo processo, molta gente si faccia parecchio male, restando triturata nel meccanismo di passaggio dal vecchio al nuovo regime.
In terzo luogo, e qui ci si addentra in dettagli tecnici che però possono fare la differenza, il meccanismo di tenure-track resta altrettanto nebuloso quanto quello previsto dalla legge Gelmini. Normalmente, in altri paesi, la tenure-track è un meccanismo di valutazione puramente scientifica: il ricercatore è stato assunto con determinati obiettivi e indicatori, si verifica che li abbia raggiunti facendo con successo il proprio lavoro di didattica e ricerca, ne consegue la stabilizzazione, senza che alcun criterio di bilancio entri nell’equazione. La legge Gelmini, invece, prevedeva che la valutazione tesa al passaggio in ruolo, fosse subordinata alla presenza di «risorse disponibili per la programmazione», pur stabilendo che questa programmazione dovesse assicurare «la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione». Una formulazione, ripresa pari pari dalla nuova legge, potenzialmente ambigua, i cui rischi di interpretazione ai danni di ricercatori e ricercatrici potrebbero crescere, ora che la tenure-track diventa lunga 6 anni (mentre la programmazione degli atenei è triennale) e che il venir meno della distinzione tra rtd-A e rtd-B potrebbe scoraggiare gli atenei dal pensare il nuovo rtd come una figura destinata fondamentalmente alla stabilizzazione in ruolo. In un mondo come quello dell’università italiana, e con lo squilibrio di potere che il precariato implica, meno margini di discrezionalità ci sono, e più la valutazione avviene su criteri trasparenti, universali e predeterminati, meno si rischia l’arbitrio sulla pelle di precari e precarie.
Infine, e questo ovviamente è il punto maggiormente critico, resta aperta la gigantesca questione del finanziamento dell’università. La riforma non dice una parola su questo (se non, come vedremo, in negativo) e non prevede affatto quel «reclutamento ordinato e ciclico» che ricercatori e ricercatrici rivendicavano. Il numero di concorsi per rtd che sarà bandito dagli atenei resta un mistero da svelare ogni autunno, leggendo nelle pieghe della legge di stabilità quanto consistente sarà l’Ffo (fondo per il finanziamento ordinario) che il governo darà alle università, e se ci saranno risorse supplementari, attraverso i famosi piani straordinari, per il reclutamento. Il numero di persone assunte all’università continuerà a essere indipendente dal fabbisogno in termini di ricerca e didattica, o anche semplicemente dal turnover con i pensionati, dipendendo invece semplicemente dalle effimere scelte di bilancio del governo di turno. Se a ciò si aggiungono le perversioni della suddivisione dell’Ffo secondo criteri di «premialità» introdotte nel decennio post-Gelmini, in particolare in termini di squilibri nord-sud, il panorama non è roseo.
Come si diceva prima, il precariato universitario è un collo di bottiglia che pochissimi riescono ad attraversare. Accorciarlo, com’è stato fatto, è sicuramente positivo, ma il problema principale resta il diametro, e questa riforma non lo allarga in alcun modo. I precari e le precarie avranno più tutele e retribuzioni più degne, ma continueranno a essere costretti in gran parte a scegliere se emigrare o cambiare mestiere, pur in un’università pesantemente sotto organico, che ha materialmente bisogno ogni giorno del loro lavoro.
A ciò si aggiunge un tema creato dalla stessa riforma. Come si diceva prima, uno dei motivi del successo degli assegni di ricerca era l’esenzione dalle tasse, che li rendeva incredibilmente economici per gli atenei, riducendo al minimo il famoso «cuneo fiscale» tra il «lordo ente» che l’università spende e il netto in busta paga. Ciò ha permesso per anni all’università italiana di bandire migliaia di assegni a costi bassissimi. In particolare in occasione di progetti europei, gli atenei italiani hanno sempre potuto assumere, a parità di budget, un numero di collaboratori ben maggiore di quello dei partner stranieri. Una volta che si passa al nuovo «contratto di ricerca», che invece prevede che si paghino contributi previdenziali e soprattutto tasse come in qualsiasi altro rapporto di lavoro, però, il giochino rischia di saltare. A parità di posti di lavoro, e con un aumento limitato di retribuzione per i post-doc, il costo per gli atenei dovrebbe aumentare del 30-40%.
Mercoledì scorso un editoriale de La Stampa firmato da Antonella Viola e Stefano Piccolo, entrambi ordinari di medicina a Padova, ha denunciato la questione, ovviamente dal punto di vista dei docenti più potenti. L’articolo è pregno di ideologia della precarietà, denunciando l’introduzione di un normale contratto di lavoro, per di più precario, come qualcosa che «ingesserà» la ricerca in un percorso «irreggimentato» e «blindato», addirittura «garantendo loro un ‘posto fisso’ prima che abbiano potuto dimostrare quanto valgono». Dove abbiano visto Viola e Piccolo il «posto fisso» in questa riforma non è dato sapere, e sorprende che due scienziati del loro valore sbaglino così clamorosamente i numeri (sovrastimando a 52 mila euro all’anno il costo dei nuovi contratti, che invece dovrebbe aggirarsi tra i 37 e i 40 mila, contro gli attuali 25 mila dell’assegno) e inventino addirittura che «per i vincitori dei progetti di eccellenza del Consiglio Europeo delle Ricerche (Erc) reclutare ricercatori non sarà semplice», quando i vincitori di bandi Erc reclutano tranquillamente ricercatori in tutta Europa con costi ben maggiori di quelli previsti dalla riforma. L’impressione è che una certa parte della docenza universitaria italiana si sia trovata molto a proprio agio avendo a disposizione una forma contrattuale ultraprecaria a bassissimo costo, in deroga non solo al diritto del lavoro italiano ma anche alla normalità dell’università europea, e veda con orrore la sua fine. Un po’ come le aziende del food delivery che minacciavano la chiusura di fronte al «decreto dignità» e all’apparizione di pur limitate tutele per i rider.
Questo piano di discorso è, appunto, pregno di ideologia della precarietà e va quindi rigettato senza ambiguità. Ciò non significa, però, che la trasformazione dell’assegno di ricerca in contratto non ponga davvero il tema dei finanziamenti. A guardarlo bene, sarebbe facilmente risolvibile: dato che la parte più sostanziosa dell’aumento del costo dei nuovi contratti sarà costituita da tasse, e cioè quindi da soldi in più che lo stato incasserà dagli atenei, logica vorrebbe che quelle risorse venissero poi ridestinate dallo stato alle università, in modo da garantire di poter fare più contratti. Ma la logica e la finanza pubblica raramente vanno di pari passo, e la riforma stessa prevede (grazie a un’aggiunta dell’ultimo secondo della proverbiale «manina») che la spesa complessiva per l’attribuzione dei nuovi contratti di ricerca non possa «essere superiore alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati». Cioè: per i nuovi contratti, più costosi, non si potrà spendere più che per i vecchi assegni. Tradotto: si dovranno fare molti meno contratti di quanti assegni si facevano. E dato che la differenza in termini di costo deriva in gran parte dalla tassazione, lo stato da questa manovra risparmierà un bel po’ di quattrini. Una riforma del precariato universitario non solo a costo zero: addirittura in attivo di bilancio.
È evidente che contro lo scoglio del finanziamento si vadano a schiantare tutte le buone intenzioni e tante delle innovazioni positive introdotte da questa riforma. Il punto non è, come sostengono Viola e Piccolo, che ricercatori e ricercatrici debbano restare sfruttati e precari altrimenti il sistema non si può permettere di andare avanti. Il punto è che il rafforzamento di tutele e retribuzioni di lavoratori e lavoratrici dell’università deve andare di pari passo con il potenziamento di un sistema universitario che è, va ripetuto, profondamente sottodimensionato. Un sistema in cui, secondo i dati Ocse, ci sono 20 studenti per ogni docente, contro i 15 della media europea, i 12 della Germania, i 10 della Svezia e i 9 della Norvegia.
Le due battaglie vanno di pari passo: quella per l’uscita dalla precarietà del lavoro universitario, che registra questa forma un parziale passo in avanti, deve continuare, insieme a quella per il rilancio del sistema universitario, da mettere al servizio, negli anni della pandemia e dell’emergenza climatica, delle trasformazioni profondissime che presente e futuro ci impongono.
*Lorenzo Zamponi, ricercatore in sociologia, si occupa di movimenti sociali e partecipazione politica. È coautore di Resistere alla crisi (Il Mulino)





