
Piancastagnaio, ’pace’ con Estra clima
19 Ottobre 2025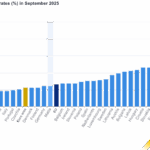
Digest strategico per oggi (20 ottobre 2025)
20 Ottobre 2025
di Pierluigi Piccini
Oggi abbiamo ascoltato parole giuste su Gabriello Picconi, sulla sua poesia e sulla sua vita.
Non voglio aggiungere altro su di lui, ma guardare un po’ più intorno.
Perché Picconi non è stato un caso isolato.
È parte di una generazione di uomini e donne che, tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento, hanno dato forma al carattere civile di Piancastagnaio.
Attorno a lui c’era un mondo che non parlava dai palchi, ma lavorava, scriveva, insegnava, aiutava gli altri.
C’erano poeti come Dante Cappelletti, che usava l’ironia per dire la verità senza alzare la voce.
C’erano maestri come Mario Martelli, che portavano la scuola nelle campagne e credevano nell’istruzione come diritto, non come privilegio.
C’erano donne come Giuseppina Rossi, impegnate nelle cooperative agricole del dopoguerra, quando la terra cominciava a cambiare padroni ma non ancora destino.
C’erano sacerdoti come don Enrico Bargagli, che negli anni più difficili provarono a tenere insieme fede e giustizia.
E c’erano artigiani e giovani come Pietro Fabbri e Antonio Baldanzi, che misero il proprio lavoro e la propria vita al servizio della libertà.
Accanto a loro, agivano educatori e intellettuali pianesi che seppero trasformare la conoscenza in una forma di riscatto collettivo.
Domenico Bassi, barnabita e pedagogista, credeva che l’educazione fosse il modo più alto per elevare la dignità di chi nasceva con poco.
Giuseppe Fatini, preside e studioso, insegnava che la cultura non è un lusso, ma un dovere verso sé stessi e verso la comunità.
Giuseppe Cortini, professore di latino e greco, portava l’amore per le lettere classiche tra i figli di contadini e artigiani.
Carmela Cortini, sua figlia, fu la prima donna laureata in Scienze Naturali all’Università di Firenze: divenne una scienziata di fama internazionale, portando nel mondo la precisione e la tenacia apprese in una casa dove lo studio era un atto di libertà.
Enea Piccinelli, avvocato e uomo delle istituzioni, unì l’impegno civile alla formazione delle giovani generazioni, continuando quell’idea di cultura come servizio pubblico.
In ognuno di loro c’è una storia di classe e di coscienza: la consapevolezza che la cultura non appartiene a chi comanda, ma a chi la usa per capire, per migliorare, per costruire giustizia.
Erano figli di un paese povero, ma non rassegnato.
E hanno saputo fare della scuola, della parola e del lavoro strumenti di libertà.
Vorrei aggiungere, a questo ritratto collettivo, un elemento che ci aiuta a comprendere meglio anche la figura di Gabriello Picconi.
C’è una differenza profonda tra le comunità nate dalla mezzadria, come Siena, e quelle nate dal bracciantato, come Piancastagnaio.
Una differenza economica, ma anche morale e culturale.
A Siena, la mezzadria ha generato una visione del mondo più legata alla terra condivisa, a un equilibrio — talvolta precario — tra padrone e contadino. Una relazione che si riflette anche nella letteratura: basti pensare alle Tre Croci di Federigo Tozzi, dove la fatica, la solitudine e il destino familiare diventano metafora di un’intera condizione sociale.
A Piancastagnaio, invece, il mondo dei braccianti ha dato origine a una coscienza diversa: più aspra, più radicale, ma anche più libera. È in questo contesto che Gabriello Picconi, come segretario del movimento contadino, immaginò l’emancipazione dei contadini da se stessi, la conquista della dignità attraverso il lavoro, l’educazione e la parola.
Un percorso che si muove tra la Rerum Novarum e il nascente socialismo delle campagne, dove il riscatto non era solo economico, ma anche morale e umano.
Un’eredità che ha lasciato un segno profondo nella nostra storia e che appartiene a tutta la collettività pianese, al di là delle differenze politiche — che è naturale che esistano, ma che non devono mai cancellare il valore comune di quella conquista civile.
Quando dedichiamo la piazza che stiamo dedicando al Poeta, ricordiamo anche loro.
Ricordiamo un tempo in cui la parola e l’azione andavano insieme, e in cui la poesia poteva nascere da un campo o da un banco di scuola.
Oggi quella eredità ci riguarda da vicino.
Perché una comunità che riconosce il valore dei suoi poeti, dei suoi maestri, dei suoi lavoratori e dei suoi resistenti è una comunità che sa chi è e dove vuole andare.
Il compito della cultura è proprio questo: non mettere le persone su un piedistallo, ma tenerle in dialogo con il presente.
Per questo la piazza che stiamo dedicando al Poeta non è solo un luogo di memoria.
È anche un invito a non perdere il filo tra la nostra storia e il nostro futuro.
A ricordare che la libertà, la dignità e la cultura non sono conquiste acquisite una volta per tutte, ma impegni quotidiani che ciascuno di noi è chiamato a rinnovare.




