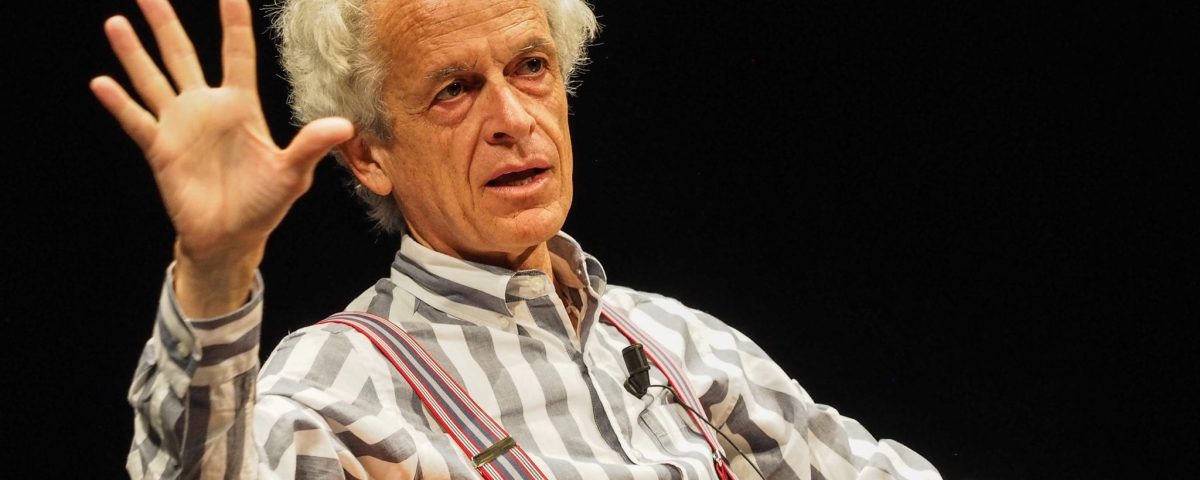Come il primo giorno di scuola
5 Dicembre 2022
Schlein rompe gli indugi: “Mi candido a segretaria, il Pd va ricostruito”
5 Dicembre 2022
di Federico Rampini
Nove mesi di guerra hanno rafforzato in Occidente il progetto di ridurre la nostra dipendenza economica da potenze antagoniste o rivali come Russia e Cina. L’idea che sia urgente riportare vicino a casa nostra molte produzioni strategiche si era già affermata durante la pandemia. Prima ancora, un clima da guerra fredda era all’ordine del giorno dall’inizio della escalation dei dazi fra Donald Trump e Xi Jinping (proseguita con Joe Biden). Di fatto è da cinque anni che una sorta di de-globalizzazione figura nell’agenda dei governi occidentali e delle nostre aziende multinazionali. Quali sono i risultati concreti, e quanta parte della rilocalizzazione può realisticamente beneficiare l’Europa, l’Italia? Il trentennio della globalizzazione ruggente fece molti perdenti nei Paesi ricchi, smantellando intere industrie e sventrando la classe operaia. Se è iniziato un percorso inverso, ci sono opportunità da raccogliere? La globalizzazione non è mai stata un fatto «naturale», il Novecento vide alte e basse maree nell’apertura delle frontiere e nella liberalizzazione degli scambi. Ma i passaggi da una fase all’altra non furono indolori. Che un divorzio dalla Cina sia all’ordine del giorno, lo conferma un’azienda simbolo del nostro tempo: Apple. Il gigante tecnologico ha sede a Cupertino nella Silicon Valley californiana ma fabbrica in Cina fino all’85% degli iPhone più recenti. Ora il suo top management vuole adeguarsi ai nuovi scenari geopolitici.
Riporterà qualche attività in America, ma il grosso della produzione vuole redistribuirla tra Paesi emergenti meno antagonisti della Cina. L’obiettivo è avere il 45% della produzione in India e Vietnam, entro una data da definire. Come Apple altre imprese si stanno adattando, il «friendshoring» o globalizzazione fra amici è entrato nei dibattiti dei consigli d’amministrazione. Non è facile però sostituire la più grande classe operaia del mondo. I cinesi nel trentennio della loro simbiosi produttiva con l’Occidente si sono guadagnati la fiducia di tante multinazionali, non solo per i salari bassi (che nel frattempo sono cresciuti). Il miracolo cinese ha avuto vari ingredienti: qualità e disciplina della manodopera e degli ingegneri; flessibilità e capacità di adattamento; una formidabile logistica appoggiata su infrastrutture moderne per raggiungere in tempi record i clienti di quattro continenti. Sono capacità che non s’improvvisano altrove, di certo non in un Paese afflitto da una pessima burocrazia come l’India, o nel Vietnam che ha appena un decimo della popolazione cinese. Inoltre se davvero inizia una ritirata di multinazionali dalla Repubblica Popolare, il governo di Pechino non starà a guardare. La fabbrica Apple è stata di recente elogiata dal Quotidiano del Popolo (organo del partito comunista) come un gioiello di efficienza che genera un milione di posti di lavoro nell’indotto. Prima di lasciar partire Apple è probabile che le autorità locali sfoderino una campagna di seduzione a base di agevolazioni e incentivi. Se per noi la dipendenza dalla Cina è diventata un pericolo, per Xi Jinping è l’esatto contrario: un’arma di pressione sull’Occidente a cui non rinuncerà facilmente.
Nell’ultimo biennio una reindustrializzazione dell’America è cominciata. I numeri sono ancora piccoli, ogni anno fra i trecentomila e i trecentocinquantamila posti di lavoro «tornano a casa», rispetto a una stima dai sei ai dieci milioni di posti che sparirono in Cina o in Messico durante il trentennio aureo della globalizzazione. Questa tendenza a rilocalizzare produzioni sul suolo Usa potrebbe proseguire e perfino accelerare nell’attuale clima dove gli imperativi di sicurezza nazionale guadagnano terreno. Il guaio per l’Europa, è che l’America gode di almeno tre vantaggi competitivi: ha una pressione fiscale più bassa; ha energia abbondante in casa propria e quindi costi dell’elettricità inferiori; ora si è data una politica industriale aggressiva a base di generosi aiuti di Stato. Quest’ultimo tema è stato affrontato da Emmanuel Macron nel suo recente incontro con Joe Biden alla Casa Bianca, perché è un tasto dolente: la politica industriale americana oltre a elargire sovvenzioni ha un segno protezionista. Ursula von der Leyen ha confermato questo allarme europeo. Nei due settori dove Washington è prodiga di sussidi pubblici, cioè i semiconduttori e l’auto elettrica, ci sono multinazionali europee che stanno decidendo di aprire nuovi stabilimenti sul territorio Usa, sia per farsi finanziare dal contribuente americano, sia per ripararsi dalle clausole protezioniste. L’America sopravanza l’Europa anche nella costruzione di catene di approvvigionamento sicure in settori strategici come i minerali rari. L’Europa rischia di avviarsi a una transizione «green» schiava delle forniture cinesi (pannelli solari, auto elettriche) e quindi della benevolenza di chi governa a Pechino; gli Stati Uniti vorrebbero scongiurare questo scenario. La corsa di Biden verso una ricostruzione dell’industria nazionale dei semiconduttori è una polizza assicurativa nell’eventualità che Xi invada Taiwan.
Un tema che vede America ed Europa altrettanto impreparate, è il ruolo dei Paesi terzi, i non allineati. La nuova geografia della globalizzazione deve includere un ruolo maggiore per potenze emergenti come l’India, l’Indonesia, le nazioni sudamericane e africane. Per molti di questi Paesi però la Cina è il partner economico numero uno. In un recente viaggio in Brasile ho avuto conferma che il prossimo governo Lula sarà condizionato da questo dato: «occidentale» dal punto di vista geografico, in realtà il Brasile da molto tempo è nell’orbita cinese. Al prossimo capitolo della globalizzazione noi arriviamo con una strategia delle alleanze incompleta. Un’altra incognita della nuova globalizzazione riguarda la nostra effettiva disponibilità ad accoglierne i benefici. Nel trentennio delle delocalizzazioni l’Occidente non ha soltanto cercato di sfruttare la manodopera a buon mercato dei Paesi emergenti. Abbiamo marginalizzato la cultura operaia al nostro interno; per una maggioranza di giovani le professioni operaie e tecniche non sono un’opzione. Abbiamo preso le distanze da ogni attività accusata di sporcare il Pianeta, cioè in sostanza da ogni industria estrattiva o manifatturiera. Se non vogliamo che nella nuova globalizzazione «tra amici e alleati» i beneficiari siano soltanto Paesi come l’India e il Vietnam, questo nodo andrà affrontato: vogliamo ancora essere una nazione industriale?