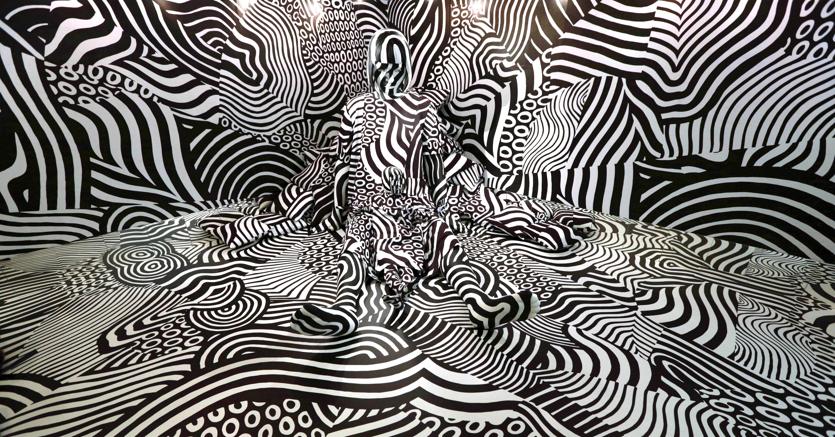News, press
15 Settembre 2022
Il (verde) granaio di Roma
15 Settembre 2022In certi ambienti di sinistra radicale è quasi d’obbligo evocare la complessità. Poi, quando sulla complessità si batte il muso, l’esigenza di schierarsi e di semplificare tradisce spesso i buoni propositi. Ora, poiché schierarsi e semplificare sono operazioni indispensabili, bisognerà pure trovare qualche pratica per non tradire oltre un certo limite. Una complessità non elaborata è probabilmente la ragione principale di una discussione sulla guerra in Ucraina che ha avuto come primo effetto quello di paralizzare il potenziale di movimento e di lotta che si era espresso subito dopo l’invasione di Putin con un’affollatissima manifestazione a Milano. Le domande su cui si sono arenate le potenzialità di movimento, che in altre occasioni in Italia è stato immenso, sono in sé stesse semplici. Manifestare per che cosa e con chi? Può forse aiutare a rispondere reintrodurre nella discussione qualche briciola di complessità almeno su un tema: il rapporto tra il diritto all’autodeterminazione e i contesti politici e geopolitici.
Marxismo e autodeterminazione
Nel movimento operaio di cultura marxista c’è stata per un secolo una discussione sulla questione nazionale che oggi sembra dimenticata. Un movimento internazionalista dalla sua nascita ebbe l’intelligenza di capire che i nazionalismi non sono tutti uguali. Marx osservò che la borghesia inglese si era servita della miseria irlandese per dividere i lavoratori in due campi in concorrenza e nemici. Marcello Musto ricorda che Marx si era spinto anche più in là, quando aveva corretto la sua posizione a favore dell’importanza decisiva della questione nazionale per la rivoluzione. Per lungo tempo aveva creduto che fosse possibile risolvere la questione irlandese con l’ascesa della classe operaia inglese. Poi aveva rovesciato la sua posizione e pensato che la classe operaia inglese non avrebbe mai combinato nulla di decisivo se la questione che divideva la classe non fosse stata risolta. Lenin riconobbe all’Ucraina il diritto di decidere se e quando unirsi alla Russia e Putin ha riconosciuto a Lenin la sua coerenza di marxista, quando gli ha attribuito la responsabilità dell’esistenza dell’Ucraina moderna. Dopo la Seconda guerra mondiale la rivolta dei popoli colonizzati in Asia e in Africa (in modo particolare in Indocina e in Algeria) conquistò un tale prestigio che il femminismo assunse il termine «autodeterminazione» per designare il diritto delle donne a decidere del proprio corpo.
L’autodeterminazione nella vicenda del movimento operaio di cultura marxista non è mai stata né un dogma né un valore assoluto ma una variabile dipendente dalla lotta di classe e dal contesto storico e geopolitico.
Marx pensava alle divisioni tra lavoratori in Inghilterra nei termini di un sostegno della classe operaia inglese all’emancipazione nazionale dell’Irlanda. La «primavera dei popoli» (la rivoluzione europea del 1848) era alle sue spalle ma esercitava ancora forti suggestioni e lotte di classe e per l’indipendenza nazionale spesso convivevano nelle stesse forme organizzative.
Rosa Luxemburg fu fieramente avversa al concetto stesso, certo sbagliando ma anche perché guardava il mondo da uno specifico angolo di visuale. Lei ebrea polacca, «cosmopolita senza radici», conosceva bene la carica reazionaria del nazionalismo polacco e vedeva in primo piano qualcosa che per altri in quel momento restava sullo sfondo. Il qualcosa balzò in primo piano due decenni dopo l’assassinio di Rosa. Il nazionalismo di una nazionalità oppressa vicina alla Polonia (proprio l’Ucraina), radicalizzato da una lotta troppo lunga e periodicamente frustrata, aveva già prodotto prima dell’invasione nazista un antisemitismo senza uguali in Europa. Quando i nazisti invasero il suo paese, quel nazionalismo si illuse di poter usare Hitler contro Stalin prima di rendersi conto di essere caduto dalla padella alla brace. Si riscattò dando alla resistenza antinazista un grande contributo di sangue, che non cancellava comunque il sangue degli ebrei che aveva contribuito a massacrare con l’alleato tedesco.
Lenin, durante la Prima guerra mondiale, esaminò le tendenze imperialiste del capitale finanziario ma poi fu costretto a misurarsi con la sgradita eredità del vecchio imperialismo zarista. Anche perché, come disse Trotsky, la rivoluzione non cambia la geografia. Il contesto però era radicalmente cambiato. La Russia non era più l’impero dello zar ma la roccaforte della rivoluzione. La Polonia non era più il paese minacciato da un impero vicino ma una delle nazioni che aggrediscono la giovane rivoluzione. In quel contesto i bolscevichi contraddissero le loro ferme e radicate convinzioni, inseguendo i nemici fin nel cuore della Polonia. Con il senno di poi, si può dire che anche in questo caso la scelta sia stata discutibile ma di quel tempo si capisce poco, se non si tiene conto che in quel momento le scelte erano dominate dall’idea che il mondo si divideva ormai in rivoluzionari e controrivoluzionari in un confronto decisivo imminente.
Quando Hitler rivendica territori e popolazioni di lingua tedesca strappati alla Germania sconfitta nella Prima guerra mondiale, in qualche caso si potrebbe davvero porre un problema di autodeterminazione. Ma è evidente che in quel contesto concedere ragioni a Hitler era la peggiore delle scelte, come sa chi conosce il seguito della storia.
Il nazionalismo degli oppressi fa poi strani giochi di prestigio. Pensiamo per esempio al sionismo verso il quale si poteva anche essere indulgenti, malgrado la sua narrazione regressiva, prima della Shoah anche agli occhi della stragrande maggioranza degli ebrei. Ma il senso politico di quel mito nazionalista si rovescia nel suo contrario, quando si trasforma in giustificazione di un’oppressione e del presunto diritto a uno «spazio vitale».
Tutto questo non rende meno valido il concetto di autodeterminazione ma ne fa nello stesso tempo un diritto democratico irrinunciabile e qualcosa di legato a un contesto e che non si trasforma in pratiche e precetti validi in eterno.
La metà non è l’intero
Nelle difficoltà che ha la sinistra radicale a orientarsi ci sono anche il fantasma del neo-stalinismo degli anni Settanta e incomprensioni che resistono a ogni prova della storia, come se questa fosse un’illusione ottica provocata dal nemico. Ma non c’è solo un certo filoputinismo ad allontanare la possibilità di capire, c’è anche un modo di essere solidali con l’Ucraina che contribuisce alla paralisi. È con questo che vale la pena di continuare a discutere e non con chi confonde l’armata russa con l’armata rossa. Nel nobile tentativo di mantenere ben fermi i riflettori sulle sofferenze del popolo ucraino e sulla natura dell’aggressione e dell’aggressore rifiuta ogni riferimento all’Occidente, agli Stati uniti e alla Nato. Affermare che gli Usa non sono migliori di Putin significherebbe assolverlo e deviare all’attenzione sull’Iraq e sull’Afghanistan invece che sull’Ucraina. Attribuire agli Stati uniti e a Zelensky una mancanza di volontà di trattare vorrebbe dire che invece Putin sarebbe interessato a una soluzione diplomatica. Ammettere che la Russia sia stata minacciata dalla Nato trasformerebbe Putin in una vittima, facendo dimenticare chi è la vera vittima e chi invece l’autentico l’aggressore. Non si può giurare che questi rischi non esistano, anche se possono essere affrontati sul piano della comunicazione. Il rovescio della medaglia è ben più grave ed è quello di non poter descrivere un contesto amputato già in anticipo della sua metà e finire con il credere che la metà sia l’intero.
Tutte le principali guerre in questo periodo della storia sono anche interimperialiste. D’accordo. L’affermazione però viene fatta per dire che in sé questo aspetto dei conflitti del presente non è significativo, è un’ovvietà il cui effetto è solo quello di allontanare i riflettori dall’aggressione di Putin. È vero che tutte le principali guerre di questa fase della storia sono interimperialiste, ma non lo sono tutte nella stessa misura. Lo spessore della componente di conflitto interimperialista cambia secondo gli eventi, è mutevole e non è immediatamente visibile.
Taras Bilous del Movimento Socialista d’Ucraina, in un appello alla sinistra occidentale per invitarla a sostenere la richiesta di aiuto militare, usa tra gli argomenti una domanda: quando il mondo è stato così vicino a una guerra nucleare? L’interrogativa è retorica e la risposta è ovviamente mai, mai dopo la Seconda guerra mondiale il conflitto è apparso così acuto e rischioso. Ma questa condivisibile domanda non avrebbe potuto essere formulata, se la componente di conflitto interimperialista non fosse predominante. Questo non vuol dire che l’Ucraina stia combattendo una guerra per procura e che Zelenky sia il burattino di Biden ma semplicemente che hanno un nemico comune. L’Ucraina combatte per un’autodeterminazione che storicamente le spetta, ma lo fa in un contesto specifico di cui è impossibile non tenere conto.
Nessuna guerra mondiale arriva all’improvviso come lo scontro di due auto in tangenziale. Gran parte dei segni restano a lungo invisibili e l’esistenza di quei segni non significa che la guerra certamente ci sarà. La Guerra fredda è restata fredda perché ha prevalso la razionalità, ma per tre volte l’umanità è stata a un secondo dalla mezzanotte. Le ragioni del conflitto interimperialista si sono accumulate nel tempo: la crisi del sistema unipolare è stata aggravata dalla pandemia, dalle conseguenze economiche del riscaldamento globale, dalla crisi interna delle due maggiori potenze nucleari e dalla fame di petrolio e di gas che ha scatenato la speculazione anche prima della guerra di Putin.
Esiste poi anche un altro elemento di instabilità e di rischio, le cui implicazioni non sono calcolabili ma potrebbero diventare decisive. Il dominio dei mercati finanziari ha fortemente indebolito il ruolo della politica e la sua capacità di produrre una professionalità di governo. È attraverso questa professionalità che classi, caste e mafie dominanti difendono sé stesse anche come persone fisiche dalla carica distruttrice dei loro sistemi di potere. E, difendendo sé stesse, pongono qualche limite al proprio avventurismo e alla propria indifferenza alla vita altrui.
Siamo in guerra anche noi
C’è un momento in cui l’insieme delle ragioni obiettive e dei segni visibili e invisibili spinge verso decisioni e iniziative. Chi ha voluto la guerra in Ucraina? Putin dovrebbe rispondere per primo all’appello perché invadere uno stato sovrano, occuparlo, bombardarlo è la reazione propria di un regime che affida soprattutto alle armi le sue ambizioni imperiali. Ma la guerra l’hanno voluta anche gli Stati uniti, come testimonia chi per mestiere è attento ai segni che di solito noi non percepiamo.
Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Rivista italiana di geopolitica, in un articolo del 12 aprile 2021 scriveva che priorità degli Stati uniti era di liquidare la Russia e isolare la Cina. Dopo aver fallito il progetto di giocare la carta dell’una contro l’altra, avevano deciso di liquidare l’impero di Putin. Un anno dopo la rivista prende atto che la guerra è arrivata, che Putin non può perdere e che l’Occidente non può farlo vincere. Non siamo ancora alla Terza guerra mondiale ma a una sua «plausibile premessa».
Non si può avere la certezza che vi sia un rapporto di causa ed effetto tra alcuni segni e la decisione di Putin di imprimere un’accelerazione al conflitto. Questo non vuol dire che non si debbano prendere in considerazione nel fare un bilancio del punto a cui siamo. Si tratta infatti di segni non lievi: tre gigantesche esercitazioni con scenari di guerra in Ucraina e con la partecipazione di tutti i paesi Nato nel corso del 2021; l’esistenza nella Nato di punti di vista diversi alcuni dei quali particolarmente aggressivi; i corpi separati finanziati dal Pentagono che preparano piani per «distruggere la Russia»; il rinvio al mittente delle richieste di trattativa da parte di Putin prima del 24 febbraio; ecc. Sarebbe però non rispondente alla realtà l’immagine di un Putin aggressore nella guerra locale e vittima in quella globale. In questo tipo di conflitti non c’è mai un assoluto equilibrio di forze e iniziative, ma le ragioni di fondo di entrambi sono inaccettabili per una sinistra radicale, rivoluzionaria o come vogliamo chiamarla.
In una situazione in cui, per dirla con Taras Bilous, il mondo non è mai stato così vicino a una guerra nucleare, è ovvio che siamo in guerra anche noi sinistra radicale italiana, anche se per ora nessuno ci spara contro. Lo siamo dal punto di vista economico per sanzioni, contro-sanzioni e alibi forniti alla speculazione; dal punto di vista politico perché l’avventurismo di Putin ha rianimato un’istituzione come la Nato in declino; dal punto di vista delle sicurezza perché questa guerra è già nucleare, come dimostra la vicenda della centrale di Zaporizhzhya.
La domanda sul che fare deve essere perciò formulata in modo corretto perché a domanda sbagliata corrispondono risposte sbagliate. E la domanda non è che cosa dobbiamo fare per l’Ucraina ma che cosa dobbiamo fare di fronte a un temibile conflitto di cui la guerra in Ucraina è in questo momento l’episodio più grave. Coloro che combattono in Ucraina decideranno da soli che cosa fare e a noi spetta di sperimentare tutte le forme possibili della solidarietà. Ma mai nella storia delle nostre diverse storie il dovere di solidarietà ha significato l’obbligo di condivisione dei giudizi dei programmi e dei progetti.
La natura di questa guerra ovviamente impedisce di accogliere l’appello alla sinistra europea perché sostenga la richiesta di invio di armi all’Ucraina. Le ragioni sono state ripetute più volte ma si possono brevemente ripetere.
Primo: si tratta di una richiesta inutile perché chiede ciò che gli Stati uniti e molti paesi della Nato stanno già facendo. Ci si può naturalmente qualificare con la richiesta di fare di più in un’escalation di cui non si vede con quali criteri fissare il limite. A voler essere coerenti a minaccia nucleare bisognerebbe rispondere con minaccia nucleare.
Secondo: è insensato perché con arsenali nucleari in allarme e centrali sotto attacco di entrambe le parti bisognerebbe gettare acqua e non benzina sul fuoco.
Terzo: è paralizzante perché la sinistra radicale non può fare nulla nel merito, se non attendere che altri facciano ciò che noi invochiamo. Molto potremmo fare invece per ridare vita a un movimento disperso anche dalla vista delle bandiere Nato alla sua testa. È accaduto a Milano nella più affollata manifestazione dopo il 24 febbraio.
Quarto: è politicamente sbagliato perché l’Italia è un paese disseminato di basi Nato e degli Stati uniti, in cui per decenni si è ripetuto come un mantra «Fuori la Nato dall’Italia» e in cui la questione della Nato come «ombrello difensivo» è stata una discriminante nel definire le diverse posizioni a sinistra. E perché l’idea di un’escalation è la più lontana dai sentimenti e dalla volontà di solidarietà e di lotta delle persone disponibili a scendere in piazza.
*Lidia Cirillo è stata responsabile della collana di testi femministi Quaderni viola di cui Alegre ha pubblicato la seconda serie. Ha pubblicato, tra l’altro, Lettera alle romane (Il dito e la luna, 2001), La luna severa maestra (Il dito e la luna, 2003), Da Vladimir Ilich a Vladimir Luxuria (Alegre, 2006) e insieme a Cinzia Arruzza Storia delle storie del femminismo (Alegre, 2017).