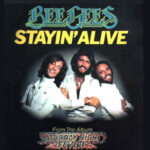
Bee Gees – Stayin’ Alive
11 Luglio 2025
Guerra e filosofia: Galvano della Volpe, 1940
11 Luglio 2025Con La disfida Bobbio-Togliatti, Michele Ciliberto riporta all’attenzione una delle più alte dispute intellettuali del secondo dopoguerra italiano: il confronto tra Norberto Bobbio e Palmiro Togliatti sul concetto di libertà, svoltosi tra il 1954 e il 1955. Pubblicato dalle Edizioni della Normale, il volume Sulla libertà raccoglie non solo i testi originari di quell’incontro, ma anche due interventi successivi di Bobbio sullo stalinismo. A introdurre il dibattito, oggi più che mai attuale, è un denso saggio di Luciano Canfora, che ne evidenzia la qualità del confronto e l’attualità delle questioni affrontate, tra democrazia, diritti sociali e memoria storica. (ndr)
Dibattito Michele Ciliberto riporta all’attenzione nelle Edizioni della Normale gli interventi del filosofo e del segretario del Pci.
Tra il 1954 e il 1955 si confrontarono sul concetto di libertà. E di uguaglianza
di Luciano Canfora
È meritoria l’iniziativa di Michele Ciliberto di ricomporre la discussione storico-politica svoltasi nel 1954 e 1955 tra Norberto Bobbio e Palmiro Togliatti. Gli interventi di Bobbio in quella discussione furono da lui stesso raccolti per Einaudi nel 1955 ( Politica e cultura ) e riediti con ampia introduzione da Franco Sbarberi nel 2005. Gli interventi di Togliatti erano apparsi nella sua rubrica per «Rinascita» firmati «Roderigo di Castiglia». Dopo il terremoto del XX Congresso del Pcus (la «destalinizzazione», come fu allora chiamata), Bobbio intervenne ancora (ottobre 1956) e Ciliberto ha inserito nel volume, sotto il titolo complessivo Sulla libertà , anche questo intervento (Edizioni della Normale, 2025).
È giusto ripercorrere quella discussione innanzi tutto per la qualità intellettuale e il lessico dei due protagonisti. Non è moralismo ricordarlo ma semplice constatazione del tracollo di qualità intellettuale e morale del personale politico e della resa alla dogmatica dominante, da parte del ceto intellettuale in Europa, salvo eccezioni.
La discussione avvenuta tra Bobbio e Togliatti ruotava intorno al gigantesco e impervio concetto di «libertà». Pur avendo l’aspetto di disputa sui principî, essa non poteva che calare nel concreto dell’esperienza storica e della conoscenza empirica di come le parole astratte erano passate — complicandosi — nella realtà effettuale. Era prevedibile, e così fu, che la contrapposizione approdasse all’antinomia libertà/uguaglianza, sulla quale del resto Bobbio è tornato assiduamente fino al fortunato opuscolo dei primi anni Novanta Destra e sinistra. Ed è altrettanto ovvio che in quella discussione ritornasse più volte la questione della natura del potere nell’allora immediatamente post-staliniana Unione Sovietica. E Togliatti ha buon gioco nel far notare al suo interlocutore la riluttanza, da parte della pratica politica liberale (al di là dei principi generali), a prendere atto della necessaria complementarietà tra diritti politici e diritti sociali. E quindi a stigmatizzare la «astrattezza» della critica bobbiana alle forme di attuazione di ciò che fu poi chiamato «socialismo reale».
Ma la novità del volume costruito da Ciliberto consiste soprattutto nell’aver aggiunto, ai quattro interventi dell’originaria discussione, due testi del solo Bobbio apparsi dopo e alquanto dopo: uno dell’ottobre 1956 sempre su «Nuovi Argomenti» (incentrato sul terremoto anti-staliniano del XX Congresso del Pcus), l’altro di trent’anni dopo (una importante lettera all’amico Paolo Spriano dell’ottobre 1986, edita su «l’Unità» nel 2013). Al centro di entrambi è il problema storico dello stalinismo.
La novità
Nel libro anche due testi successivi dello studioso torinese sul problema storico dello stalinismo
Bobbio — scrive Ciliberto in modo calzante — è un «liberale» saldamente ancorato ad una forma mentis storicistica e realistica. Perciò necessariamente fa capo, nella sua riflessione, a Machiavelli e a Hegel. Aggiungerei che questo fu anche proprio di un altro liberale sui generis come Benedetto Croce. Il quale Croce, ben prima del Bobbio del 1956, pronosticò la mutazione inevitabile dell’Urss in alcune memorabili pagine finali della Storia d’Europa nel secolo XIX (1932).
Storicismo e realismo portano Bobbio a formulare, sia pure in una lettera privata che (dice Ciliberto) è quasi «una autobiografia», un giudizio storico su Stalin e la sua opera fondato sul rifiuto netto dell’incolta equiparazione con l’hitlerismo. Scrive Bobbio: «La massima di Machiavelli secondo cui è lecito al principe violare le regole della morale comune se fa gran cose è applicabile a Stalin, non a Hitler». Donde la felice battuta: «Non si possono mettere i due nello stesso sacco». E poco dopo evoca il folgorante ritratto che Machiavelli diede di Annibale «venerando e terribile» per i suoi stessi soldati.
Del tutto collimante con questa considerazione di Bobbio sulla non comparabilità tra hitlerismo e stalinismo è la pagina conclusiva del saggio storiografico su Stalin di un critico severissimo dello stalinismo quale fu Isaac Deutscher. Cui si deve la celebre definizione: «Stalin cacciò la barbarie dalla Russia con metodi barbari»; e la non meno celebre osservazione dell’antitesi totale tra Stalin che imprime con forza spietata, alla Russia, in 20 anni un progresso «di venti secoli» diversamente dal retrogrado hitlerismo che riporta indietro verso l’animalesco razzismo un Paese di altissima civiltà quale era la Repubblica tedesca sorta nel novembre 1919 e strangolata dal nazismo nel 1933.
Ciò che conclusivamente si vorrebbe porre in rilievo, alla luce della selezione di testi che Ciliberto ha riproposto a rinnovata attenzione, è che il movimento perenne della storia produce per lo più inediti, esiti imprevisti: che richiedono innanzi tutto di essere capiti.





