
Una cultura allo sbando: tra dimissioni, faide e vendette di palazzo
4 Luglio 2025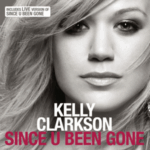
Kelly Clarkson – Since U Been Gone
4 Luglio 2025
La crisi della sinistra italiana non è un inciampo di comunicazione né un vuoto di leadership: è un cedimento strutturale. Incapace di leggere i processi di trasformazione del capitalismo, di riconoscere le figure sociali che essi generano, la sinistra ha mancato l’appuntamento con la storia. In termini gramsciani, le è sfuggita la costruzione di un nuovo blocco storico, mentre la destra, pur contraddittoria, lo ha consolidato. Un segnale rivelatore viene dall’attacco di Giuli al cinema, uno degli ultimi luoghi dove una società in trasformazione lascia ancora tracce leggibili, e per questo, pericolose: lì sopravvive una capacità critica che altrove è stata neutralizzata.
Il capitalismo contemporaneo ha spostato il suo baricentro: dalla fabbrica alla finanza, dalla rendita urbana alle piattaforme digitali, dalla logistica globalizzata al lavoro on-demand. Da questa metamorfosi è emersa una costellazione di soggetti ibridi – autonomi instabili, micro-impresa precaria, professionisti freelance, tecnici in outsourcing, partite IVA in bilico – figure né garantite né protette, ma decisive.
A questi segmenti la destra ha offerto una promessa semplice: meno tasse, meno Stato, meno lacci burocratici. Ne ha fatto una narrazione di efficienza e libertà, ha indicato nemici riconoscibili – burocrazia, centralismo, parassitismo pubblico – e, soprattutto, ha tradotto tutto ciò in dispositivi concreti: flat tax, concordati, corsie veloci per l’impresa. Così ha trasformato frustrazione in identità politica, dando luogo a un patto fiscale che funge da architrave del proprio blocco sociale.
La sinistra, al contrario, non ha saputo riconfigurare mappe e lessico. Le sue categorie restano ferme al Novecento. Parla a un mondo che non esiste più: dipendenti pubblici, settori universitari, ambientalismo urbano diffuso. Nessuna alleanza ampia, nessuna visione, nessuna egemonia.
Mentre la destra colonizzava lo spazio tecnico – riforma fiscale, autonomia differenziata, nuove norme sul lavoro – la sinistra oscillava fra riformismo timido e moralismo simbolico, recidendo il legame con i propri intellettuali organici e abdicando alla direzione culturale e tecnica.
Il risultato è una crisi organica: il popolo che la sinistra evoca non esiste più; quello che esiste non la riconosce. Non sa leggere il nuovo lavoro, la nuova fiscalità, le nuove dipendenze; non sa più chi sono i suoi interlocutori; non possiede un linguaggio.
Intanto l’Unione Europea, lungi dall’essere un vincolo neutro, ha istituzionalizzato la logica dell’accumulazione finanziarizzata. Trattati, parametri, norme deflattive hanno reso egemonico un ordine competitivo che la sinistra ha finito per subire: o lo ha accolto in chiave tecnocratica, o lo ha respinto senza progetto.
Tre carenze inchiodano oggi la sinistra al suo stallo. Prima: l’assenza di un’analisi materiale della società reale, di chi produce, lavora, soffre. Seconda: l’incapacità di ricomporre interessi dispersi in un’alleanza sociale che leghi lavoro autonomo e precario, pubblico impoverito e innovazione periferica. Terza: la mancanza di una concezione dello Stato come infrastruttura di potere collettivo, capace di redistribuire potere oltre che risorse.
Non basta cambiare linea, né sostituire i volti al comando: la sinistra italiana, oggi, non è dentro i processi reali di trasformazione. È fuori dalla storia, con un linguaggio logoro, strumenti arrugginiti, riferimenti sociali evaporati. Gramsci avrebbe parlato di minoranza senza egemonia. È esattamente ciò che è diventata. (P.P.)





