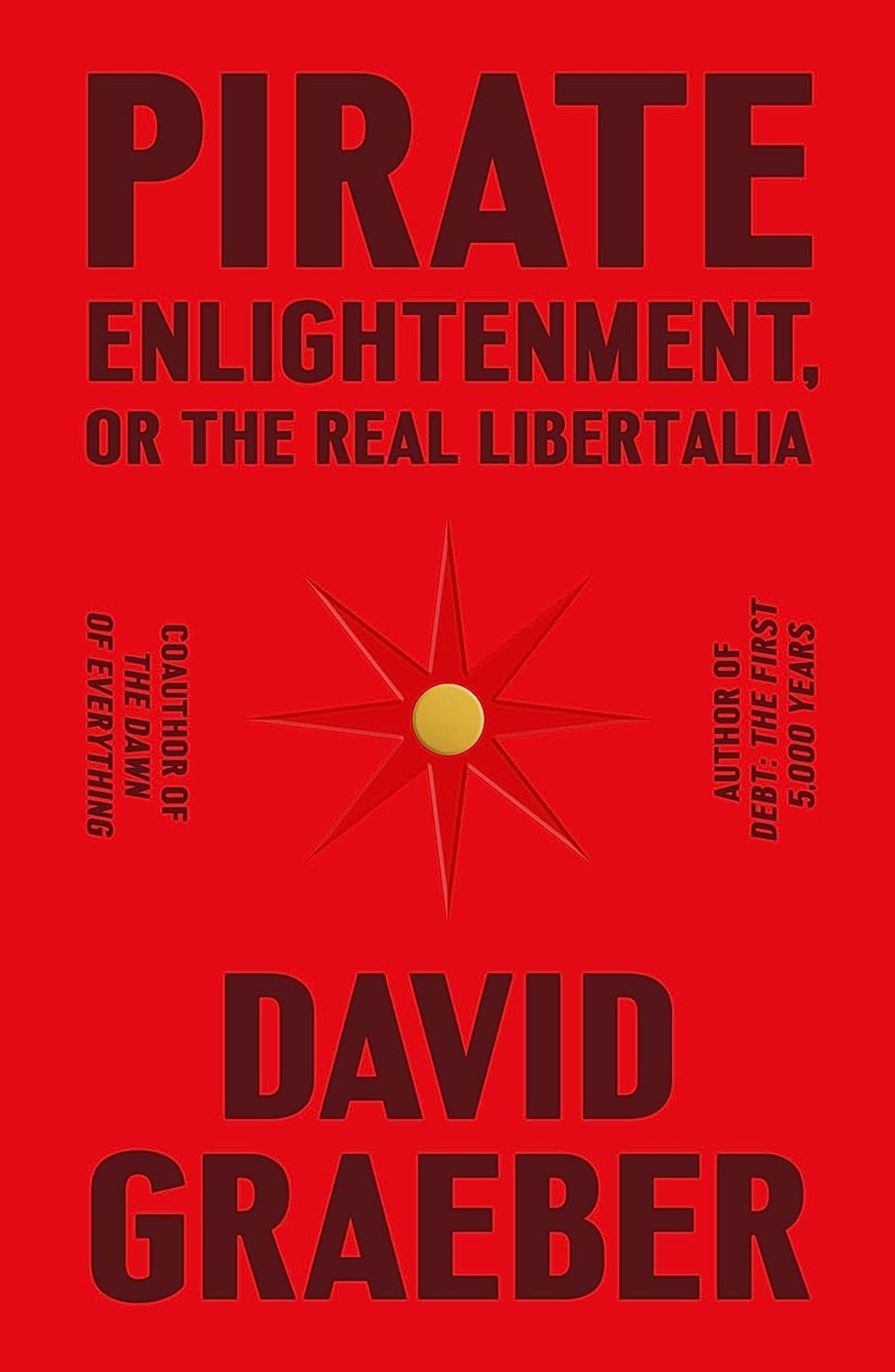
Pirates + Madagascar = Egalitarian Utopia? On David Graeber’s “Pirate Enlightenment, or The Real Libertalia”
16 Luglio 2023
Karlovy Vary, una passeggiata nel cinema
16 Luglio 2023
Uno che ha scritto Il barone rampante (cito quello che ritengo essere il suo libro più riuscito, meglio, quello che più mi ha affascinato) può permettersi tutto, anche di scrivere non esaltanti recensioni cinematografiche. La vulgata è che in tutti i suoi scritti dedicati al cinema, Italo Calvino abbia sempre diffuso di sé l’immagine di uno «spettatore medio», appassionato, con trascorsi cineclubbistici, mai però interessato alla storia e alla teoria del film: un giovane critico militante. Più militante che critico, come vedremo. Il corollario che giustifica la pubblicazione (il 15 ottobre sarà un secolo dalla nascita) è che Calvino nei suoi libri e nei suoi saggi ha sempre privilegiato lo sguardo, sia come chiara vocazione visiva sia come «statuto dell’immagine»: la sua educazione non poteva che partire dal cinema.
I giornali su cui scrive di cinema sono «La Verità» (organo della Federazione comunista di Imperia), «l’Unità», «Partito e massa» (bollettino della Federazione comunista torinese), «Il Contemporaneo» ma soprattutto «Cinema Nuovo» diretto da Guido Aristarco (l’egemonia gramsciana unita alla concezione estetica di György Lukács). Per un lettore affezionato di Calvino, appare abbastanza inspiegabile questa lunga collaborazione con il dogmatismo ideologico di Aristarco, con il suo grigiore punitivo da dibattito obbligatorio, con un tipo di critica di tendenza, risolutamente giudicante, volta a individuare in quale misura trionfino nella forma cinematografica le contraddizioni tipiche di una società. Nella Vita agra, Luciano Bianciardi, che è stato redattore della rivista, si serve del personaggio del dottor Fernaspe per descrivere le manie ideologiche di Aristarco e quell’ossessione per «la battaglia per il passaggio dal neorealismo al realismo, dalla cronaca alla storia» che non ammetteva distrazioni.
Su Calvino e il cinema sono già stati pubblicati alcuni libri ma l’occasione per parlarne oggi è l’uscita presso Mondadori di Guardare. Disegno, cinema, fotografia, arte, paesaggio, visioni e collezioni a cura di Marco Belpoliti. Il libro è una raccolta di recensioni e saggi sull’atto del guardare come fonte imprescindibile di conoscenza. Belpoliti si era già occupato dell’argomento nel libro L’occhio di Calvino (Einaudi) dove, però, non si parlava di cinema. Adesso, invece, con l’aggiunta delle recensioni e di altri scritti sull’argomento, la passione cinematografica diventa d’un tratto la «vera e propria palestra nella quale si formerà la sua sensibilità artistica».
C’è da augurarsi che non sia così perché uno che stronca in meno di quattro righe La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock non lascia presagire alcunché di buono (chi vuol bene a Calvino, suppone che non abbia visto il film e che ne abbia parlato male per «partito preso», cioè il Pci). Persino i giudizi sulla sacra triade di allora, Luchino Visconti-Federico Fellini-Michelangelo Antonioni, sono rivedibili, anche se è interessante la manifesta affinità con Antonioni.
Leggendo la famosa Autobiografia di uno spettatore, cioè la prefazione che Calvino scrisse a libro di Fellini, Quattro film (Einaudi, 1974), si intuisce il senso di una profonda inibizione, di un’inspiegabile autorepressione (curioso poi che invece di parlare di Fellini, il Nostro parli prevalentemente di sé). Calvino ama follemente il cinema americano, quello di Hollywood: «La mia epoca va pressappoco dai Lancieri del Bengala con Gary Cooper e L’ammutinamento del Bounty con Charles Laughton e Clark Gable, fino alla morte di Jean Harlow (che rivissi tanti anni dopo come morte di Marilyn Monroe, in un’epoca più cosciente della carica nevrotica di ogni simbolo)». E in un’intervista che Lietta Tornabuoni gli fa nel buen retiro di Roccamare confessa: «Ci sono stati anni in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni e magari due volte al giorno, ed erano gli anni tra diciamo il Trentasei e la guerra (…). Anni in cui il cinema è stato per me il mondo. (…) Andavo al cinema al pomeriggio, scappando di casa di nascosto, o con la scusa di andare a studiare da qualche compagno… Entrare all’ora dell’apertura mi garantiva la rara fortuna di vedere il film dal principio». E ancora, su «Cinema Nuovo» del 1° maggio 1953: «A me il cinema quando assomiglia alla letteratura dà fastidio; e la letteratura quando assomiglia al cinema anche. (…) Il mio cinema ideale resta — forse perché mi ha nutrito quotidianamente per tanti anni della mia adolescenza — quello americano dell’anteguerra, col suo catalogo di divi-personaggi, di convenzioni-situazioni, che corrispondono ad altrettante realtà o ad altrettante ipocrisie anch’esse storicamente reali e importanti; quei film mi divertivo a vederli, e mi divertivo ancor di più a rifletterci sopra, a smontarli, a demolirli (…) cosicché anche quelli brutti erano interessanti e istruttivi. (…) Il film non è più quello strano fiore d’una pianta spuria e contaminata, con radici che vengono su dal circo equestre, dal castello dei misteri, dalle cartoline al bromo, dai tabelloni dei cantastorie. Ed è un fatto che io mi diverto meno».
Poi, però, subentra la militanza e Calvino deve negarsi il piacere del cinema americano per recensire film sovietici, come Compagno P. del quale capisce perfettamente la pochezza ma si sente obbligato a cantarne i pregi: «Compagno P. ha qualcosa della potenza delle epopee nate dalla fantasia popolare e tramandate di bocca in bocca dei poemi corali di cui non è autore un uomo ma un popolo» (1945). John Ford in Com’era verde la mia valle diventa un autore democristiano, i film cecoslovacchi esaltano la vena umoristica della cultura di quel Paese, L’infernale Quinlan di Orson Welles è un «film su Stalin» (1959).
La delusione più grande è rappresentata dal suo intervento al dibattito aperto nel 1956 su «Cinema Nuovo» da un critico sensibile come Renzo Renzi sulla destalinizzazione del cinema sovietico (nel febbraio del 1956, a Mosca, Nikita Krusciov aveva pronunciato il famoso discorso sui crimini di Stalin), dibattito noto come «Sciolti dal Giuramento». Scrive con coraggio Renzi: «Di fronte a film come Il giuramento, non ci si accontentava di giustificarli. Si andava più in là: si diceva che essi erano forme nuove di arte, forme mai viste, superiori a tutte le precedenti, poiché sapevano mescolare la lirica con la satira, il giornale Luce con la lirica e via dicendo. E più, agli occhi del buonsenso, molti tratti erano soltanto errori, insufficienze espressive, mancanza di sincerità degli autori, più quegli errori venivano trasformati in meriti “di tipo nuovo”… Questa critica era votata all’apologia ad ogni costo, secondo il principio base per cui “ciò che posso recuperare ideologicamente è bello; ciò che è russo è bellissimo”, applicato totalitariamente».
Calvino risponde difendendo la sua recensione positiva di La caduta di Berlino (altro film messo sotto accusa da Renzi). «Io tendevo — scrive Calvino — a fare della Caduta di Berlino un esempio di stile popolare ricco d’invenzione poetica, in opposizione al grigiore del realismo socialista». Certo, adesso gli pare un film reazionario come reazionario è il suo linguaggio e tuttavia «non facevo che assecondare una forma di retorica (quella primitiva e natalizia) per contrapporla a un’altra (quella pettoruta ed edificante)» («Cinema Nuovo», 15 dicembre 1957). La data qui assume un particolare valore perché è anche l’anno in cui Calvino, in seguito all’invasione sovietica dell’Ungheria, novembre 1956, abbandona il Partito comunista, al quale s’era iscritto nel ’54.
Le parti più interessanti sono quelle riservate al rapporto fra cinema e letteratura e al concetto di realismo: «Raccontare in letteratura e raccontare in cinema sono operazioni che non hanno nulla in comune. Nel primo caso si tratta di evocare delle immagini precise con delle parole necessariamente generiche, nel secondo caso si tratta di evocare dei sentimenti e pensieri generali attraverso immagini necessariamente precise. È certo che i mezzi del cinema hanno una suggestione di verità più diretta. Basta che la verità sia negli oggetti fotografati e che il metodo usato per fotografarli e farli muovere non sia mistificatorio, per raggiungere risultati dei quali lo scrittore credendo di potersi affidare agli stessi dati di partenza (immagini e vicende) resta ben lontano. La violenza di Rocco e i suoi fratelli è certo più vera di quelli di molti romanzi di contenuto e tonalità analoghi» (Quattro domande sul cinema italiano, «Cinema Nuovo, gennaio-febbraio 1961).
Con molta temerarietà, Belpoliti definisce Calvino «cinefilo», anche se la comunità cinefila si è sviluppata a Parigi a partire dai decenni che seguirono la Seconda guerra mondiale, con la proiezione all’interno dei cineclub di film stranieri occultati durante guerra, fatto che ha generato un profondo interesse soprattutto per il cinema classico americano; per dire, si deve alla cinefilia dei «Cahiers du Cinéma» l’esaltazione di Hitchcock. Calvino ha fatto il percorso inverso: prima ha amato il cinema americano poi quello militante. Per questo, paradossalmente, sono molto più avvincenti gli scritti in cui teorizza aspetti del cinema che non le singole recensioni sui film.
Quando parla del doppiaggio: «La convenzionalità del cinema americano mi arrivava dunque raddoppiata (mi si scusi il bisticcio) dalla convenzionalità del doppiaggio, che ai nostri orecchi però entrava a far parte dell’incantesimo del film, inseparabile da quelle immagini. Segno che la forza del cinema è nata muta, e la parola — almeno per gli spettatori italiani — è sempre sentita come una sovrapposizione, una didascalia in stampatello» (Autobiografia di uno spettatore, 1974).
Quando parla di evasione: «Il cinema come evasione, si è detto tante volte, con una formula che vuole essere di condanna, e certo a me il cinema serviva a quello, a soddisfare un bisogno di spaesamento, di proiezione della mia attenzione in uno spazio diverso, una tappa indispensabile di ogni formazione» (Autobiografia di uno spettatore, 1974).
Quando cerca di definire che cos’è il cinema: «Aschenbach è preso da un senso d’inferiorità, lui con le sue pagine così avare ed esangui, e gli viene un terribile desiderio di tutte le cose che il cinema è e dà, la realtà più immediata e l’idealizzazione più smaccata, una libertà d’espressione grande quanto il mondo visibile e una convenzione codificata all’estremo, la fama più altisonante e impudica, l’atmosfera di ricchezza onnipotente, e insieme il senso di lavorare per un mondo di povera gente, per le folle anonime che si stiperanno nelle sale buie. Per tutto quel che il cinema è: tecnica e baraccone, volgarità e sapienza raffinata, avventura per chi lo fa e per chi lo vede» (La noia a Venezia, «Cinema Nuovo», agosto 1955, articolo scritto a Venezia per la morte di Thomas Mann).
Belpoliti si stupisce che Calvino abbia dedicato poca attenzione alla televisione, pur avendola vista nascere (1954), pur avendo assistito all’esplosione di quella commerciale (1980). Per lui sarebbe principalmente uno strumento informativo. Eppure, c’è un racconto che forse avrebbe meritato l’inserimento in questa raccolta. S’intitola L’ultimo canale ed è stato pubblicato su «la Repubblica» del 3 gennaio 1984 a sancire la sovrapposizione fra televisione e vita quotidiana, fra la dimensione reale e quella immaginaria. Il brano descrive il delirio di un uomo alla disperata ricerca della sua storia, di una giustificazione della propria esistenza, di un senso che egli spera d’incontrare nelle vicende degli altri viste in tv: «Per questo continuo a passare da un canale all’altro: non perché la mia mente sia ormai incapace di concentrarsi. Neppure quel minimo che ci vuole per seguire un film o un dialogo o una corsa di cavalli. Al contrario: la mia attenzione è già tutta proiettata su qualcosa che non posso assolutamente mancare, qualcosa di unico che sta producendosi in questo momento mentre ancora il mio video è ingombro di immagini superflue e intercambiabili, qualcosa che deve essere già cominciato e certo, ne ho perduto l’inizio, e se non mi affretto rischio di perderne pure la fine. Il mio dito saltella sulla tastiera del selettore scartando gli involucri della vana apparenza come spoglie sovrapposte di una cipolla multicolore». L’inquieto protagonista alla fine verrà accusato di voler cambiare il mondo a colpi di telecomando. Più telefilo che cinefilo.
https://www.corriere.it/la-lettura/





