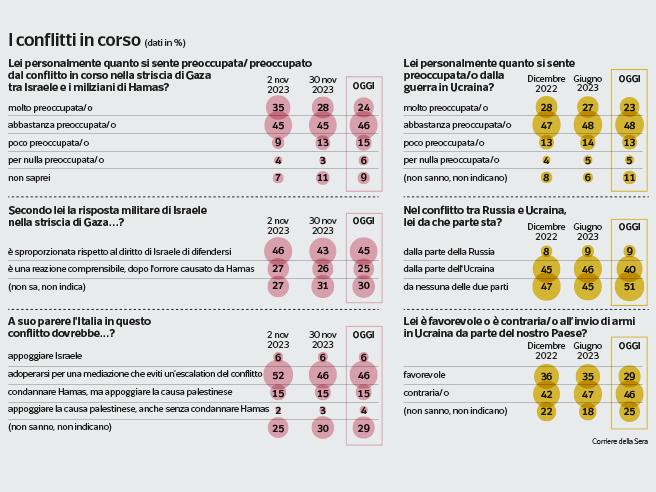Alla fine del 2022 l’Italia contava il 55% di occupate contro il 69% della media Ue. Il 18% delle lavoratrici lascia il posto quando arriva un figlio
ROMA — Dopo la fuga dei cervelli, la fuga delle mamme. Quando la donna diventa madre, in un caso su cinque smette di lavorare. E si unisce a quel terzo di donne che non lavoravano neanche prima. L’Italia è tra i pochi Paesi Ue, se non l’unico, in cui chi non è maschio deve scegliere: o lavora o mette su famiglia.
Come se il figlio fosse un ostacolo alla piena indipendenza professionale ed economica della donna. Lo è alle nostre latitudini. Non il solo, ben inteso. Ce lo ricorda il recente dossier del Servizio studi della Camera dedicato all’occupazione femminile.
L’Italia annovera il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa. Inanella solo record negativi: Neet, part-time involontario, contrattini, poche laureate nelle discipline scientifiche Stem, basse retribuzioni. E poi ancor più scarne pensioni.
Tutti gap che non si chiudono. Nonostante impegni Onu e Pnrr, strategie europee e nazionali. Alla fine del 2022 l’Italia contava il 55% di occupate contro il 69% della media Ue. Quattordici punti di divario. Il 18% poi delle (poche) lavoratrici lascia il posto quando arriva un figlio.
Oltre la metà lo fa perché non riesce a conciliare la vita a casa con quella al lavoro. Il 19% per considerazioni economiche, visto il costo della babysitter e la scarsità degli asili nido. Ce ne sono 13.518 in Italia per 350 mila posti, il 28% sul totale dei bimbi sotto i tre anni. L’obiettivo europeo fissato per il 2010 era il 33%. Quello per il 2030 al 45%. Lontani anni luce.
Dice il rapporto, citando i dati Istat, che dopo la pandemia l’offerta nei nidi è cresciuta di 1.780 posti. Ma «le richieste di iscrizione sono in gran parte insoddisfatte, soprattutto al Sud: 66,4% nel pubblico, 48,7% nel privato».
Il divario tra uomini e donne, quanto ad occupazione, pare un fossato: 17,5 punti che in presenza di figli lievita al 34%. Quello tra donne è però il più eloquente: le occupate tra 25 e 49 anni con un figlio sotto i 6 anni sono il 55,5%, quelle senza figli e nella stessa fascia di età arrivano al 76,6%. Tra madri laureate con o senza figli non c’è invece differenza.
Quando la donna lavora, anche se specializzata, ecco però l’altro fossato, il più odioso: ilgender pay gap .La differenza nelle buste paga, a parità di mansioni con i colleghi uomini. La direttiva europea970 sulla parità retributiva, approvata il 10 maggio scorso, prevede obblighi di trasparenza e informazioni in materia di retribuzioni.
L’Italia che deve recepirla entro il 7 giugno 2026, quando chiuderà anche il Pnrr, dovrà stabilire i criteri perché sia attuata da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati. A partire da un principio: la donna e l’uomo devono essere pagati in modo eguale per uno stesso lavoro. Dovranno essere trasparenti anche le offerte di lavoro, con il salario proposto da conoscere prima. E non dopo il colloquio, a seconda se donna, donna giovane, sposata o no.
Discriminazioni che purtroppo ancora pesano. I dati Inps dell’Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato dicono che nel 2022 una donna ha guadagnato in media quasi 8 mila euro in meno di un uomo: 18.305 euro contro 26.227 euro. La Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 (che riprende quella elaborata dalla Ue) si propone di ridurre ilgender pay gap nel settore privato dal 17 al 10%.
I dati Eurostat ci aiutano però anche a capire che il divario retributivo medio tra uomo e donna èmolto più legato alle ore di lavoro svolte che non dal salario orario lordo. In questo secondo caso il gap è “solo” del 5% (media Ue al 13%). Nel primo siamo al 43% contro il 36,2 della media Ue.
Significa che le italiane vengono “quasi” pagate, in media, come gli italiani per un’ora di lavoro. Ma guadagnano meno degli uomini perché lavorano meno ore. Tra le cause del divario, chiosa lo studio della Camera, c’è «il lavoro invisibile e non retribuito di cura, il maggior ricorso al tempo parziale », spesso imposto (49% per le donne, 26% per gli uomini). E poi: «Le frequenti interruzioni di carriera, l’occupazione in larga parte precaria, in settori a bassa remuneratività o poco strategici».