
Il Manifesto dei valori del Pd è inservibile, scritto per un partito adatto a tutte le stagioni
3 Dicembre 2022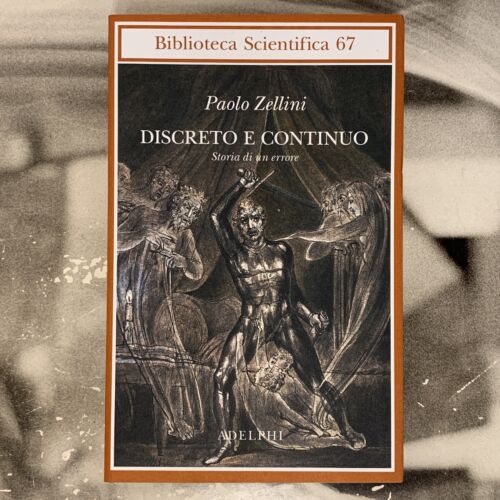
L’interazione umana con l’ambiente, tra biologia, filosofia e matematica
3 Dicembre 2022Il capoluogo lombardo è ormai un centro extraterritoriale, il laboratorio politico di una combinazione di interessi, che condiziona il partito che l’amministra
Nelle prossime settimane Goldman Sachs sposterà da Londra a Milano il suo stato maggiore di operatori e consulenti finanziari. Insieme con la famosa banda d’affari anglo-americana, anche altri centri finanziari, come Morgan Stanley, porteranno nuclei operativi consistenti dalla capitale britannica a Milano. La notizia ovviamente rende felici gli amministratori del capoluogo lombardo, e soprattutto gli operatori del mercato immobiliare e della ristorazione, che si troveranno qualche centinaio di nuovi clienti di alto target. Lo stesso capiterà ai master del politecnico e della Bocconi, che avrà ulteriori opzioni per i suoi super-laureati.
Ma il dato che politicamente ci sembra utile sottolineare riguarda proprio il profilo che sta assumendo Milano: città extraterritoriale dei primi e degli ultimi. Una caratteristica che si associa all’essere la retrovia, il ridotto al Nord, della sinistra. Per certi versi, proprio come Londra – meno Parigi e Madrid, che sono le altre componenti del quadrilatero metropolitano europee – la città meneghina si trova a declinare la sua aristocrazia immateriale che la rende il più grande territorio produttivo senza fabbriche italiano, con la sua opzione a favore del centrosinistra.
Se vogliamo fare un po’ di storia, non è certo la prima volta che la metropoli lombarda si trova a fare da contraltare del governo nazionale, trainando una sinistra, persino inconsapevole della circostanza, a governare l’innovazione. Nel 1961, a Milano, nasceva la prima grande giunta di centrosinistra, mentre a Roma Fanfani e Moro chiedevano ancora tempo per portare tutta la Dc al tavolo con i socialisti. In quella compagine amministrativa – benedetta dall’arcivescovo Giambattista Montini, prossimo papa Paolo VI – era centrale l’assessore Piero Bassetti, futuro presidente della prima giunta regionale nel 1970, ma soprattutto esponente dell’ala tecnocratica della sinistra democristiana, che già guardava al postindustriale finanziario come piattaforma per ridurre le ambizioni conflittuali della sinistra socialista e comunista e dare un assetto europeo alla città.
In quel passaggio, si può leggere molto del destino successivo della politica italiana: il perché l’espansione industriale del Paese – siamo nel pieno del mitico miracolo economico dei primi anni Sessanta – non coincise con un’adeguata espansione dell’influenza della sinistra politica;le successive delusioni del fronte riformatore dinanzi alla controffensiva reazionaria di ceti economici legati alla rendita che non acconsentivano a una modernizzazione radicale del tessuto economico del Paese; infine l’incomprensione, soprattutto da parte del Pci, delle dinamiche delle forze del mercato, che pure proprio l’intellighenzia comunista riuscì ad analizzare brillantemente nel 1962, nel corso di uno storico convegno sul neocapitalismo dell’Istituto Gramsci, ma senza che poi ci fosse un seguito politico a quelle intuizioni elaborate da giovani ma già rappresentativi quadri quali Bruno Trentin e Lucio Magri, con Lucio Libertini e Vittorio Foa della sinistra socialista.
Come allora, ci troviamo oggi dinanzi a uno snodo dei processi di riorganizzazione del capitalismo, che investe il nostro Paese passando per la porta di Milano. Mentre larghe aree del Nord, dal lombardo-veneto al Nord-ovest piemontese, fino a consistenti porzioni della ex rossa Emilia, ormai stabilmente si sposta verso la sponda sovranista – passando dall’autonomismo localistico della vecchia Lega a un sovranismo di tutela nazionale, rappresentato dal melonismo –, le grandi città, soprattutto Milano e Torino, rimangono ancora di marca democratica e di centrosinistra. Ma in particolare nella cinta daziaria ambrosiana è in corso un processo di mutazione, che sta paradossalmente trasformando proprio l’identità del Pd, che guida l’amministrazione ormai da molti anni. Milano, infatti, proprio sulla scia di Londra, a cui sta strappando pezzi rilevanti di indotto finanziario, sta diventando un laboratorio sociale in cui si sta radicalizzando una combinazione di interessi estrema.
Si allarga la piattaforma del globalismo finanziario, che ormai chiaramente ha scelto la città del duomo come terminale di un riposizionamento europeo. Un globalismo nel quale primeggiano i centri dell’immateriale: dalla moda, alle progettazioni informatiche, alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella sanità o nella logistica. Collante di queste componenti è, appunto, la finanza come lingua, prima ancora che come pratica. Fra la prima e la seconda cerchia dei navigli la residenzialità delle nuove figure di professionalità multinazionali, che vivono anche a Milano, si combinano con i tecnici delle diverse modalità di declinazione di quell’esperanto tecnologico che sono i sistemi di profilazione degli utenti di qualsiasi attività o servizio. Siamo al vertice di skills pregiati e sperimentali, che fanno surfing sulle nuove esperienze tecnologiche e creano strategie commerciali e produttive, basate sulla raccolta dei dati. Sono giovani che stressano le proprie capacità con la consapevolezza che stanno vivendo una storia intensa, redditizia ma provvisoria. In questo sentirsi di passaggio, si riconosce una cultura della vivibilità che limita e contiene la frenesia del guadagno, lasciando spazi a valori e atteggiamenti democratici e inclusivi.
Questo popolo della competizione momentanea, che considera la città un hub e non una residenza, si rivolge, nelle sue ritualità assistenziali, a un altro popolo, quello degli ultimi, quell’immigrazione che oggi si mischia a forme di impoverimento immediato e improvviso, che colpisce anche settori indigeni della ricca Milano. Cosi, negli stessi quartieri, nelle stesse isole urbane, convivono gli uffici di banche e software-house con fondazioni e onlus che assistono e tutelano chi cerca un supporto per mangiare e continuare a vivere.
Aldo Bonomi, nei giorni scorsi sul “Sole 24 ore”, parlava di città-regione, connettendo i flussi immateriali ai luoghi di questa nuova Milano, a cui si ricollegano le innovative filiere del valore che si ramificano nella regione. Una città, però, che si trova arroccata su due figure sociali dominanti: gli iper-professionalizzati e coloro che sono alla deriva.
La convergenza fra i primi, che sono comunque un pulviscolo di individui diversi e separati gli uni dagli altri, e gli ultimi, che invece tendono a diventare omologhi e omogenei nell’invisibilità, determina il nuovo carattere della metropoli più ricca del Paese, ma anche il tratto sociale del consenso che raccoglie il Pd. Un voto, quello che porta i democratici ormai da tre sindacature a governare la città, che si basa su opzioni di stile di vita, di affinità culturali occasionali, che individuano nel Pd la proposta meno distante, meno vincolante, la più innocua e funzionale per una città che deve essere aperta e inclusiva. Il partito leggero – anzi, il voto leggero –, che trascende ogni idea di partito, si deposita in un contenitore che non chiede militanza o presidi territoriali, ma solo esibizione di valori da contrapporre alla destra che assedia Milano con le sue truppe provinciali.
Diciamo che la convergenza con questo ceto globale è la scorciatoia che la sinistra sceglie per poter entrare nel Ventunesimo secolo senza pagare lo scotto di un consapevole cambio di base sociale, per attivare forme di conflitto che sostituiscano lo sbandieramento di innocui diritti. Proprio questo dualismo fra diritti e conflitti, riporta a un lontano dibattito originato nella pancia di una lontana sinistra che, a metà degli anni Novanta, a Chianciano, scelse per il sindacato una strada di omologazione alla frammentazione sociale, usando i diritti per giustificare l’assenza di conflitti contro i nuovi poteri dell’automatizzazione della democrazia.





