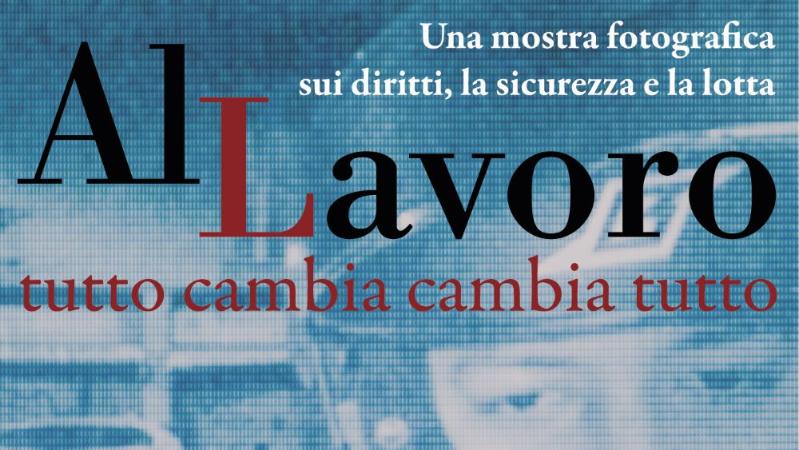The big idea: will sci-fi end up destroying the world?
27 Aprile 2025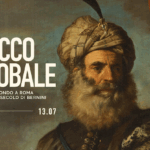
Quanto era globale la Roma barocca
27 Aprile 2025di Angelo Ferracuti
Una volta c’era la classe operaia — quella di Ladri di biciclette di Vittorio De Sica e del Ferroviere di Pietro Germi e di Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. Pellicole impastate delle atmosfere grigie di un dopoguerra gravido, quartieri polverosi e palazzi dell’Italia della ricostruzione, locomotive che corrono in un bianco e nero esistenzialistico lungo un Paese che sta per perdere l’innocenza con l’arrivo del boom. Quella memoria di un’Italia lontana e ancora comunitaria è conservata nei ritratti e nei reportage di Gianni Berengo Gardin, Uliano Lucas, Fausto Giaccone, Tano D’Amico e molti altri, che ora ritroviamo in una mostra — Al lavoro — che si inaugura a Bologna il 1° maggio proprio nel momento in cui il più grande sindacato italiano, la Cgil, lancia una campagna referendaria «per rimettere al centro della nostra società il valore del lavoro», come scrive il segretario Maurizio Landini nella presentazione del catalogo.
I cinque quesiti referendari (gli italiani saranno chiamati a votare l’8 e 9 giugno) chiedono di fermare i licenziamenti illegittimi, dare maggiore tutela ai lavoratori delle piccole imprese, ridurre il lavoro precario, aumentare la sicurezza e consentire un più facile accesso al diritto di cittadinanza. Sì, perché negli ultimi vent’anni in Italia è peggiorata la qualità del lavoro, i salari sono tra i più bassi in Europa, le tutele sono state progressivamente ridotte mentre si sono moltiplicate le tipologie di contratti precari; ma anche dove si muore di più: 1.090 vittime lo scorso anno, il 4,7% in più rispetto al 2023.
Non è più il tempo delle affollate assemblee operaie come quella dell’Alfa Romeo di Arese del 1984, fotografata da Lucio Cavicchioni, in preparazione del 25 Aprile e solidale con la lotta sandinista in Nicaragua; o dei cassintegrati calabresi ritratti da Francesco Cito; o delle operaie alla manovia negli scatti frontali in bianco e nero di Paola Agosti. Le lotte che portarono a conquiste storiche come lo Statuto dei lavoratori, la riforma sanitaria, il contratto nazionale collettivo sono lontane. Quello del dopoguerra, invece, era ancora un Paese «corporale», per dirla con il titolo di un romanzo di Paolo Volponi, con uno dei movimenti operai più forti e coesi d’Europa, un Paese che dalla civiltà contadina aveva abbandonato le campagne per entrare nella fabbrica fordista.
La mostra bolognese dedica una sezione (sono sei in tutto) anche al lavoro minorile in Italia e nel mondo, soprattutto nei settori della ristorazione, della vendita al dettaglio, dell’agricoltura e dei cantieri con le foto degli anni Settanta a Palermo di Alberto Roveri, dei raccoglitori di canna a Natal, in Sudafrica, o dei Niños trabajadores di Fernando Moleres. Così come affida uno spazio ai temi dei diritti e delle morti sul lavoro, con le immagini di stabilimenti che sembrano gironi dell’inferno (un’istantanea di Samuele Pellecchia ritrae un operaio dell’altoforno mentre osserva la colata nella Ferriera Lucchini a Servola, Trieste) o di operai al lavoro nel montaggio di un’impalcatura a Napoli (in una fotografia di Fabio Fiorani), in un Paese dove ispezioni e controlli sono ridotti al minimo. Per non parlare del lavoro sommerso di braccianti trattati come schiavi nella Piana di Gioia Tauro, soprattutto africani, o indiani dell’Agro Pontino come Satnam Singh, 31 anni, mutilato a Borgo Bainsizza (Latina) e lasciato morire dissanguato davanti alla propria abitazione, o stranieri sfruttati nelle campagne pugliesi che ricordano quelli dei romanzi di John Steinbeck. Anche i temi ambientali e i siti ad alto rischio sono documentati nell’esposizione bolognese: l’amianto di Casale Monferrato, l’Ilva di Taranto in una veduta dal mare di Andrea Sabbadini, l’Enimont di Ravenna, le immagini agghiaccianti dell’Icmesa di Seveso durante la bonifica intorno allo stabilimento dal quale fuoriuscì la diossina.
Ma la storia italiana registra soprattutto il drammatico sciopero di 35 giorni dei metalmeccanici che cominciò alla Fiat Mirafiori il 10 settembre 1980 dopo l’annuncio di 14.469 licenziamenti e la marcia dei 40 mila colletti bianchi — il 14 ottobre 1980 — che segnò una sconfitta storica per il movimento operaio italiano, simbolica quasi quanto quella dei minatori britannici contro i tagli di Margaret Thatcher. Lì finisce un mondo; secondo alcuni storici lì finisce addirittura il Novecento.
Negli anni successivi alcune parole hanno segnato l’impoverimento anche lessicale del tessuto produttivo — delocalizzazione e dismissione; e poi un’altra, competitività, legata a globalizzazione — in nome delle quali si sono avviate chiusure, ristrutturazioni, trasferimenti di produzione in Paesi dove manodopera e materie prime costavano meno. In tutti questi passaggi — sottolinea nel percorso della mostra «La linea del tempo dei diritti»: cancellazione della scala mobile, regolamentazione del diritto di sciopero, Jobs Act — c’è una progressiva e continua erosione delle tutele e dei diritti dei lavoratori. Un altro termine ha reso definitivo il cambiamento: flessibilità, perché di solito il linguaggio anticipa e rende possibili i mutamenti sociali. La prima legge che introduce la precarietà fu approvata dal centrosinistra con il cosiddetto «Pacchetto Treu» del 24 giugno 1997, provvedimento che prende il nome dal ministro del Lavoro del governo Prodi. È qui che entra in scena il capitalismo finanziario, quello che il sociologo olivettiano Luciano Gallino ha definito «finanzcapitalismo» e che Paolo Volponi ha rappresentato in un romanzo esemplare, Le mosche del capitale.
Oggi le forme di sfruttamento si sono spostate sulle piattaforme digitali. In mostra colpiscono le foto «marziane» dei rider di Federico Feliciotti ritratti dai videocitofoni, a rappresentare anche plasticamente la distanza e la disumanizzazione tra chi ordina e chi consegna.
Nel libro L’ultimo miglio. Viaggio nel mondo della logistica e dell’ecommerce in Italia tra Amazon, rider, portacontainer, magazzinieri e criminalità organizzata (Manni) il giornalista Angelo Mastrandrea ha dedicato qualche anno fa un capitolo, «Le regole di Amazon», alla mistica gendarmesca della multinazionale americana che definisce «asettica e militaresca, disumana nella sua scientificità» (vedi le foto di Alessandro Digaetano). Una lavoratrice di Passo Corese addetta agli scaffali della Robotic Storage platform, con un arto operato, ancora gonfio, e una cicatrice lunga dieci centimetri, racconta all’autore: «Mi si è bloccato per la tensione muscolare causata dai movimenti ripetitivi che facevo per prelevare la merce dagli scaffali», lo stesso gesto ripetuto 500, anche 600 volte ogni ora. È la nuova frontiera del business del capitalismo globale che però ricorda la fabbrica fordista, l’organizzazione del lavoro operaio, come ne «La città del libro» di Stradella (Pavia), ottantamila metri quadrati di stabilimento e cento milioni di libri pronti per la distribuzione, dove «si riproducono alienazione e sfruttamento, non diversamente che in una miniera di carbone degli anni Cinquanta o in uno scantinato della delocalizzazione produttiva nell’Oriente estremo di casa nostra, sia esso una Chinatown toscana o uno slum di bangladesi vesuviani». È il nuovo «capitalismo autoritario», in attesa che «la rivoluzione tecnologica renda sempre più concreto il sogno inconfessato di ogni capitalista: fare a meno degli operai». Il conflitto tra «sapere operaio» e «sapere aziendale» anche nella quarta rivoluzione industriale si sviluppa sulla nozione di tempo. La digitalizzazione, soprattutto nel mondo dell’industria, ha prodotto una nuova razionalizzazione del tempo: aumento di produttività e intensificazione del lavoro, di carichi e ritmi, eliminazione dei tempi morti, quello che l’ingegnere della Toyota Taiichi Ohno ha definito con cinica efficacia «un sistema che cerca di strizzare acqua da un asciugamano asciutto».
Questo sistema produce l’automazione dei lavoratori, «rappresentati, non di rado, come “ingranaggi” del processo produttivo», spiega un recente studio sul campo, Digitalizzazione industriale (Franco Angeli), del sociologo Dario Fontana. La ricerca, mirata su chi opera ogni giorno nei processi 4.0, è stata condotta tra 676 lavoratori e delegati sindacali: 389 che operano con tecnologia digitale e 287 con tecnologia classica. Gli impiegati coinvolti sono stati 272, suddivisi tra azienda manifatturiera (59 amministrativi e tecnici di laboratorio), bancari amministrativi e informatici (99) e bancari del ramo commerciale (114). Sono state coinvolte otto aziende della provincia di Modena dell’agroalimentare, logistica, metalmeccanica, ceramica e biomedicale. I sistemi di controllo dei lavoratori nel mondo della logistica potrebbero essere moltissimi — il braccialetto elettronico utilizzato da Amazon o l’algoritmo tracciante sugli smartphone dei rider, con un’invasività in crescita sulla vita privata, la «distorsione neoautoritaria» di Facebook, Google, Alibaba, quello che Shoshana Zuboff, docente alla Harvard Business School, ha definito in un suo saggio Capitalismo della sorveglianza (Luiss University press, 2019).
Il rapporto con l’algoritmo si sviluppa in fabbrica con la macchina industriale digitalizzata e nel mondo impiegatizio attraverso il computer. Il rapporto risulta schiacciante: aumenta in modo vertiginoso la velocità, come accadeva già nei telai e nella manovia dell’industria tessile o calzaturiera fordista, e cambia radicalmente il rapporto lavoratore-macchina. Siamo di fronte a dipendenti «con un grado di autodeterminazione quasi nullo». Nell’industria le forme di controllo avvengono tramite il monitoraggio analitico del processo produttivo, mentre nel settore bancario, per esempio, con il tracciamento da remoto delle operazioni di lavoro, oppure attraverso chat che si attivano improvvisamente sul monitor quando si rallenta la produttività. Un settore, quello finanziario, che ha già subito 40 mila esuberi in dieci anni proprio per gli effetti dell’uso di tecnologie nei processi lavorativi.
Oscar Wilde, in un famoso saggio del 1891, L’anima dell’uomo sotto il socialismo, aveva immaginato un lavoro finalmente liberato: «Tutto il lavoro non intellettuale — scriveva —, il lavoro monotono, tutto il lavoro che ha rapporto con cose spiacevoli, dovrà essere fatto dalla macchina. La macchina lavorerà per noi nelle miniere, farà tutti i lavori sanitari, sarà fuochista nei piroscafi, spazzino nelle vie, farà le commissioni nei giorni di pioggia, e tutti gli altri lavori che sono penosi e spiacevoli». Il suo utopismo in un altro passo immagina gli uomini futuri capaci di godere «di un piacevole ozio, grazie al quale potranno meditare cose belle e meravigliose per la loro gioia e la gioia di tutti». Lo scrittore del Ritratto di Dorian Gray che sfidava il perbenismo purtroppo si stava sbagliando.
https://www.corriere.it/la-lettura/