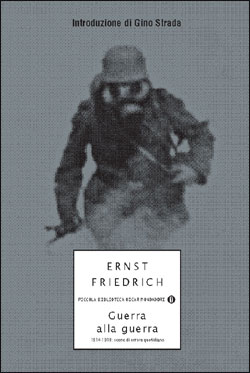Alessandro Piperno è sempre stato un autore con una straordinaria capacità di distacco. Dote rara, in uno scrittore così violento. C’è sempre, nelle sue storie, quel modo quasi fatale di considerarsi oggetto di una colpa e contemporaneamente soggetto di un rancore, come se colpa e rancore fossero due oscillazioni dello stesso movimento. Il suo protagonista si ritrova sempre come una cosa finita in un vortice, un circolo ininterrotto di torti subiti e compiuti, vergogne personali messe – come dicono gli americani – dentro il ventilatore.
Sono queste oscillazioni ad averne fatto un autore di quelli che nel teatro elisabettiano chiamavano revenge plays, tragedie di vendetta: storie di persecuzioni, mattanze, massacri all’arma bianca.
Tuttavia, nonostante questo suo gusto per le scene di lotta, Piperno è sempre stato un formidabile scrittore di distacchi: le sue carneficine narrative sono sempre a distanza; chi legge lo fa attraverso un vetro divisorio fatto di ironia, di linguaggio, di letteratura, separato dall’atto cruento come lo sono i delitti di sangue nell’opera lirica: si vedono i dettagli del massacro, ma non ci si sporca mai di sangue. Piperno ha sempre saputo che la letteratura è anche un’operazione chirurgica, un gioco di misure, distanze, strategie della lontananza.
REVENGE PLAY D’AMORE
Adesso uno legge il libro che Piperno ha dedicato a Proust – Proust senza tempo (Mondadori) – e fra tutti i suoi libri, questo così saggistico e apparentemente professorale sembra quello più intimo, il più confessionale. Sarà perché parla a sé stesso, e parlare a sé stessi è sempre inevitabilmente parlare con un sé stesso che non c’è più.
Sarà che, a una certa età, parlare di un autore che ci ha accompagnato nel corso della vita finisce sempre con l’essere una resa dei conti, una vendetta occulta, proprio di quelle di cui i romanzi di Piperno sono pieni: una revenge play, appunto, ma scritta con l’amore invece che con l’odio.
Ed è quasi commovente, quando si accorge che i conti non tornano: «Il guaio è che non ti senti più vecchio di quando avevi vent’anni. Anzi! Che non sia questo il tormento che la natura infligge agli organismi in dismissione: dilatare a dismisura lo squilibrio tra il corpo ammaccato e i palpiti di un cuore che non si dà pace?».
È, in effetti, la questione: il desiderio come vortice, buco nero, fantasma inaggirabile, che non demorde quando calano le possibilità pratiche di esaudirlo. È il centro dell’opera di alcuni fra i più importanti scrittori contemporanei: McGrath, Cartarescu, Houellebecq: «Aumentare i desideri fino all’insopportabile, rendendo la loro realizzazione sempre più inaccessibile, è il principio unico della società occidentale» (La possibilità di un’isola).
Tutti proustiani, in qualche modo, se – come Piperno fa intendere – la Ricerca del tempo perduto va letta innanzitutto come una grande lotta fra il desiderio e il tempo. Non una partita a scacchi, però: qualcosa di scomposto, di efferato. Quello che scopre il Narratore di Proust, prima di tutti gli altri, è che la lotta per il desiderio ha qualcosa di indecente. Qualcosa di volgare. Non si può lottare per il proprio desiderio e rimanere innocenti.
Nell’agone proustiano non c’è niente di epico. Il protagonista ha una natura «amorfa e cattiva»; il Narratore «è il contrario dell’uomo d’azione, una creatura sedentaria che faceva del proprio ozio d’infermo una specie di ragione di vita». «Sembrava», scrive Piperno, «non vedere l’ora di sbatterti in faccia le tante cose che gli erano precluse: la salute, la realtà filiale, l’amore romantico, i quarti di nobiltà, la memoria, il talento letterario».
Nessuno avrebbe scommesso che il protagonista del Novecento sarebbe stato un individuo sgraziato, lamentoso, introflesso, ipocondriaco. Eppure ha vinto lui: è quello, ancora oggi, il prototipo europeo, ed è lì che nascono movimenti che arrivano fino a noi: vittimismo, gusto dell’autodiffamazione, società del pettegolezzo, narcisismo della fragilità, snobismo mascherato, dittatura dell’infermità, conquista dell’autorevolezza tramite la lamentazione; competitività feroce in ogni ambito della vita: «Amare carnalmente voleva dire, per me, godere di un trionfo su tanti concorrenti».
È la grande sterzata della letteratura verso l’autofiction, di cui infatti ancora siamo qui a discutere: «Proust ha deliberatamente avvelenato i pozzi, creando a tavolino una simbiosi tanto losca quanto inossidabile tra arte e biografia». È il grado zero del contemporaneo.
MEGALOPOLI SENZA SALVEZZA
Questo, d’altronde, Piperno l’aveva capito fin dall’inizio. Non è il primo libro di critica che scrive (non è neanche il primo su Proust); ma è quello in cui l’autore francese viene inquadrato per ciò che è: un istinto assorbito come un veleno, una chiave di sguardo definitiva, l’iniziazione a una grammatica del mondo che difficilmente ti lascerà mai.
Proust ha capito meglio di tutti che il paradiso è sempre perduto e la strada che vi conduce va all’indietro, che l’unico angelo che riusciamo a venerare è quello di Walter Benjamin, che ha gli occhi fissi nel passato.
Su questo paradosso si fonda l’arte del romanzo: «Il Tempo per la narrativa è come l’ossigeno per l’essere vivente, questione di vita o di morte». Il Tempo è una megalopoli senza salvezza, un labirinto con un mostro al centro che impedisce il cammino e divora i più coraggiosi. La memoria è un luogo di mortalità e di punizioni. Lo sa Piperno, che non a caso sottotitolava un suo libro Il fuoco amico dei ricordi.
Lo scopre Proust all’inizio del suo romanzo quando, nelle complicate diplomazie per ottenere la buonanotte materna, impara con dolore che l’infanzia ha una data di scadenza. Il tempo non è solo perduto, ma è di per sé perdita. Del resto, cos’era quell’esordio feroce e insolente che fu Le peggiori intenzioni, se non un cattivo Bildungsroman, un’avvelenata cacciata dal paradiso?
UNA LOTTA CRUENTA
C’è un altro aspetto fondamentale in Proust, che nei suoi saggi Piperno tace, ma nei romanzi invece esplora eccome: la sua formidabile capacità di rappresentare il conflitto di classe. Si pensa sempre, per riflesso automatico, che la messinscena delle lotte di classe le si trovi solo nei ceti sociali più umili. Non è così. La lotta di classe avviene anche dall’alto, e Proust ne è infatti la prova più plateale.
La Ricerca del tempo perduto è spesso il teatro di una faida di classe efferata e cruenta. Si tratta però di una lotta che avviene nella parte alta della piramide sociale, in bilico su un apice stretto e traballante, dove si sta in pochi, caderne è molto facile, e richiede sacrifici violenti per non precipitare (cosa che comunque avviene, se una volgare madame Verdurin può, scalando la catena alimentare, diventare principessa di Guermantes).
In Persecuzione di Piperno avveniva una dinamica simile: il protagonista Leo Pontecorvo che finiva rinchiuso nella propria cantina come un sequestrato di guerra, ostaggio di sé stesso e di una società tanto brutalmente perbenista quanto velatamente sacrificale, era anche lui un precipitato da un’altezza sociale che, nonostante tutti gli sforzi, non era riuscito a conservarsi: una vittima della selezione delle specie.
C’è un passo, in Sodoma e Gomorra, dove in poche frasi Proust inquadra l’atteggiamento sociale dei Guermantes, e sembra di vedere in trasparenza lo schema di comportamento di un qualunque odierno influencer arricchito: «Voi siete uguale a noi, se non migliore, sembravano dire, con tutte le loro azioni, i Guermantes; e lo dicevano nel modo più gentile che si possa immaginare, per essere amati, ammirati, ma non per essere creduti; cogliere il carattere fittizio di questa amabilità denotava, ai loro occhi, buona educazione; crederla reale, era da maleducati».
I fondamenti non scritti del mondo borghese sono rimasti gli stessi: una società divisa in caste, visibili tra loro ma ben poco comunicanti, come i regni dell’aldilà dantesco. Il salotto proustiano non è scomparso, ma ha solo cambiato forma.

Proust senza tempo (Mondadori 2022, pp. 156, euro 19) è un libro di Alessandro Piperno