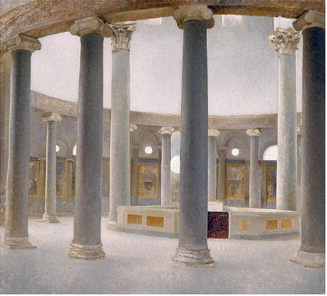Oro ai massimi storici: I prezzi salgono grazie alla ricerca di beni rifugio da parte degli investitori
12 Aprile 2025
Ammanettati e “scaricati”. I primi 40 deportati dall’Italia
12 Aprile 2025FILOSOFIA
«Bisogna mettersi in salvo dalle avanguardie di un postumano che si inginocchia dinanzi alla potenza di manipolazione della tecnica». In uscita le “Opere teoretiche scelte” del pensatore
Per Vittorio Possenti «la grandezza della metafisica sta nella sua necessità, di cui ci si accorge soprattutto quando è obliata. I suoi scribi e farisei ne annunciano la fine “destinale”, entro un irreversibile processo verso l’approdo nichilistico. In ciascun momento il suo sviluppo futuro non è però interamente predeterminato dalle condizioni del passato, per cui sono possibili ripartenze: l’attività filosofica è evento, non destino». Grandezza della Metafisica. Opere Teoretiche Scelte, in due volumi (Mimesis, pagine 684+568, euro 30,00+25,00) e prossimo ad andare in libreria, è il titolo dell’opera-summa del filosofo ottantasettenne, a lungo docente di Filosofia morale e politica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che raccoglie la parte maggiore e più significativa dei suoi studi teoretici. « La “cosa” qui trattata – spiega – è una scienza teoretica del reale: una filosofia conoscitiva, capace di esprimersi ai suoi vari livelli. Una rinascita dopo l’epoca degli abbandoni e delle assenze: morte della filosofia, di Dio, dell’uomo, della civiltà, dell’Europa. Tanta parte della metafisica moderna è giunta a consumazione: il suo ciclo si è concluso e bisogna riprendere su altre basi il cammino. Venire a capo della grandiosa questione del tramonto e dell’aurora della metafisica è il compito delle ricerche qui raccolte».
Ma quale metafisica, professor Possenti?
«Noi operiamo decisamente in favore del realismo conoscitivo e della metafisica dell’essere e dell’ente, capace di traversare i secoli, rinnovandosi nella fedeltà alle sue intuizioni più sorgive. Le sue inesauribili questioni suonano: “l’ente è” e “che cosa è l’ente?”. Dobbiamo riprendere il discorso sull’essere e sull’ente puntando sul disvelamento delle sue virtualità inespresse, intrecciare le questioni sulla verità, il nichilismo, il male, la libertà, la tecnica, l’inizio e l’ultimo. La discussione si confronta con gli antichi, i medievali (Tommaso d’Aquino) e in specie con i moderni; Kant, Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, Husserl, Bergson, Gentile, Maritain, Heidegger, Habermas, Bontadini, Severino, per valutare quali siano in grado di ispirarci oltre l’impasse odierna e per una ripartenza».
Un’impasse che, muovendo dalla questione del nichilismo teoretico, sembra mettere in crisi l’idea stessa di verità?
« Per Nietzsche l’essere e la vita esprimono volontà di potenza. Dichiarata la morte della metafisica, Zarathustra indicherà il cammino verso l’oltreuomo: la filosofia occidentale, “avvelenata” dall’ottimismo teoretico ed esistenziale di Socrate, andrebbe per Nietzsche rigettata. Heidegger riterrà invece che la metafisica della volontà di potenza nietzscheana costituisca il compimento della metafisica occidentale che ha obliato l’essere e ha considerato l’ente come oggetto maneggiabile dalla macchina tecnologica. Nella volontà di potenza dell’oltreuomo si esprimerebbe la metafisica del soggetto moderno, l’Io incondizionato che pone l’essere e lo “crea”. Secondo Heidegger l’errore insuperabile della filosofia occidentale consisterebbe nell’oblio dell’essere, e in ciò si realizzerebbe l’apice del nichilismo. Nell’elaborazione sul nichilismo mi distacco nettamente da quelle di Nietzsche, di Heidegger e di Severino, tra loro conflittuali; il nichilismo non è il destino dell’Occidente, ma il suo problema. La determinazione del concetto di nichilismo teoretico costituisce un polo primario della mia ricerca, senza di cui il termine “nichilismo”, inflazionato come pochi altri, non significa più nulla».
Eppure è diffusa un’opzione per la postmetafisica, o per il rigetto della metafisica… «Sono stati proposti negli ultimi decenni alcuni “nuovi realismi”, a mio parere alquanto incompleti. La tradizione vigorosa del realismo classico ha le carte in regola per dire la sua sulla conoscenza dell’ente e dell’essere e sul concetto di verità. Oltre all’heideggeriano oblio dell’essere si è verificato su altri e più concreti piani un oblio del realismo. Nel tema del realismo si decide anche sul nesso tra pensiero e realtà (essere): il primum non è il pensiero ma l’essere/ente. È la realtà che pone le condizioni per un pensiero veritativo, non il contrario. L’intelletto ricercante si volge verso l’esistenza e l’esistente per coglierne il “mistero”, non legifera a priori riguardo all’esistente ma lo scopre lentamente a posteriori».
Qual è allora il nesso tra il realismo filosofico e l’intuizione intellettuale? Nelle metafisiche (moderne e/o neoparmenidee) che si richiamano genericamente all’essere, la partenza deve esse fatta dall’essere astratto, vuoto e indeterminato, o invece dall’ente concreto?
« Nella questione della conoscenza e del realismo si è dato nei due volumi un particolare rilievo al tema dell’intuizione intellettuale, una chiave che apre o chiude molte porte. Uno spartiacque senza di cui larga parte del pensiero moderno diventa incomprensibile. Per Kant, Hegel, Gentile, Severino l’intelletto è l’organo del pensiero astratto, non il nous dei Greci né l’intellectus dei Medievali. È una sciagura che ancora oggi, a due secoli e mezzo da Baumgarten e Kant che inaugurarono la fatale inversione tra Verstand e Vernunft, tra intellectus e ratio, dando il primato alla seconda, molti ritengano che l’intelletto si riduca quasi a intelletto calcolante e astratto! Con questo esiziale equivoco, si taglia alla radice la cooperazione nascosta ma fondamentale tra intellectus teoretico che percepisce l’ente e l’essere e che li elabora concettualmente, l’intuizione creatrice poietica (poetica) dalle cui profondità sgorga la poesia, alle radici dell’anima e della vita, e la fides quaerens intellectum nell’atto religioso. Il sapere dichiarativo, quello religioso e la parola poetica possono procedere insieme per un buon tratto. Una conoscenza integra della vita esige appunto l’apporto di vari approcci».
E tra logica e metafisica che rapporto si instaura?
« Dobbiamo curare la mortale malattia del logicismo, culmine del razionalismo moderno che ha disseccato il rapporto con la vita. I pensatori “logicisti” come Hegel, Gentile e Severino si distinguono per il costante tentativo di logicizzare il reale, senza considerare l’indeducibilità dell’esistenza dall’essenza: l’esistenza si “aggiunge dal di fuori” all’essenza». L’identità tra logica e metafisica è il pericoloso sogno dell’idealismo hegeliano, dell’attualismo e del severinismo.
La tradizione della filosofia dell’essere e dell’ente è stata coinvolta nell’operazione heideggeriana di destructio oppure è in potenza attiva verso il futuro, mentre altre scuole filosofiche sono ormai spente?
«Una metafisica si mantiene in atto se riesce a captare i nuovi problemi e le nuove domande, cercando di dar loro una risposta fondata. Essa dovrà ripensare se stessa alla luce dei suoi principi per metterli alla prova delle nuove sfide. Nei due volumi circola una meditata scelta in favore della metafisica dell’essere e della sua capacità di operare positivamente nel contesto ideale di oggi e domani. Ho cercato di prestare ascolto a un’antica sapienza sull’ente e sull’essere, capace di traversare i secoli e di rinnovarsi nella fedeltà alle sue intuizioni più sorgive, secondo il detto del vetera novis augere ».
Secondo lei può avvenire un progresso nella vicenda millenaria della filosofia?
« Rispondo positivamente. Nel moto incessante della ricerca è accaduta una “terza navigazione”, consistente nell’oltrepassamento della seconda navigazione platonico-ellenica (cfr. il Fedone), in base a una nuova concezione dell’essere, dell’ente, del finito e dell’infinito, procedente dalla filosofia dell’essere dell’Aquinate e dal suo atto inaugurale tutt’altro che spenti. La generazione dei grandi tomisti del ’900 (cito qui soltanto Fabro, Gilson e in special modo Maritain) ha costituito una preziosa fonte di ispirazione. Essi hanno illustrato e prolungato la solidità dell’impianto metafisico di san Tommaso, intendendolo come un acquisto per sempre. La “terza navigazione” e il “teorema di creazione” che le si connette, segnano un punto di svolta della metafisica occidentale, che non è stato intaccato dal razionalismo e dall’idealismo moderni. Conviene ricordare questi nuclei oggi quando domina l’antropocentrismo».
Quali sono i nessi e differenze tra conoscenza scientifica e sapere metafisico?
« L’importanza delle scienze consiste nell’aumentare indefinitamente l’ambito dell’esperito e dell’osservato – senza mai raggiungere la totalità dell’esperibile e dell’osservabile – ed elaborare un sapere su quanto via via emerge dal seno inesauribile della physis. La creatio continua produce sempre nuove imprevedibilità e possibilità: il reale di oggi è il possibile di ieri. L’evoluzione della vita non è una marcia di progresso ma un’esplorazione di possibilità. Queste considerazioni debbono stimolare la riflessione del filosofo, non decapitarla. La ricerca metafisica e quella scientifica potranno aiutarsi a non confondere cose diverse: la creazione ( creatio ex nihilo sui et subjecti) con il Big Bang, per esempio, oppure l’intelligenza umana e l’IA. Mai dimenticare l’avvertimento di Horkheimer: “Nel dominio sulla natura è incluso il dominio sull’uomo”. Si entra così nel capitale tema della tecnica, in cui bisogna mettersi in salvo dalle avanguardie di un postumano che si inginocchia dinanzi alla potenza di manipolazione della tecnica».