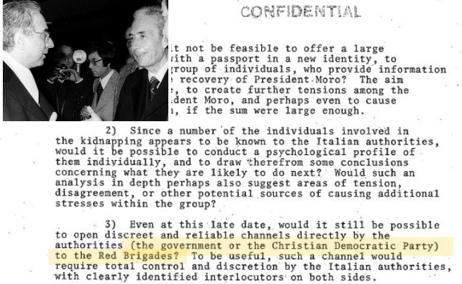L’annuncio era atteso. Il governo italiano ha dato via libera alla cessione della rete di Tim al fondo americano Kkr. Il Tesoro, quindi, non eserciterà il potere di veto di cui dispone in base alle norme del golden power. Difficile immaginare il contrario, visto che il ministero dell’Economia fin da subito ha sponsorizzato l’operazione ed è pronto a investire fino a 2,2 miliardi di euro per rilevare una quota del 20 per cento nell’asset strategico messo in vendita dal gruppo telefonico.
L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo, ma servirà ancora qualche mese prima di arrivare alla separazione della rete dal resto dell’azienda, in primis i servizi commerciali. L’opposizione attacca. Pd e Cinque Stelle ieri hanno protestato contro quella che viene definita la “svendita di un asset strategico”, per usare le parole dell’ex ministro Stefano Patuanelli.
STATO COMPRATORE
A ben guardare, però, sui mercati finanziari va in scena un copione diverso. Lo Stato non vende, anzi. Per il momento assistiamo all’apparente paradosso di un governo che in autunno ha annunciato un piano di privatizzazioni da 20 miliardi (l’1 per cento circa del Pil), ma si vede costretto dalle circostanze a muoversi in direzione contraria. Al momento, infatti, lo Stato è compratore, più che venditore.
Entro qualche settimana, come detto, il Tesoro investirà un paio di miliardi nella rete Tim. E poi c’è l’Ilva. Se Mittal, attuale azionista di maggioranza, verrà accompagnata all’uscita, toccherà all’azionista pubblico farsi carico dei fondi necessari a tenere in vita la più grande acciaieria d’Europa in attesa che si manifesti un compratore disposto a investire. Quanto costerà il salvataggio? Le variabili in gioco a cominciare dall’eventuale ricorso all’amministrazione straordinaria sono troppe per indicare una cifra precisa. Di certo però il conto finale difficilmente sarà inferiore al miliardo di euro e potrebbe arrivare al doppio o al triplo se l’intervento pubblico dovesse protrarsi a lungo per finanziare, tra l’altro, anche i costi della cosiddetta decarbonizzazione, per ridurre l’impatto ambientale dell’impianto.
GIORGETTI RASSICURA
Il 2024, quindi, è iniziato all’insegna dello Stato azionista, anche se il ministro dell’Economia, impegnato ad arginare la slavina del debito pubblico, ne avrebbe fatto volentieri a mano. Sul fronte delle privatizzazioni, invece, restano le dichiarazioni d’intenti del governo, ma poco di più.
Da Davos, dov’è ospite dell’annuale Forum, il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti rassicura e annuncia: «Gli investitori internazionali si sono dimostrati molto interessati al piano di privatizzazioni». Un piano, ha riconosciuto il ministro, che «è solo ai primi step». A novembre, infatti, è andata in porto, con ottima scelta di tempo e buoni risultati, la vendita in Borsa del 25 per cento del Monte dei Paschi di Siena. L’operazione ha fruttato circa 920 milioni, ma il Tesoro, che ora possiede il 40 per cento circa dell’istituto si è impegnato con la Commissione Ue a uscire dall’azionariato entro la fine dell’anno. Ai prezzi di questi giorni la quota in mano pubblica vale circa 1,6 miliardi, anche per effetto dell’ottima performance borsistica del titolo Mps, che ha fatto segnare un rialzo del 42 per cento nell’arco di dodici mesi.
DA SIENA ALLE POSTE
L’addio a Siena, se davvero avverrà nei tempi previsti, sarebbe però solo il prima passo di un percorso molto più lungo. Per arrivare agli annunciati 20 miliardi di privatizzazioni il governo dovrà mettere in vetrina altri marchi importanti dell’industria di Stato. Giorgia Meloni, nella conferenza stampa del 5 gennaio ha fatto il nome delle Poste e delle Ferrovie. Nel primo caso, ha detto la premier, verrebbe «ridotta la quota di partecipazione statale» mantenendo il controllo pubblico sull’azienda, che è quotata in Borsa.
Secondo Meloni c’è anche la possibilità di far entrare i privati nel capitale di Ferrovie, che invece è per intero di proprietà dello Stato. In altre parole, il governo pensa di vendere il 14 per cento di Poste, scendendo al 51 per cento dall’attuale partecipazione del 65 per cento. Non è escluso però che il ministero dell’Economia ceda per intero la sua quota del 30 per cento (un altro 35 per cento è in portafoglio a Cassa depositi e prestiti). Poste in Borsa ora vale 13 miliardi e quindi l’incasso per lo Stato potrebbe variare tra 1,9 e 4 miliardi circa. Ben più complicata appare un’eventuale privatizzazione di Ferrovie, che controlla anche Anas. Qui va deciso che cosa vendere esattamente. Tutto il gruppo? La sola Trenitalia? E che fare della rete? Servirà tempo per sciogliere questi nodi. Forse un anno, più probabile almeno un paio.
Al momento però, sembra quantomeno azzardato stimare quanto potrebbe essere il ricavato di una vendita parziale del gruppo Fs. Difficile che si superino i 4 miliardi, secondo gli analisti che nelle settimane scorse si sono esercitati sul tema.
Tra Poste e Ferrovie, quindi si potrebbe arrivare intono ai 6-7 miliardi. Una cifra ancora distante dal traguardo dei 20 miliardi. Il governo dovrà inventarsi qualcos’altro. Magari mettendo sul mercato piccole tranche delle quote che controlla in gruppi come Eni, Enel o Terna. E con le ipotesi si moltiplicano anche le incognite, per operazioni che comunque vanno preparate con cura. Nella speranza che in Borsa non finisca la stagione dei rialzi.