
Davanti al dolore degli altri. I suoi ritratti sono al Centro Pecci di Prato
16 Febbraio 2025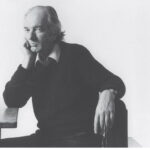
Bernhard al centro del “cono” del ’900
16 Febbraio 2025SCAFFALE Raccolta in due volumi di cui il primo va dal 1962 al 1968 e il secondo dal 1968 al 1972
È tornata in libreria, a cura di Eugenio Gazzola e pubblicata da Pgreco/Filorosso, l’antologia in due volumi della famosa rivista i «Quaderni piacentini» (il primo volume va dal 1962 al 1968, pp. 550, euro 25; il secondo volume va dal 1968 al 1972, pp. 552, euro 25). Curata a suo tempo da Grazia Cherchi e Luca Baranelli (Gulliver, 1977-1978), è stata fondata nel marzo del 1962 da Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi, a cui si aggiunse dal 1966 Goffredo Fofi; i primi due numeri uscirono ciclostilati. Ebbe così inizio la più importante rivista della Nuova sinistra italiana, un’avventura intellettuale che attraversò quasi un ventennio di profondi mutamenti e di grande partecipazione civile.
IL PRIMO a sostenere l’iniziativa fu Franco Fortini che l’anno prima aveva scritto La lettera ad amici di Piacenza. Ma inizialmente fu importante anche il legame di amicizia con Raniero Panzieri, Danilo Montaldi e Giovanni Pirelli. Partendo da un’ottica locale, ma non provinciale, la rivista divenne nel giro di poco tempo un importante laboratorio politico e culturale e si distinse subito per lo spirito critico e anticonformista e per la sua apertura nazionale e internazionale, in netta opposizione al neocapitalismo e all’imperialismo, al riformismo della sinistra storica e al centro-sinistra, come organo di dibattito e di confronto fatto da giovani e rivolto principalmente ai giovani, per le sue rubriche di contro-informazione («Il Franco tiratore», «Libri da leggere e da non leggere» e «Cronaca italiana»), in cui i direttori conducevano la loro battaglia contro la «sinistra rispettosa», l’industria culturale e i mostri sacri della cultura italiana (Moravia, Pasolini, il gruppo ’63, ecc.) e trattavano gli argomenti passati sotto silenzio dalla stampa di regime e dalla Rai-Tv. Fino al 1968 essa pubblicò testi poetici di alcuni dei maggiori poeti italiani ed europei (Brecht, Enzensberger, Majorino, Cesarano, Vittorio Sereni, ecc.) e per tutta la sua durata una rubrica di cinema tenuta costantemente da Goffredo Fofi, molto amata dai lettori.
La redazione consiglia:
Piergiorgio Bellocchio, l’ordito intellettuale di un «testimone secondario»
SULLE SUE PAGINE s’incontrarono molti dei maggiori cervelli del marxismo critico: oltre al già citato Fortini, Sergio Bologna, Augusto Vegezzi, Alberto Asor Rosa, Renato Solmi, Giovanni Giudici, Roberto Roversi, Luciano Amodio, Cesare Cases, Edoarda Masi, Sebastiano Timpanaro, Giovanni Jervis, Elvio Fachinelli, Luigi Bobbio, Guido Viale, Vittorio Rieser, Federico Stame, Michele Salvati, Carlo Donolo, ecc. I principali temi trattati furono il rapporto tra gli intellettuali e la politica, fra letteratura e rivoluzione, la lotta antimperialistica nei paesi del terzo mondo, la Scuola di Francoforte, la nuova sinistra americana e le lotte antirazziali, la guerra del Vietnam, la rivoluzione culturale cinese, il ’68 in Italia e nel mondo, il maggio francese, l’autunno caldo eccetera.
I due volumi dell’Antologia interessano il periodo cosiddetto eroico della rivista (1962-1972), quello più incisivo e innovativo. Successivamente i «Quaderni piacentini» diventarono una rivista prettamente teorica, un po’ dottrinaria e di non facile lettura. Di questo secondo periodo tra i maggiori collaboratori si possono citare i nomi di Francesco Ciafaloni, Alfonso Berardinelli, Bianca Beccalli, Giovanni Raboni, Augusto Graziani, Luisa Muraro. Nel 1980 si concluse la prima serie della rivista. In questo arco di tempo essa fu totalmente finanziata e autogestita dai suoi fondatori e questo ha permesso di mantenere la massima autonomia e l’indipendenza dal contesto politico e culturale: «Facevamo tutto da soli – ha dichiarato Piergiorgio Bellocchio – dalla redazione alla tipografia, alla distribuzione. Giravo l’Italia con il baule della macchina pieno di pacchi della rivista, andavo personalmente dai librai per convincerli a metterla in vetrina. All’inizio era dura. Ma in poco tempo arrivammo a 4-5 mila copie di vendita. Un vero miracolo».
ESSI NON SEGUIRONO MAI una linea politica ben definita e non si legarono a nessun gruppo, ma nell’insieme hanno rappresentato l’area della sinistra antiistituzionale. Infatti Sebastiano Timpanaro definì la rivista piacentina «il più libero e vivo luogo d’incontro tra diversi gruppi dell’estrema sinistra italiana». La seconda serie passò fino al 1984 all’editore Franco Angeli, ma la parabola della Nuova sinistra italiana si era chiusa da un pezzo.





