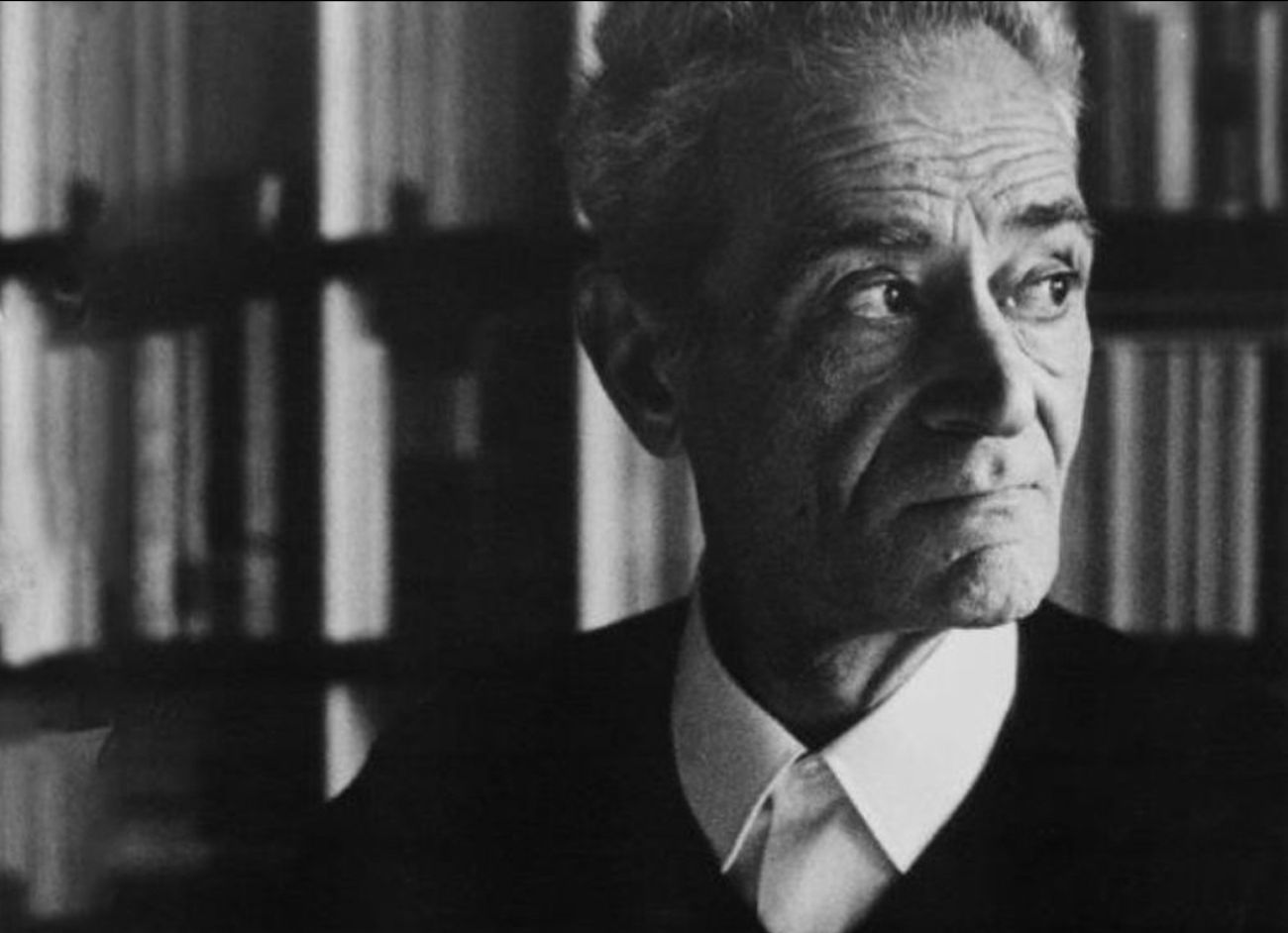
I poeti invisibili maestri del tempo così lontani dalla rete e dai talk show
21 Marzo 2023
Pd e 5S oggi e domani alla prova delle armi
21 Marzo 2023Emanuele Trevi
«Più si conosce la poesia più ci si accorge», ha scritto una volta Cristina Campo, «che essa è figlia della liturgia», considerabile come il suo «archetipo». Il primo esempio a sostegno dell’idea è quello di Dante, e suona abbastanza ovvio; più interessante è il fatto che a Dante venga accostato Boris Pasternak, perché il poeta russo, assieme a tanti contemporanei, incarna una strada verso l’assoluto ancora più preziosa e imprevedibile, scavata com’è tra le macerie delle immani catastrofi materiali e spirituali del suo tempo.
Mi è sempre sembrato questo il centro del pensiero di Cristina Campo, nata cent’anni fa, e il motivo del fascino perdurante del suo pensiero e della sua scrittura: la capacità di non arrendersi al sentimento della disfatta, della pienezza perduta, e di vivere il proprio destino come se fosse sempre possibile ricomporre i significati perduti, riannodare i fili sottilissimi della visione e della comprensione. Se il temperamento mistico di questa grande scrittrice, suprema orefice della lingua italiana, si è sempre rivolto all’invisibile come al nord magnetico della sua bussola interiore, è pur vero che è il visibile, la tetra evidenza del principio di realtà, il nostro punto di partenza. In una delle sue pagine più famose, aveva dichiarato di amare il suo tempo, nonostante tutto il suo carico di orrori e disincanti, proprio perché il tempo «in cui tutto vien meno» è il vero «tempo della fiaba».
Nel pensiero di Cristina Campo, vale la pena ricordare, «poesia» e «fiaba» sono praticamente sinonimi, e anche in quest’ultima le parole non si limitano a designare i fatti e le cose, ma si organizzano in una «disposizione quasi liturgica». Identica, per l’umanità di oggi, è la posta in gioco della poesia e della fiaba: il bene «perduto e dimenticato», nascosto in fondo ai «più orridi labirinti». È un punto cruciale, che distingue Cristina Campo da tanti ingenui misticismi che pretendono di puntare direttamente all’invisibile, evitando la porta stretta del visibile, come se fosse possibile far finta di non vedere quello che abbiamo di fronte agli occhi.
I simboli della poesia e della fiaba sono come dei ponti: capaci di condurre chi sappia meditarli dalla prigione della necessità al riconoscimento del proprio destino, che è la più grande libertà a cui si possa aspirare. È una specie di interminabile pedagogia dell’anima, quella che offrono le immagini delle Sacre Scritture, delle favole, dei miti, della poesia: punti di convergenza e di sintesi tra il naturale e il sovrannaturale, come il roveto ardente, il grillo parlante, le zucche di Cenerentola. Ci insegnano la legge fondamentale della vita: il mistero non si nasconde nell’inconcepibile e nell’invisibile (sarebbe, questo, un falso mistero, una tentazione diabolica) ma si manifesta «per allusioni celate nel reale». Tutto ciò presuppone, prima di ogni altra attitudine, un’arte rigorosa e sottile dell’interpretazione, una capacità di andare oltre i significati letterali delle parole e delle cose. Perché noi viviamo nel visibile, ma non dobbiamo concedergli un’«onnipotenza» che sarebbe solo una forma irrimediabile di cecità. Leggere davvero il mondo significa imparare a muoversi tra i suoi vari livelli di significato, come se procedessimo scostando dei veli, in direzione di quella verità che scopriremo essere nient’altro che il punto da cui siamo partiti.
La meta finale coincide con l’infanzia, e il nostro è un «avanzare di ritorno», come dice un’espressione del gergo dei marinai che la scrittrice amava molto.
Si può capire da questi rapidi accenni che quella che Cristina Campo tributa ai suoi poeti preferiti sia una forma di devozione molto più che un’ammirazione letteraria in senso stretto. Che si tratti di classici come Gaspara Stampa o John Donne, o di contemporanei come Marianne Moore o William Carlos Williams, il grande poeta è sempre un mediatore, ed è difficile distinguerlo dal santo. Potrei citare molte pagine, ma mi basta ricordare, tanto è esemplare della concezione di Cristina Campo, lo stupendo saggio su John Donne pubblicato nel 1971, come introduzione a una scelta di Poesie amorose e teologiche, da lei stessa tradotte. Già il titolo di questo prezioso libretto uscito nella «Serie bianca» di Einaudi è molto significativo. Non suggerisce una gerarchia, ma uno sviluppo spirituale coerente. Quello del grande poeta inglese è un itinerario, un «affilarsi» della mente che ha la sua necessaria origine nel più carnale, nel più terreno degli amori, quello per sua moglie Anne. Il passaggio dalla poesia amorosa alla poesia teologica, dopo la morte di Anne, non è una conversione che rinnega il passato, ma un progressivo ampliarsi del senso della realtà.
Nel 1971, oltre all’antologia di John Donne, Cristina Campo pubblicò anche un saggio intitolato Sensi soprannaturali, che per molti aspetti può essere considerato come il punto di approdo del suo pensiero, la sua formulazione più compiuta. Non è un saggio di critica letteraria, e tratta di argomenti impervi come la «vita spirituale del corpo» e la decadenza dei riti. Ma è da vera poetessa e interprete di poeti la convinzione che «nulla è soltanto metaforico nel dominio dell’invisibile». Là dove la bellezza e la verità (o il visibile e l’invisibile) finalmente coincidono, «la parola è condizione della sostanza come la sostanza lo è della parola». È proprio questa la lingua della favola, della poesia, e nessuno ha saputo coglierne il suono, quasi impercettibile tra i rumori del mondo, come Cristina Campo.





