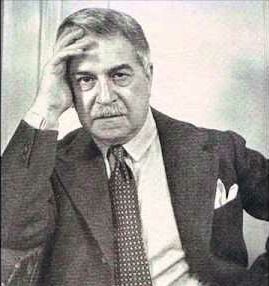Ha radici profonde il mito della separazione tra «le due culture», cioè il divorzio tra una scienza che vuol spiegare ogni fenomeno affermandone la piena calcolabilità e un sapere «umanistico» che, sciolti gli ormeggi dal porto sicuro dei dati, si abbandona alle suggestioni dell’indeterminabile, evoca, affascina ma in ultima istanza, dicono gli scientisti, non «conosce» davvero. Radici che nel sottosuolo della cultura moderna si raccolgono intorno a una torsione fondamentale, vecchia ormai di due secoli, impressa al concetto di metafisica: ora come ricerca di verità intellegibili che trascendano il pantano in cui si agitano i nostri sensi, ora come tentativo di assicurare il tumultuoso divenire sotto l’egida di un principio primo immutabile, ora come fumosa astrazione antiscientifica, metafisica è divenuta la parola, sancisce Hegel, «davanti alla quale ognuno, più o meno, si affretta a fuggire come davanti a un appestato».
Oltre i limiti prospettici imposti da questa fuorviante torsione (limiti che condizionano gran parte della nostra civiltà) ci conduce l’ultima, fondamentale opera filosofica di Massimo Cacciari, Metafisica concreta, compimento di un lungo percorso teoretico avviato nel 1990 con Dell’inizio. Un testo potente che dialoga da pari a pari con i grandi del passato per gettare luce sulla nostra destinazione al pensare, cioè all’atto «che caratterizza quel genere dell’essente che siamo» noi umani e che ha l’episteme, dunque «la scienza di ciò che è», come proprio fine. Cacciari intrattiene dei densi corpo a corpo con, tra gli altri, Parmenide, Platone, Aristotele, Spinoza, Leibniz ma anche con Heidegger ed Emanuele Severino, le cui apparenti assonanze (sulla tecnica, sul destino dell’Occidente, sul nichilismo) nascondono un dissidio decisivo per capire la filosofia del Novecento. Ma dialoga anche con chi nella matematica e nella fisica (Brouwer, Feynman, Heisenberg) ha contribuito a scardinare la fede nell’esaustiva calcolabilità del reale.
In origine e fino all’arrivo del positivismo, chiarisce Cacciari, il termine metafisica non alludeva ad un überwelt, ad un altro mondo rispetto a ta physika, cioè alle realtà portate all’essere da quell’infinito generare, physis, da noi tradotto con la parola «natura». La filosofia nasce in Grecia come ricerca inesauribile della verità dell’essente, di ciò che è in questo mondo, non in qualche regno ideale scisso dalla realtà in cui siamo immersi. Certo poi per conoscere physis è necessario anche «un guardare in alto» che però, scrive Cacciari, «è l’opposto di stare col naso all’insù e cadere nel pozzo suscitando l’ilarità dell’intelligente servetta tracia».
Nessuna astrattezza del pensiero filosofico che snobberebbe la vita quotidiana, insomma: il guardare in alto a cui pensa Cacciari significa, al contrario, guardare al fondo degli oggetti d’esperienza e pure al fondo di noi stessi. Significa capire che ogni essente, percepito dapprima nei confini visibili che lo definiscono, se lo vogliamo conoscere davvero ci rinvia inesorabilmente oltre quei confini, verso un’origine che resta però indeterminata, apeiron, priva di limiti (oggi anche molti scienziati, un secolo dopo la scoperta della relatività e della meccanica quantistica, ne sono ben consapevoli: con loro il dialogo, per il filosofo, è fecondo e necessario). Tale rinvio non separa, non ci allontana di un millimetro da ta physika, bensì ci avvicina al loro cuore in quanto è l’insieme di tutte le possibilità di ogni essente e di tutta la sua storia: un insieme impossibile da ricostruire, certo, ma a cui dobbiamo puntare e su cui dobbiamo indagare senza sosta, perché da esso soltanto emerge ciò che della cosa esperita si offre alla nostra vista e al nostro pensiero. È un trascendere la cosa necessario per poterla davvero comprendere e per prendersene cura. Immagine paradigmatica di questo principio che sta «oltre tutte le essenze» è il sole descritto nel mito della caverna di Platone, di cui Cacciari offre una lettura perfetta. Il filosofo, stimolato dalle contraddizioni del mondo sensibile che risvegliano la sua anima, si libera dai ceppi, dal buio e dalla tirannia delle opinioni, si converte e risale a fatica verso l’uscita della caverna e verso quel Bene, Agathon, che non è affatto un «superente» separato e incorruttibile: è, invece, la luce che rende possibile, ad un tempo, l’essere delle cose e il nostro vederle, è la luce che «ci consente di cogliere i fenomeni come un Tutto e non come un mucchio di apparenze».
Ecco cosa cerca la vera scienza: relazioni oltre l’apparenza che isola i fenomeni nella loro calcolabilità e manipolabilità. Cerca to xynon, «il comune». E «non in un’astratta separazione dall’aisthesis (percezione), ma nel connettere secondo forme necessarie le apparenze che in essa si danno». La metafisica concreta (il prefisso met a, in greco, significa «oltre», certo, ma anche «con») cerca la trama lucente di quel Tutto a cui nessuna scienza, anche la più iperspecialistica, può davvero voltare le spalle. Da qui il compito del filosofo che, lungi dal congedarsi dalle technai, non accontentandosi di una pur virtuosa propensione odierna al dialogo interdisciplinare, incarna il dialogo fitto con chiunque «ricerchi».
Qui si raccoglie da sempre, del resto, l’essenza politica del suo destino, espressa dalla celebre immagine platonica del reggitore-filosofo. Nessuna prevaricazione della teoria che si imporrebbe «dall’alto» sulla vita pratica e sulle scienze particolari (i fallimenti politici di Platone a Siracusa ne sono la conferma e lui ce li racconta nella Settima lettera proprio per farcelo capire). Un ruolo politico del filosofo che, attenzione, non è ancillare o successivo a quello teoretico. Del resto, come afferma Eraclito, «una e una sola è la via che va in alto e la via che va in basso». Non è filosofo, dice Socrate, chi compie solo l’ascesa e poi si sistema fuori della caverna «credendosi migrato in vita nell’isola dei Beati».
La ridiscesa al fondo della caverna per cercar di liberare i concittadini ancora schiavi dell’ignoranza (ma questa è una domanda che pongo io, da lettore) è raccontata da Platone come un momento successivo solo a causa della diacronia necessaria alla narrazione? Narrazione che dunque, a sua volta, rinvia a una sincronia indicibile dei due movimenti del mito, la salita e la discesa? Forse anche il testo platonico, in modo deliberato, è un essente che rinvia ad un principio «oltre tutte le essenze» che non si può definire e tantomeno mettere per iscritto, ma che pure si può e si deve provare a «vivere» per agire filosoficamente e politicamente. Per dare forza, insomma, alla metafisica concreta a cui pensa Cacciari, che a me pare una proposta filosofica tra le più audaci e necessarie del nostro tempo.