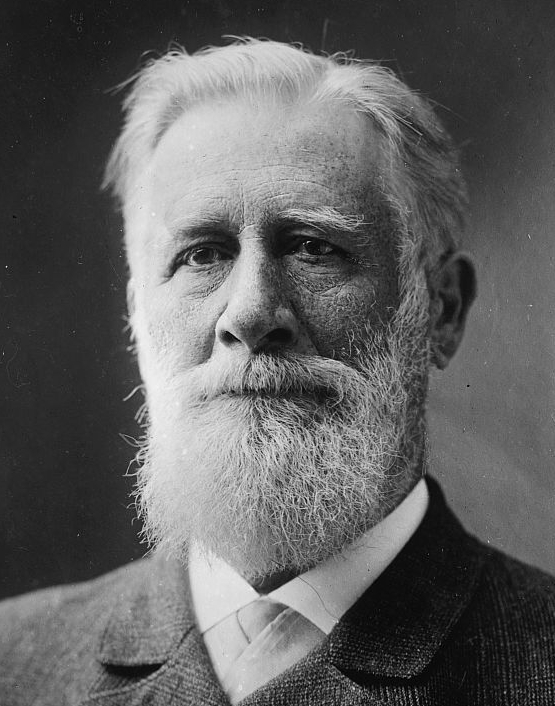Nel febbraio del 1954 «Il travaso delle idee» – uno dei giornali umoristici più popolari d’Italia – pubblica la sua vignetta sul Festival di Sanremo. Due passanti osservano una folla vociante. Uno dice: «Di nuovo i capannelli in galleria! Sostengono che Pella e? meglio di Fanfani?». L’altro risponde: «No, che Piripicchio, piripacchio e? meglio di Una barca torno? sola». Il riferimento rispettivamente a due dei politici democristiani e a due dei brani del Festival di Sanremo più noti in quel momento è poco trasparente, a settant’anni di distanza. Il succo è però chiaro: in occasione di quella che sembrerebbe essere una normale rassegna musicale, un’intera nazione si ferma per discutere di canzoni. Molto poco è cambiato da allora – e in effetti, la stessa battuta funzionerebbe oggi sostituendo i nomi con «Salvini e Meloni» e «Tuta gold e Sinceramente». Appena alla sua quarta edizione, Sanremo era già quello che è oggi: un leviatanico generatore di discorsi, suoni, opinioni, posizioni, gusti. Uno specchio del Paese, della società, della cultura, del mondo. Con il tempo abbiamo però capito che, se Sanremo è uno specchio, è uno specchio deformante, e che del mondo ci rimanda una versione grottesca e patinata – oppure al contrario a bassa risoluzione, come nelle immagini disturbate delle vecchie tv a tubo catodico. Abbiamo anche capito che la luce ci mette del tempo a rimbalzare sulla sua superficie sgargiante, e arriva a noi non solo distorta, ma anche con un certo ritardo.
La storia della musica pop attraverso Sanremo (e viceversa) è la storia di uno sfasamento. Tutte le novità sono passate dal Festival fuori tempo massimo: il rock’n’roll arriva nel 1960. Il beat è accolto quando la British invasion è già cosa vecchia. In anni recenti, la trap ne è stata attratta quando l’iniziale spinta trasgressiva era nella fase discendente della sua parabola. Sanremo assorbe le innovazioni quando sono già state accettate dal mondo intorno, e a sua volta contribuisce a normalizzare quello che passa attraverso il suo gargantuesco sistema digerente: il rap a Sanremo è sempre un po’ meno rap, il rock un po’ meno rock, il cantautore indie un po’ meno arguto. Per quanto lo si tenda a descrivere come tale, il Festival non è però un essere senziente. È parte della cultura in cui esiste, e organizza la sua agenda su quella dell’industria della musica. Negli anni 50 la formula del concorso di canzoni era funzionale ad alimentare l’editoria musicale. Nei 60, a vendere i nuovi dischi in vinile. Negli 80, ripensato come spettacolo televisivo prima che come gara fra interpreti, il Festival è diventato quello che è ancora oggi… o almeno, quello che è stato fino a poco tempo fa. La rivoluzione nell’era del tardo-baglioniano/primo Amadeus (ovvero l’ultimo quinquennio), in cui abbiamo assistito a un generale svecchiamento dell’offerta musicale e del target di riferimento, è in effetti più figlia di Spotify che non dell’operato di direttori artistici illuminati. Una nuova generazione di musicisti che esisteva grazie allo streaming si è costruita un pubblico passando per Sanremo, e Sanremo si è a sua volta ripensato come vetrina per lo streaming, moltiplicatore di visibilità – e dunque di ricavi – un po’ per tutti, complice il suo ritrovato carattere transgenerazionale ed ecumenico.
Ma se il posto del Festival nel mondo sta cambiando – e dunque diverso è il riflesso distorto che del mondo ci rimanda – non è solo per merito (o per colpa) delle canzoni. Il 2023 era stato l’anno di Sanremo sui social, in coerente ritardo sulla timeline globale. Chiara Ferragni aveva lanciato una diretta Instagram dal palco dell’Ariston, con annessa multa (confermata l’altro giorno) per pubblicità occulta a Rai, che mentre negli stessi giorni apriva un suo account su TikTok. Il 2024 ha confermato la direzione, e non poteva essere altrimenti. Ma in quanto piattaforme audiovisive che si alimentano e generano profitto assorbendo il tempo dei loro utenti, TikTok e Instagram sono competitor diretti della tv generalista. Il paradosso è che oggi è possibile seguire Sanremo senza guardare veramente la televisione, ma solo scorrendo lo schermo del proprio smartphone (alzi la mano chi non lo fa, almeno per un po’), dove le canzoni e le esibizioni esistono a pezzi e brandelli, continuamente smontate, rimontate, commentate e prese in giro da tutti noi. È su questo terreno che si sta giocando il futuro della musica e della sua industria, e lo dimostra molto bene lo scontro sulle royalties che impegna TikTok e Universal proprio in queste settimane.
Il Festival è però resiliente, ed è destinato a sopravvivere – anzi, a prosperare – nel nuovo bizzarro ecosistema musicale in cui ci ritroviamo a vivere. Più che uno specchio deformante, ci ricorda oggi una mirrorball, le luccicanti palle da discoteca che moltiplicano la luce in infinite direzioni. Sanremo lo fa con i discorsi sulla musica, i suoni, le opinioni, le posizioni e i gusti degli italiani e delle italiane da più di 70. I “capannelli in galleria” non ci sono più, Pella e Fanfani sono morti, le canzoni si ascoltano dallo smartphone ma davvero tutto è cambiato perché nulla cambiasse veramente.