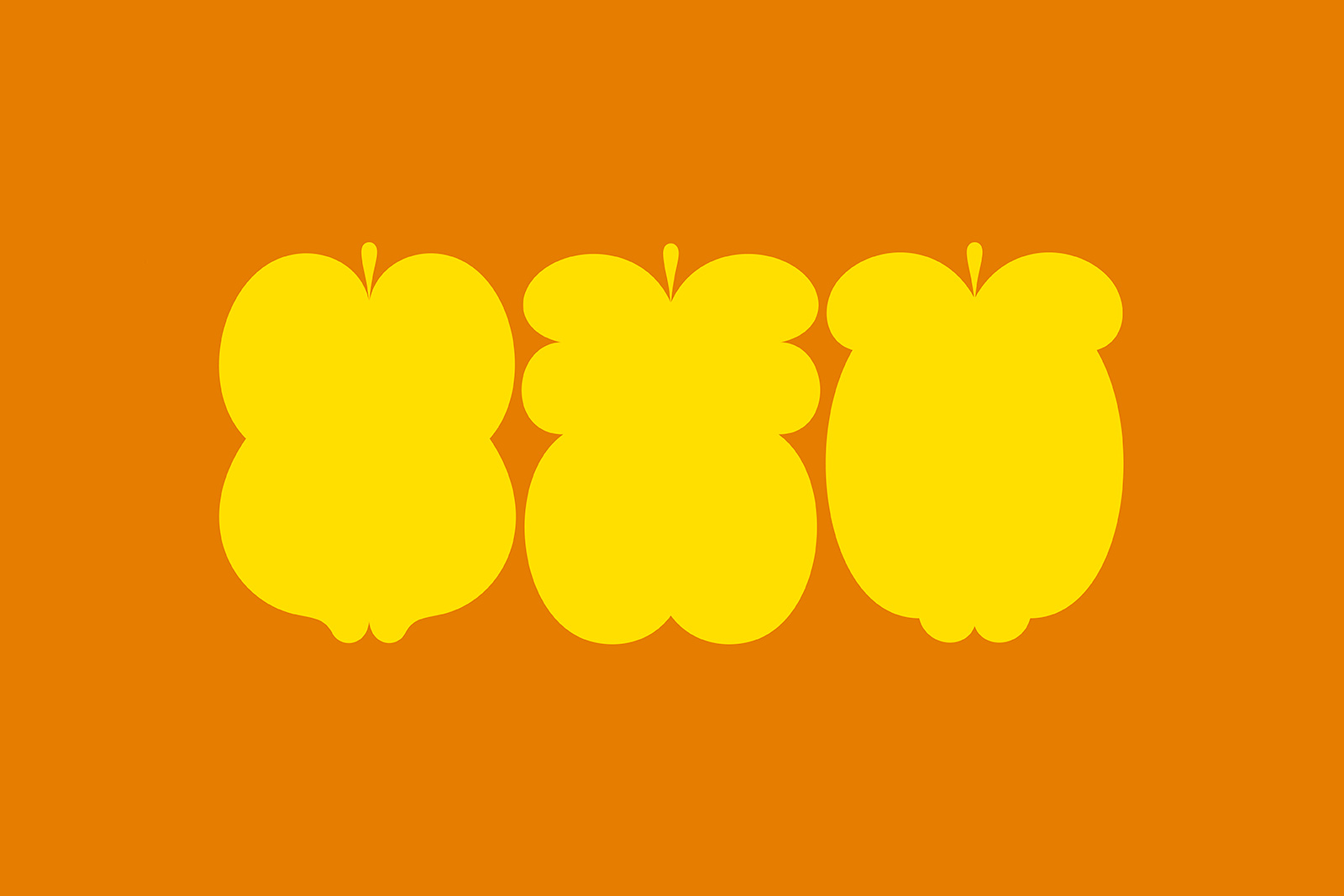La questione della vecchiaia e della morte invadono interamente la scena del primo racconto che Abraham Yehoshua pubblicò non appena varcata la soglia dei vent’anni: mai si potrebbe immaginare un destino per lui più lontano di quello che assegnò al vegliardo protagonista, del quale l’autorevole padrona di casa aveva decretato la morte, conquistando a sé tutto il vicinato, benché egli fosse perfettamente in salute. E questo solo perché era finito il tempo in cui la comunità era disposta a tollerare il pur mite vecchietto; che così viene fatto avviare a piedi verso la sua tomba, perché vengano sepolti insieme al suo corpo sano e alla sua mente vigile, l’eccedenza alla norma e il conseguente turbamento che egli rappresenta. Con questa inaugurale sfida alla ragione, Yehoshua prendeva simbolicamente congedo dalla generazione dei padri della letteratura israeliana, e anzitutto da Shmuel Yosef Agnon, la cui grande lezione si riverberava allora su tutti gli scrittori israeliani.
Ultimamente debilitato dalla malattia, e negli ultimi anni dalla perdita della moglie inseparabile, Yehoshua si sarebbe forse augurato anche lui una vita non più lunghissima, sebbene la tenesse doppiamente avvinta al filo degli affetti, che coltivava con commosso calore, e alla letteratura, nonostante la sua penna stesse progressivamente mollando la presa, e il sontuoso simbolismo dei primi decenni cedesse, nelle ultime novelle, a un realismo non immune da venature moraliste.
La stagione del racconto si chiuse per Yehoshua a metà degli anni Settanta (dodici invenzioni magistrali, comprese tra il 1957 e il 1974 sono raccolte in Tutti i racconti, Einaudi 1999) e fu una sorta di lento apprendistato alla forma romanzo, inaugurata già magnificamente nel ’77 con L’amante e mai più abbandonata.
ERA INTERESSANTE ascoltare Yehoshua tornare sui suoi libri a distanza di tempo, perché il suo giudizio portava a galla pregi e difetti in misura altrettanto realistica, e ne metteva a fuoco peculiarità preziose per una lettura ravvicinata. A distanza di decenni, L’amante finì dunque per sembrargli un romanzo troppo allegorico, troppo politico. Aveva cominciato a scriverlo all’indomani della guerra del Kippur, quando la società israeliana, fino a allora abbastanza compatta, sembrava esibire un processo di frammentazione che gli dettò l’idea di moltiplicare i punti di vista anche all’interno del romanzo. Finita la guerra, i giornali si erano riempiti di annunci di genitori che chiedevano notizie dei loro figli, mai più rivisti dopo i primissimi giorni di combattimento. In questo contesto a Yehoshua venne l’idea che qualcuno avrebbe potuto approfittarne per abbandonare la propria famiglia e spacciarsi per disperso, magari travestendosi da religioso. Cominciò a scrivere L’amante partendo dal monologo finale, poi passò all’incipit del romanzo e da lì proseguì in modo lineare.
PORTATO A TERMINE il suo esordio, un nuovo problema si presentò al giovane scrittore: come differenziare le voci interne ai personaggi. A quel tempo, Faulkner e in particolare la rivoluzione linguistica contenuta nell’Urlo e Il furore, esercitavano su Yehoshua una influenza ineludibile: fu sulla traccia di quell’esempio che presero vita i monologhi del Divorzio tardivo e, finalmente, l’idea che sta alla base di tutta la costruzione del Signor Mani, affidata ai famosi dialoghi in cui compare una sola delle due voci, mentre l’altra è omessa dalla narrazione. È questa l’idea letteraria che iscriverà stabilmente Yehoshua al canone degli autori da non dimenticare.
Al tempo dell’uscita del romanzo, Yehoshua dichiarò di avere guardato all’Intifada come a una sorta di rinascita del popolo palestinese, che segnava l’autofondazione tardiva di una loro identità nazionale. Gli chiesi quale rapporto ci fosse tra il quinto dialogo del Signor Mani – composto, almeno in parte, come una sorta di risposta ai giorni più duri dell’Intifada – e il resto del libro: «Penso – disse – che Il signor Mani sia il mio miglior lavoro e che non riuscirò mai più a uguagliarlo. L’idea fissa di Josef Mani è che i palestinesi siano degli ebrei rimasti in quella terra, successivamente convertitisi all’Islam. Quindi la sua ossessione è portarli a ricordare, con ogni mezzo, la loro condizione originaria di ebrei. A tutto questo si intreccia qualcosa di più personale: mio figlio era nell’esercito durante l’Intifada e mi raccontava delle perquisizioni sistematiche alla popolazione, di donne e bambini sbattuti contro il muro. Mi raccontava come scavassero sistematicamente nella loro intimità, casa per casa, e tutto era odio, tremendo rancore… Nei confronti di quelli che, forse, erano i discendenti dei nostri fratelli. Così, fatte le debite differenze, il signor Mani che va alla ricerca dei segni della cultura ebraica, casa per casa, porta un po’ il riflesso di quanto mi raccontava mio figlio durante l’Intifada».
Avrebbe voluto far parlare, nell’ultimo monologo, anche un cane, cui era affidato il compito di riassumere i nove giorni in cui si svolge la storia di tutta la famiglia protagonista. Mutuata da uno tra i passi più celebri di tutta la letteratura israeliana, un racconto di Agnon, questa idea venne giudicata tuttavia così surreale da minacciare la credibilità dell’intero romanzo e l’editore si rifiutò di darle seguito. Più o meno a metà del romanzo, mentre cercava di valicare i confini individuali dei personaggi per risalire a un inconscio collettivo, Yehoshua si spaventò per l’ambizione del suo progetto (che avrebbe comunque ripreso e portato a compimento) e cominciò un nuovo libro, Cinque stagioni. Per la prima volta tra queste pagine lo scrittore israeliano adotta la forma-romanzo classica, e tuttavia gioca con le voci narranti, impiega tutte le forme del dialogo possibili, apre finestre narrative in cui cambia completamente registro stilistico.
ALMENO UN EPISODIO del romanzo esemplifica bene il sentire politico di Yehoshua: il nipote di Rashed, uno dei personaggi, è vittima dell’amministrazione dei Territori, che gli impedisce il ritorno in Galilea. Adottando un registro fiabesco, in cui sembra che la voce narrante segua il bambino come un’ombra consapevole della tragedia che sta per abbattersi su di lui, Yehoshua descrive una parentesi commovente in cui per un verso rende evidente la malvagità intrinseca al divieto dell’amministrazione: «Come mai gli arabi devono dimostrare di essere malati perché gli sia permesso di tornare qui?», d’altra parte mette in bocca a un altro personaggio israeliano parole di riprovazione nei confronti di una nostalgia infantile per il proprio luogo di origine: «Per voi tutti devono vivere esattamente nel villaggio dove è nata la loro madre? Cos’è? Siete un popolo di bambini che continua a sentire nostalgia di casa anche da adulti e da anziani?»
INTANTO, mentre cercava un bandolo per la matassa delle sue trame, due eventi irruppero nella la vita di Yehoshua: la morte del padre, un orientalista autore tra l’altro di dodici libri su Gerusalemme, e l’attacco israeliano al Libano. Sharon e Begin erano arrivati fino a Beirut e pretendevano di fare la pace con i cattolici contro i musulmani: «una autentica follia», così la commentò Yehoshua. «Per la prima volta – ricordava allora – mi sentii come se avessi perso il contatto con i codici del mio popolo; mi era già capitato, soprattutto nel ‘67, di oppormi alla politica israeliana, ma almeno ne capivo la logica. Ora, invece, mi sentivo come se improvvisamente qualcuno della mia famiglia fosse impazzito; dunque, per tentare di raccapezzarmi mi sembrò necessario andare indietro nella storia, un po’ come quando si risale psicoanaliticamente alle radici dei propri problemi. Cominciai così a scrivere sul passato; mai prima di allora, nemmeno nei miei racconti più astratti, avrei pensato di potere abbandonare il presente».
L’AFFONDO nel tempo remoto di Yehoshua assunse nel ‘98 la forma di una fiaba per adulti, anomala e sontuosa, titolata Viaggio alla fine del millennio (Einaudi), dove la trama si svolge e si riavvolge in repentini cambiamenti di destini, al prezzo di desideri di vendetta e furibondi dolori. Ma è chiaro che una stessa aspirazione sostiene questa storia antica e la quotidianità tutta moderna di Yehoshua, cittadino israeliano di terre contese: che genti di diversa estrazione religiosa e culturale si incontrino sulla base di un dialogo capace di edificare un ponte tra rivendicazioni apparentemente inconciliabili.
Gli occhi del lettore incontrano la prima pagina quando la nave che trasporta i viaggiatori è già salpata. Sull’antico vascello hanno preso posto il mercante ebreo Ben-Atar con le sue due mogli, il socio ismaelita Abu-Lufti, il comandante, i marinai maghrebini e un rabbino di Siviglia, alla cui saggezza è affidato l’esito della missione. Avrebbero potuto compierlo via terra, quel viaggio che da Tangeri ora li porta a Parigi sfidando le insidie dell’Atlantico; ma manca solo un anno alla fine del primo millennio e il fanatismo dei cristiani offre minacce ben più concrete di quelle riservate dai capricci del mare. Non tutti i viaggiatori sono mossi da una identica passione, ma un unico scopo sottomette la loro volontà: ricongiungersi al nipote di Ben-Atar e rinsaldare la alleanza commerciale che egli ha rotto, abbandonando l’amico ismaelita e l’adorato zio, per assecondare il volere della sua nuova moglie.
Nei lunghi giorni della navigazione, la fede musulmana e quella ebraica intrecciano i loro riti nella pacifica, amorevole convivenza dei diversi temperamenti che le sostengono. «Ciò che mi affascinava – disse Yehoshua nel corso di una intervista in cui commentammo il libro – era indagare lo scontro tra i codici di due filoni diversi dell’ebraismo. Non essendo sottomessa a alcuna autorità centrale, la religione ebraica, praticata da popoli diversi e lontani tra loro, si trovava a dovere fronteggiare il problema di mantenere una sua unità. È molto interessante capire come mai una regola abbia vinto sull’altra e, inoltre, quale eredità si sia lasciato alle spalle un codice decaduto».
NON A CASO, nei libri di Yehoshua compare quasi sempre la figura di un uomo di legge, e nemmeno troppo fra le righe ci si trova spesso di fronte alla urgenza di chiedersi chi abbia ragione: prima di dedicarsi interamente alla scrittura, infatti, Yehoshua avrebbe voluto diventare avvocato, e da quella originaria vocazione non ha mai preso del tutto le distanze. Quando parlava delle sue giornate di lavoro, le descriveva come regolate dalla «metodicità dell’impiegato». Diceva di avere bisogno di disciplina, di scansioni della giornata sempre uguali, una attitudine che si riflette sulla dedizione puntuale alla struttura dell’intreccio, che solitamente cominciava dalla fine, consapevole che ogni azione narrata deve risultare necessaria, mentre ai personaggi nessuna altra possibilità deve essere data se non quella alla quale vanno incontro.
Come altri scrittori, primo tra tutti Nabokov, Yehoshua ha sempre rivendicato un ferreo controllo su tutto ciò che si svolge nell’intreccio: nulla deve essere lasciato al caso, le domande su quale sia il punto di vista, dove stia il narratore, cosa sappia e cosa ignori dei suoi personaggi, da quale altezza li giudichi, quale sia la distanza che mette tra sé e loro è decisiva: perciò l’identificazione indotta non deve risultare eccessiva, e l’ironia va calibrata. Più volte Yehoshua ha insistito sulla necessità di tenere lontani gli elementi autobiografici, «perché un coinvolgimento troppo forte è una minaccia all’obiettività dello sguardo» – diceva.
E tuttavia, elementi relativi alle dinamiche coniugali, che da sempre gli stavano a cuore, invadono pressoché tutti i suoi romanzi: La sposa liberata, per esempio, (Einaudi 2002) costruito su due binari paralleli, una vicenda privata e una storica. Tra quelle pagine, Rivlin, il protagonista, è ossessionato dal dolore che il figlio Ofer patisce per il divorzio che la ex moglie Galia gli ha imposto, e la ricerca della verità nascosta dietro quella rottura diventa il motore privato delle sue azioni. Contemporaneamente, sul versante delle sue ricerche storiche, egli indaga le motivazioni profonde del terrorismo algerino. Tutta la trama è proiettata sullo sfondo della difficile convivenza tra arabi e israeliani e si direbbe che più ancora della risoluzione dell’intreccio, sia questo il tema che l’autore ha più a cuore.
L’INVESTIGAZIONE romanzesca di Yehoshua su quanto avviene all’interno delle relazioni matrimoniali trova un suo ennesimo capitolo in Fuoco amico, un romanzo del 2008, (Einaudi), dove l’espressione del titolo rimanda sia alla fiamma rassicurante delle candele accese nei giorni della festa ebraica, sia all’incidente fatale in cui il nipote della protagonista ha perso la vita, qualche anno prima del tempo in cui si svolge il romanzo. Si chiamava Eyal ed era nell’esercito quando una notte gli avevano ordinato di appostarsi sul tetto di una casa palestinese a Tul Karem. Insieme agli altri soldati aspettava che un ricercato arabo tornasse a visitare i suoi per catturarlo, e dato che l’attesa sarebbe stata lunga, si era fatto consegnare dagli abitanti della casa un secchio in cui fare i suoi bisogni, e il secchio intendeva riconsegnarlo pulito. Ma quando era sceso per compiere quel gesto di elementare buona educazione, i soldati israeliani avevano confuso la sua sagoma e gli avevano sparato uccidendolo.
IN UNO DEI NOSTRI incontri, chiesi a Yehoshua, che nel frattempo si era spostato su posizioni decisamente più conservatrici, come spiegasse la distanza tra l’empatia così profonda con i palestinesi che attraversa le pagine dei suoi romanzi e le dichiarazioni rilasciate al giornale Haaretz, per esempio sulla necessaria edificazione di un Muro: «La questione che ho più volte discusso riguardava la edificazione di uno stato binazionale. Oggi – a mio parere – il problema è che, alcune correnti palestinesi da una parte e l’estrema sinistra israeliana dall’altra, vorrebbero riunire in un unico stato tutti i palestinesi, gli israeliani e i profughi. Io credo che questo si risolverebbe in un incubo e, d’altronde, anche Yaser Abed Rabu, il segretario generale del comitato per la liberazione della Palestina, ha rilasciato una intervista molto franca e molto audace in cui esorta a fare in fretta perché altrimenti i palestinesi, dopo avere aspettato tanto, rinunceranno alla sovranità nazionale. Ma questa idea è anche il risultato degli errori di Israele: siamo noi che abbiamo violato le frontiere, siamo noi che abbiamo installato colonie nei territori, ed è la destra israeliana che, per prima, ha ventilato l’ipotesi di un unico stato. Da sempre mi batto perché Israele si ritiri unilateralmente dagli insediamenti illegali nei territori… Quanto al Muro, intendo la necessità di una frontiera, e ho detto mille volte che essa sarebbe dovuta passare sulla linea del 1967, riconosciuta internazionalmente».
VIA VIA PIÙ ESILI, le trame di Yehoshua sembrano rivelare negli anni la loro motivazione a funzionare da impalcatura per l’espressione di idee relative alla giustizia su questa terra piuttosto che a onorare un debito verso i regni della finzione.
Fra i romanzi dell’ultima stagione, La scena perduta fin dal titolo denuncia l’attitudine nostalgica dei protagonisti, tutti proiettati verso il passato, e concentrati nel recupero di qualcosa che si vorrebbe riportare all’attualità. Vi si racconta la retrospettiva che un monaco cinefilo organizza a Santiago de Compostela per far conoscere al pubblico i primi film di Yair Moses, ora doppiati in spagnolo. Il regista assiste alle proiezioni con la sua attrice preferita, Ruth, non proprio la sua compagna ma nemmeno una presenza neutra, che ha portata con sé per non perderla di vista e perché lei impari a sentirlo necessario così da non potere fare a meno di lui anche quando verrà esiliata dai suoi film.
L’ultimo capitolo della carriera di Yehoshua, già visibilmente indebolito, La figlia unica (Einaudi 2021) è ambientato nella molto amata Italia: tornano figure di avvocati nella linea paterna della famiglia della piccola Rachele Luzzatto, la protagonista. Di ampie vedute il nonno, di più ristretti orizzonti il padre, che nega alla ragazzina dodicenne di accettare il ruolo della Madonna nella recita di Natale della sua scuola.
Da sempre militante per lo schieramento morale dei suoi personaggi, Yehoshua nei suoi romanzi tardivi si è preoccupato via via meno di occultare il proprio giudizio: qui, condanna la pochezza di vedute del padre, ma lo restituisce al ruolo della vittima, assegnandogli una malattia potenzialmente mortale, e introducendo così un altro tema a lui caro, quello della vulnerabilità fisica, al tempo stesso riverbero della propria salute già al tempo compromessa, e ricorrenza della produzione romanzesca più tarda.