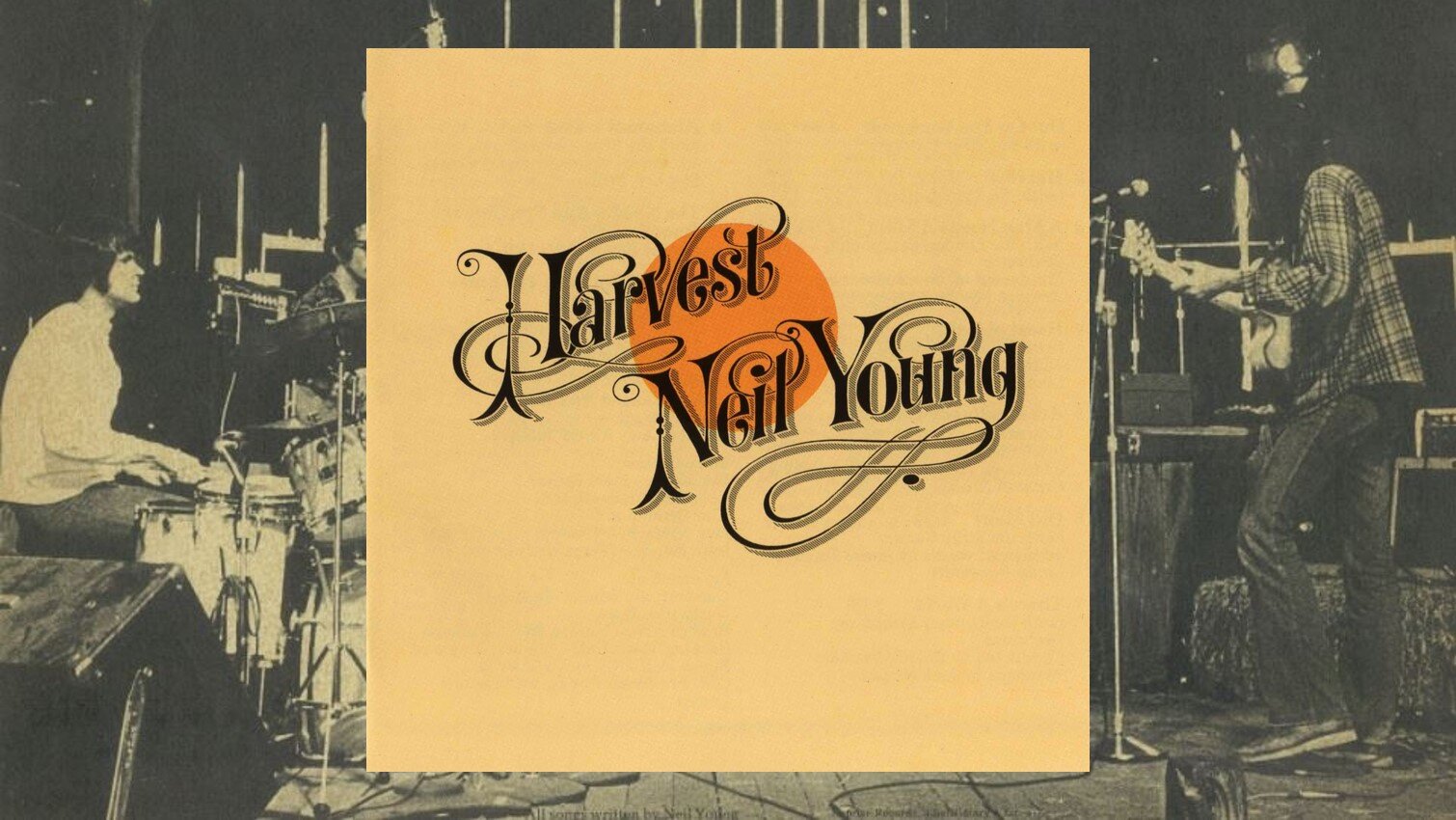classici
Nel suo memoir, appena ripubblicato, Nadezda Mandel’stam mostra di non essere solo la moglie del grande poeta Osip, ma un’autentica scrittrice di razza. Che ci riporta nella cupa Russia dell’era Stalin
diWlodek Goldkorn
Quando i carnefici vengono a toglierti la vita, scrive Nadežda Mandel’štam, ci sono due possibili atteggiamenti. Il primo, quello del bue, che « condotto al macello spera ancora di riuscire a scappare e a schiacciare sotto gli zoccoli i suoi beccai » . Il secondo, quello dell’uomo «condotto al supplizio » che non oppone resistenza e anzi considera un atto di coraggio « non farsi coprire gli occhi e morire senza benda » . Lei preferisce il bue, « la sua cieca furia » . Grazie a questa « cieca furia » , alla voglia dell’autrice di non arrendersi, possiamo leggere il suo memoir Speranza contro speranza, in uscita con Edizioni Settecolori nella traduzione di Giorgio Kraiski, con l’introduzione di Seamus Heaney, Nobel per la Letteratura, e la postfazione di Clarence Brown. Il volume è una specie di riedizione di un testo pubblicato in Italia una cinquantina di anni fa, seguirà a primavera un secondo volume, Speranza abbandonata, in gran parte inedito, ma non è questo il luogo per raccontare le avventure editoriali dell’autrice in Italia.
Quando si parla di Nadežda Mandel’štam, si aggiunge quasi senza pensarci, « la moglie di Osip » . Osip Mandel’štam, a sua volta, era uno dei più grandi poeti del Novecento ed è morto, all’età di 47 anni, in un gulag, Vtoroja Re?ka, alla periferia di Vladivostok. Nadežda, che in russo significa “ speranza”, ha sempre voluto presentarsi quasi come la custode della memoria del marito e soprattutto come colei che imparò a memoria le sue poesie e così ha potuto trasmettere ai postumi quei sublimi versi.
E invece. Ecco, la letteratura è tempo, la ricezione dello stesso testo cambia a seconda delle circostanze in cui viene letto. E leggendo oggi le oltre seicento pagine del testo si arriva alla conclusione che Speranza contro speranza è un capolavoro assoluto, un libro che risplende della propria luce, della trasparenza della prosa. L’autrice non si sostituisce all’oggetto (il sommo poeta assassinato dal tiranno) della narrazione ma crea invece un metaromanzo — dove tutto è successo davvero — in cui parla della condizione umana, del rapporto fra arte e potere, della rettitudine di alcuni e mancanza di coraggio di altri e dell’ « amor che move il sole e l’altre stelle » . La citazione non è casuale, Osip Mandel’štam sapeva recitare i versi di Dante a memoria.
Per la cronaca: Nadežda Chazina ( il suo cognome da nubile) conobbe il suo futuro marito a Kiev,nel 1919. Lei aveva vent’anni, lui ventotto. Ambedue venivano da famiglie ebree borghesi, in casa si parlava il russo. Lui era ormai un poeta famoso, uno degli esponenti dell’acmeismo, una corrente che nacque una decina di anni prima e che — contro i simbolisti allora egemoni nella poesia russa — insisteva su un linguaggio chiaro e trasparente, appunto, o con una metafora, prediligeva la luce d’Italia alle nebbie del Nord. Fu amore a prima vista, consumato la sera stessa.
Una notte di maggio del 1934, nella piccola abitazione dei Mandel’štam a Mosca, ospite Anna Achmatova, appena arrivata da Leningrado — e dove non c’era niente da mangiare, tanto che Osip si fece prestare un uovo dai vicini, destinato alla ospite — si presentarono funzionari della polizia politica. La scena della perquisizione varrebbe di per sé uno spettacolo teatrale ( l’uovo comunque finisce per essere mangiato da Osip).
Il poeta viene arrestato. Stiamo parlando dell’Unione sovietica di Stalin. Si può finire al confino, in un gulag, o in prigione senza un motivo manifesto. È il destino di una generazione quello che racconta l’autrice, delle vite devastate da un potere arbitrario e dove fidarsi di un amico ( che invece faceva il delatore, per paura) poteva portare alle torture, alla morte distenti e per esaurimento a causa di lavoro in condizioni di fame e schiavitù. Mandel’štam però è consapevole di vere colpe: un epigramma, recitato in una cerchia ristretta contro il dittatore e la non adesione ai canoni estetici ed etici del comunismo.
La pena è relativamente mite: il poeta finisce al confino. Lei lo accompagna senza esserne obbligata. Scopre che il marito soffre di una malattia mentale, è testimone di tentativi di suicidio. Dopo tre anni, arriva la semilibertà: Mandel’štam non è più confinato, ma non può risiedere né a Mosca né in una delle grandi città. Nel maggio ( accade tutto a maggio) del 1938 lo arrestano di nuovo. Questa volta finisce davvero nel gulag. Nel dicembre muore.
Strazianti le pagine sulla ricerca della data e delle circostanze del decesso del marito: il regime negava ai famigliari perfino il diritto al lutto, il più sacro dei diritti. Lei, dal momento del suo secondo arresto, vive da nomade, finché nel 1964 le viene permesso di tornare a Mosca. E scrive questo libro, dove parla delle persone, con acume e sensibilità, in genere senza rancore ( ma neanche perdona), senza dimenticare coloro che in un’epoca di lupi si dimostrarono generosi.