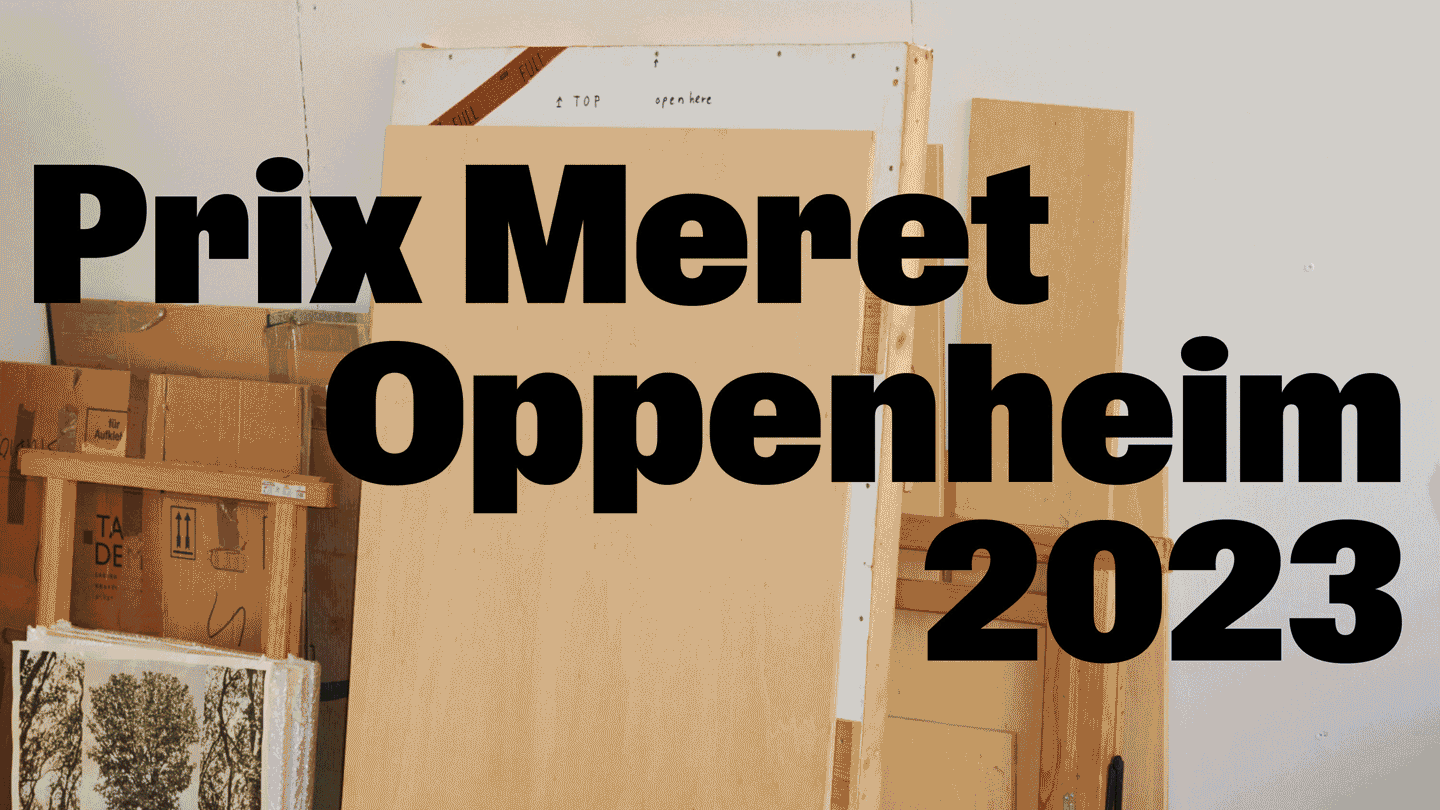
Prix Meret Oppenheim 2023
5 Febbraio 2023
Gli ultimi giorni di Mario Paciolla
5 Febbraio 2023«I nostri carnefici non meritano il perdono, eppure io non sono mai riuscito a odiarli. I miei sentimenti nei confronti di quelli che durante la guerra bruciarono le nostre case e uccisero la nostra gente non sono cambiati. Non li odio. Ma per loro non dev’esserci alcuna pietà altrimenti potrebbero farlo di nuovo». Trent’anni fa il giornalista e poeta bosniaco Rezak Hukanovic fu costretto a vivere l’inferno sulla terra. Nel giugno 1992 venne rinchiuso insieme al suo figlio di 16 anni in uno dei quattro campi di concentramento allestiti dai nazionalisti serbi nei dintorni di Prijedor, la città- simbolo della pulizia etnica nei Balcani. Vi furono deportate migliaia di persone, molte delle quali non avrebbero più fatto ritorno. Hukanovic fu imprigionato per sei mesi nell’ex complesso minerario di Omarska, trasformato in un lager per musulmani e croati. Lì ha visto la crudeltà e l’umiliazione diventare una perversa forma di divertimento e ha sperimentato sulla propria pelle l’inspiegabile sadismo di ex amici, conoscenti e vicini di casa trasfigurati in carnefici. Ancora oggi si chiede come sia riuscito a sopravvivere. Tornato in libertà si è sobbarcato il peso solitario della memoria, raccontando la macabra ordinarietà della vita dei prigionieri nel coraggioso memoir Il decimo girone dell’Inferno. Una testimonianza diretta dai campi di concentramento in Bosnia (traduzione di Sara Ferraro; Spartaco, pagine 156, euro 16,00), apparso per la prima volta in inglese nel 1996 con una prefazione del Premio Nobel Elie Wiesel. Un libro che ci obbliga a non distogliere lo sguardo da quell’orrore e fa riecheggiare forte il famoso monito di Primo Levi, «è avvenuto, quindi può accadere di nuovo». La vita di Rezak Hukanovic e di migliaia di altri musulmani e croati di Bosnia cambiò all’improvviso nella primavera del 1992, quando le milizie serbo-bosniache invasero la città di Prijedor e obbligarono la popolazione non serba a issare uno straccio bianco sulle proprie case e a portare sempre al braccio una fascia bianca per poter essere riconosciuti. Fu l’avvio della più brutale pulizia etnica compiuta in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale. Di lì a poco migliaia di uomini, donne, anziani, bambini musulmani e cattolici furono prelevati dalle loro abitazioni e deportati nei campi di concentramento della zona. Il giornalista venne rinchiuso insieme a suo figlio nel campo di Omarska, in cui i prigionieri furono costretti a subire violenze di ogni genere e oltre tremila persone sarebbero state uccise a bastonate, a colpi di arma da fuoco, oppure a mani nude. Dopo essersi salvato quasi per miracolo, Hukanovic ha trovato la forza per raccontare quelle indicibili crudeltà, il gusto di torturare, umiliare e uccidere i propri simili. Ma ha preferito usare uno pseudonimo e un io narrante in terza persona, quasi a volersi illudere di non aver mai vissuto quegli orrori.
In uno dei passaggi più potenti del suo libro c’è una frase, «Signore, fa’ che tu non possa mai perdonarli ». La riscriverebbe ancora adesso, a trent’anni di distanza, oppure i suoi sentimenti nei confronti di quanto le è accaduto sono cambiati?
Oggi non provo sentimenti diversi nei confronti di coloro che bruciarono le nostre case e uccisero la nostra gente. Penso che non debba esserci alcuna pietà per gli assassini e per i torturatori perché se ne avessero la possibilità lo farebbero di nuovo. Io appartengo a quella categoria di persone che non è capace di odiare, semplicemente perché non conosco quello stato d’animo. Non odio quelli che all’epoca mi hanno fatto del male. Avevo e ho ancora amici tra i serbi, perché non si può condannare un intero popolo per colpa di una manciata di criminali. In questo modo faremmo del male anche noi. Il mio motto è sempre stato: fai del bene in modo che quel bene ritorni indietro.
Da quando è tornato a vivere nel suo Paese le è capitato di incontrare qualcuno dei suoi carnefici?
Sì, ne ho incontrati molti, se non tutti. Sono stato testimone tre volte al tribunale internazionale dell’Aja, dove ho raccontato ciò che ho vissuto in prima persona dopo essere stato fatto prigioniero. Non tutti i carnefici si sono pentiti del male che hanno fatto. Alcuni sono tornati a Prijedor dopo aver scontato anni di carcere, altri l’hanno fatta franca. Pochi giorni fa è stato finalmente arrestato Dragomir Saponja, uno che mi aveva picchiato nel campo di Omarska e che finora, a quasi trent’anni dalla fine della guerra, era riuscito a nascondersi. A volte la giustizia è lenta ma alla fine fa il suo corso. Io credo nelle istituzioni statali e internazionali e penso che abbiano lavorato bene.
Il suo libro pone domande terribili sulla natura umana e sulla sua degenerazione. Dopo tutto questo tempo è riuscito a spiegarsi come sia stata possibile la trasformazione di persone comuni, peraltro ex amici e conoscenti, in servitori impazziti di una nuova autorità e capaci di compiere atti mostruosi?
No, credo che non sarò mai in grado di comprendere la psiche degli assassini e dei torturatori. Non riesco a capire cosa possa spingere qualcuno a uccidere una persona solo perché non prega il suo stesso Dio o non appartiene al suo stesso gruppo etnico o religioso. In una mia poesia ho scritto che nei Balcani «si nasce con il fucile in mano e la polvere da sparo nelle narici». Ma è difficile spiegarlo a chi non abita da queste parti. I Balcani sono una polveriera che erutta periodicamente, in determinate fasi storiche, perché è la porta dell’est e dell’ovest e sono sempre stati una moneta di scambio tra le grandi potenze. E noi siamo soltanto il danno collaterale di un grande gioco.
Ritiene che le condanne comminate da allora (a cominciare dai grandi leader latitanti, Karadzic e Mladic) siano bastate per fare giustizia?
Purtroppo la maggior parte di quelli che hanno fatto del male non sono stati neanche incriminati. Karadzi , Mladi e altri hanno ottenuto pene esemplari ma l’effetto delle condanne di quei criminali di guerra su una parte della popolazione è sorprendente. Molti li considerano eroi, e a loro hanno intitolato scuole, strade e piazze. I bambini nati dopo la guerra sono cresciuti nello spirito di glorificazione dei criminali di guerra. In questo modo è assai difficile che possa esserci una catarsi.
Lei è anche un poeta. È riuscito a ricominciare a scrivere poesie dopo quanto le è successo?
Prima della guerra avevo pubblicato una decina di libri, tra cui sei raccolte di poesia. Per lungo tempo ho chiuso le porte dell’inferno che ho vissuto nel tentativo di scappare dal passato. Per guardare al futuro è servita una grande forza ma ritengo sia stato necessario trovarla soprattutto per il bene delle nuove generazioni. Mi ci è voluto molto per ricominciare a scrivere poesie, e proprio adesso sono in attesa dell’uscita del mio nuovo libro di poesie. Ho voluto intitolarlo Canti di bellezza e dolore, perché contiene le cicatrici della guerra ma parla anche dell’amore ricambiato che rappresenta l’unico senso della nostra esistenza.
(ha collaborato Azra Nuhefendi)





