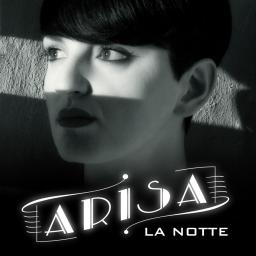
Arisa – La notte
30 Settembre 2023
La CGIL-Sunia di Firenze
30 Settembre 2023«La cultura a Firenze, un deserto costellato di aiuole di plastica»
In città da anni un monopolio che ha indotto alla fuga i veri talenti
Caro direttore,
nella polemica su Eike Schmidt si è persa ancora una volta l’occasione, a Firenze, per parlare di cultura senza sommarietà né pregiudizio. Invece di considerare le contestazioni nel merito, si è preferito associare ad esse, sbagliando, un immediato colore politico.
Desidero però parlare qui di cultura e non di «politica», non quantomeno dall’angusto punto di vista della controversia elettorale. Vale allora partire da una semplice constatazione: quanto alla questione «cultura», Firenze soffre da anni di una situazione di inverosimile monopolio, particolarmente nell’ambito delle arti figurative, che non ha equivalenti in Italia (non dico in Europa); e che non si spiega con ragioni di fama o merito.
Non c’è dubbio: tali monopoli, di tipo personalistico e neppure solo ideologico, intollerabili altrove, hanno gradualmente distrutto il tessuto artistico e culturale cittadino, sottomettendo gli attori principali (artisti, curatori etc.) a poche e inaggirabili sorgenti di finanziamento pubblico; contribuendo a rimuovere il dissenso (è forse questo che si cercava?); e contribuendo infine a spingere lontano dalla città le persone più capaci e autenticamente dotate di talento (che hanno avuto successo altrove, in arte, nella ricerca scientifica, nella letteratura o altro). I «creativi» sono stati indotti alla fuga (o a una sorta di penoso «esilio interno») non solo da un regime di odioso accentramento, ma anche, in taluni ambiti o circostanze specifiche, da protervia e grettezza davvero fuori misura.
Il mondo dell’arte contemporanea non è oggi la bohème di tradizione ottocentesca. Competitivo, premia mobilità, capacità di relazione, conoscenze linguistiche, strategia e visione, professionismo. La figura del «curatore-guardiano», cui l’amministrazione affida nel tempo una sorta di rocciosa luogotenenza, non è contemplata in nessun modo: si trasforma inevitabilmente, per le istituzioni culturali cui lo si pone a capo, in discredito ed esclusione. Se considerata da punti di vista artistici e culturali, Firenze è stata una città vivace e partecipata sino ai primi anni del nuovo millennio. Sembrava al tempo imminente la creazione di un Centro per le arti contemporanee. Il Csa di Gavinana si era imposto come laboratorio culturale tra i più apprezzati in Italia, nello specifico delle arti performative: qui ad esempio erano nati i Kinkaleri. Era ancora viva, al Maggio Danza, l’eredità glam-punk di Karole Armitage. Di lì a poco si sarebbero aggiunte le attività di Villa Bardini e del Museo Marino Marini. Oggi Firenze, se considerata dal punto di vista della creazione artistica e culturale contemporanea, è un deserto costellato di aiuole di plastica. Se è questo che si desiderava, lo si è ottenuto.
Tra i 67 soi-disants studiosi, artisti, curatori che hanno firmato a favore delle scelte politico-culturali della giunta di Dario Nardella, non è dato ritrovare un solo nome che abbia standing nazionale o sovranazionale (due eccezioni: Carlo Falciani e Ilaria della Monica, bravi storici dell’arte che però non si occupano professionalmente di cultura contemporanea e che qui, voglio credere, sono stati sviati da timori politici), garantisca indipendenza di giudizio e non possa essere in un modo o nell’altro, per via di reti economico-professionali e amicali, riconoscibile come stakeholder della giunta stessa o congiunto degli stakeholder.
La città è peraltro quel che è: un’inespugnabile miniera a cielo aperto, il luogo più ostile per chi, bambini, adolescenti e anziani in particolare, non prenda parte alle attività di scavo e vi si trovi ad abitare cercando verde pubblico, gioco e silenzio. Un semplice esempio: la fioritura di resort extralusso non sembra destinata a recare ai cittadini qualche lembo di prato in più né servizi migliori su cui contare — solo un supplemento di recinzioni, securities e ristoranti stellati. E sì che basterebbe andare non in Germania o in Scandinavia, ma a Lucca, Rimini o Sarzana (non faccio questione, neppure qui, di colore politico) per vedere cosa ogni amministrazione virtuosa possa fare, purché lo voglia.
I pressoché 70, firmatari di un appello che ipocritamente nega di fare campagna a favore ciascuno del proprio particulare , compongono la scena di un corteo di compagni d’arme e vecchie glorie mai pervenute altrove, indefettibili e lagrimose. In calce al breve testo mancano tutti i nomi noti che pure si potrebbero fare in città e avrebbero reso, se presenti, l’appello davvero autorevole; i nomi di chi, pur risiedendo a Firenze, da Firenze ha scelto di (o è stato costretto a) allontanarsi; i nomi di ospiti residenti e visitatori illustri (non importa chi adesso, a elenco chiuso, potrà aggiungersi per i servizievoli uffici dell’erinni di turno); i nomi di galleristi, collezionisti, imprenditori attivi nel collezionismo e nella promozione dell’arte contemporanea. Per non parlare di quanti, e sarebbe gravoso citarli tutti, hanno esposto o curato a Firenze in anni recenti. Che il loro ricordo della città, e del fosco curatore-guardiano annidato nel suo centro, si sia guastato nel frattempo?
A fronte di ciò, la sola firma di Giulio Paolini, beneficiato di recente da una giornata di studi, sembra l’astuta concessione «diplomatica» di un artista preoccupato che niente turbi, tantomeno malumori operai, l’annosa costruzione del proprio mito.
https://corrierefiorentino.corriere.it/





