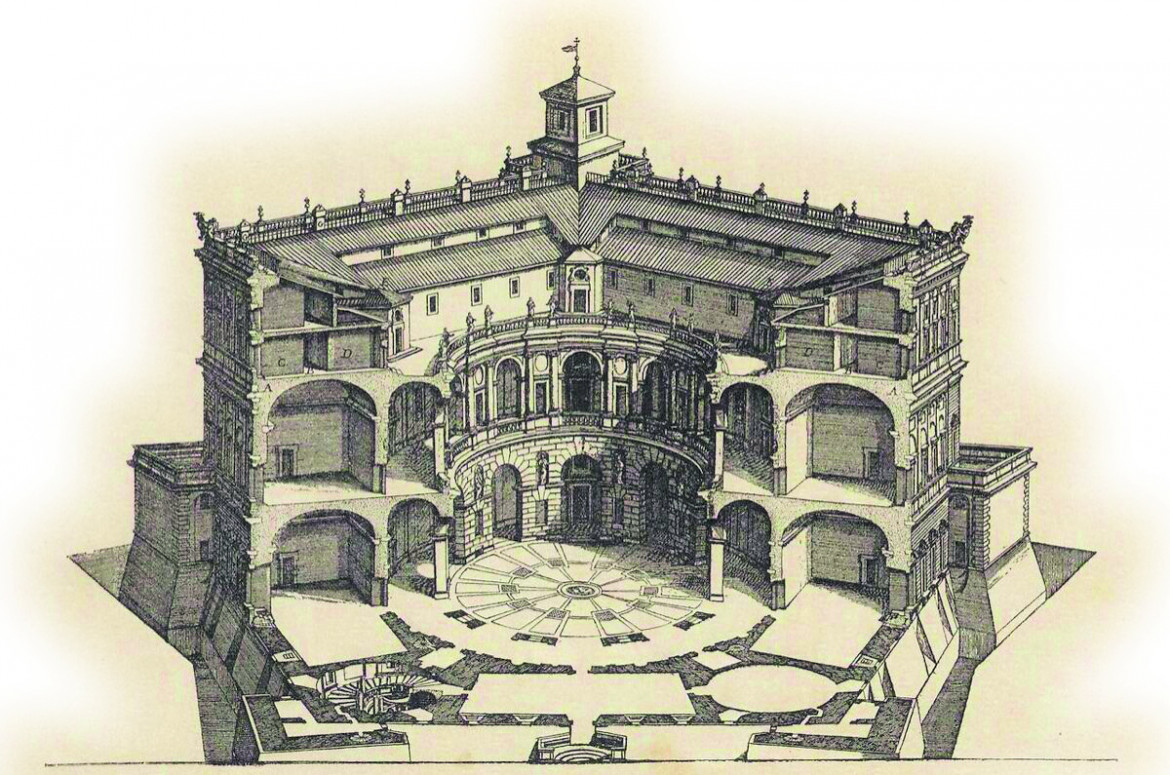
La dinastia della magnificenza
24 Giugno 2022
Creedence Clearwater Revival: Long As I Can See The Light
24 Giugno 2022Anticipazioni Esiste un destino che informa di sé un luogo e le persone che lo vivono: lo hanno interpretato dagli anni Sessanta a oggi due architetti dall’inconfondibile cifra. Ora li racconta un volume, con una premessa d’autore: questa
di Sandro Veronesi
È l’essenza della città. Che prende forma nei lavori di Gianmaria e Roberto Beretta
Partiamo da un assunto — anzi, da un postulato. Si postula che esista un canone milanese, e che esso regoli i principi fondamentali dell’essere e del fare, del pensare e dell’agire, del prendere forma e dello svilupparsi (in una parola, dell’esistere) nella città di Milano; e che non si tratti di una semplice maniera, o tradizione, o costumanza, o usanza o consuetudine, e che non si riferisca a nulla di precedentemente definito ma che al contrario preceda ogni sua specifica applicazione; si postula cioè che non solo esista un canone milanese ma anche che esso esista in sé, come pura e ineludibile matrice delle più disparate fenomenologie, e che sia in grado di ricondurle tutte, dal loro primo apparire fino alla loro più completa manifestazione, a un insieme chiuso di definizioni semplici. Un canone genuinamente epicureo, che sia modello della realtà senza essere la realtà, e che nella distinzione tra sé e la realtà sia — esso, il canone — generatore di realtà. Si postula dunque l’esistenza di questa dottrina dalla quale mai la realtà potrà discostarsi, e che essa non debba confondersi con altre entità che le somigliano come il cosiddetto genius loci o, in via metaforica, il «Dna della città», o anche il fin troppo bistrattato cliché, il luogo comune, ma che semplicemente contenga anche queste come contiene ogni cosa che riguarda Milano. Si postula che esista questo canone, e che esista a Milano, per Milano, a proposito di Milano, e che per questo sia detto appunto canone milanese.
Ne consegue, se questo canone esiste, che l’inconfondibilità di Milano che tutti constatiamo non è il risultato delle azioni e delle forme che nei secoli vi si sono sovrapposte, bensì che ne sia la causa; e che esso abbia generato e continui a generare ogni molecola della città, inerte o vivente, passata o presente, e che ogni fenomeno che la riguarda e ogni disciplina che vi viene praticata renda conto a quel canone come il fare del credente rende conto al buon Dio.
Allontanandoci dal linguaggio filosofico — e anche, immediatamente, dall’insidiosa metafora religiosa —, e orientandoci piuttosto verso una visione del mondo più letteraria, e dunque più generosa, possiamo proseguire parlando di destino. Se esiste un canone milanese, esso altro non è che un destino.
E poiché un destino è un destino, cioè è singolare, ecco che in esso si riversano le migliaia di destini che in esso trovano compimento, e che a Milano hanno una propria coerenza. Nascere e crescere a Milano apre dunque una miriade di prospettive, ma — attenzione — apre solo quelle. Vi è dunque, in questo canone, postulando che esso esista, il genio dell’esclusione. Ed essere architetti a Milano, allora, esserlo fedelmente, per tutta una vita che dal XX scivola nel XXI secolo, è condizione di raro privilegio, poiché abbraccia praticamente tutto ciò che quel canone forma e informa. L’architettura infatti altro non è che il rapporto che l’uomo stabilisce con lo spazio e col tempo, e spazio e tempo sono concepibili soltanto grazie ai limiti entro i quali l’uomo opera e vive: la durata di una vita, i luoghi nei quali essa si consuma, la miriade di varianti che questa combinazione rende possibili — ma solo quella miriade di varianti, non una di più. Questa finitezza è la forza che l’uomo oppone alla leopardiana indifferenza con cui la natura tende all’entropia, ed è discernimento, resistenza, differenziazione — e l’architettura in questa lotta si trova lì, in prima linea, a definirla senza riposo, questa finitezza, e a rinnovarla e a farla bella, possibilmente, fintanto che il sole sorge ogni mattina e ogni sera tramonta.
I fratelli Gianmaria e Roberto Beretta, architetti in Milano dai primi anni Sessanta del secolo scorso ai nostri giorni, non hanno solo progettato e realizzato opere: hanno — insieme ad altri, beninteso, ma con una propria cifra che da tutti gli altri li distingue —, servito ogni giorno questo canone milanese del quale postuliamo l’esistenza, e senza il quale riesce difficile perfino spiegarsela, Milano. Ciò che viene in mente pensando a questo canone loro l’hanno vissuto come esperienza sensibile, o l’hanno appreso da altri protagonisti, o l’hanno addirittura realizzato; sono intrisi fin nel loro più tenero midollo di questa Milano della mente che ha creato la Milano reale, e di entrambe sono parte.
Non so dirlo meglio che con un esempio personale: mi si nomina Milano e io subito penso alla sua ritrosia, ai suoi orti segreti, ai cortili nascosti, alle terrazze invisibili, a Scerbanenco (patrigno, guarda la combinazione, dei fratelli Beretta, perché compagno della loro madre), alle vetrine, alle tavole calde, all’alluminio anodizzato che brillano nei romanzi di Scerbanenco, a Gio Ponti, a Gadda, ai parquettisti della Confidenza raccontati nell’Adalgisa, al massello nelle strade del centro, al porfido, al basolato, alle rotaie dei tram, ai tram, all’edilizia comune, non a caso detta civile, agli ingegneri, al culto del lavoro, a Enzo Jannacci che era cardiochirurgo, a Dario Fo che era laureato in pittura, a Giorgio Gaber che era chitarrista malgrado una paralisi che l’aveva colpito alla mano sinistra quando aveva nove anni, a Cochi che è ragioniere, a Renato che è geometra, a Luciano Bianciardi, a Gian Carlo Fusco, a Giovanni Testori, a Giuseppe Pontiggia, a Guido Piovene, a Cerutti Gino, a Duca Lamberti, a Umberto Simonetta, a Gino Bramieri, a Carlo Mazzarella, a Gianni Brera, a Beppe Viola, a Livio Garzanti, a Camilla Cederna, a Gae Aulenti, a Giorgio Strehler, a Ornella Vanoni, a Gianni Rivera, a Sandro Mazzola, a Celentano, a Mina, a Memo Remigi, a Lucio Fontana, a Piero Manzoni, a via Bigli, al Duomo, alla Galleria, a corso Buenos Aires, alla Stazione Centrale, alla Rinascente, alla Borsa Valori, a Brera, alla Scala, alla Triennale, all’Expo, a Peck, al Bar Jamaica, al Derby, al Santa Tecla, allo Smeraldo, al Palalido, alla Metropolitana, a San Vittore, a San Siro, al Vigorelli, all’Idroscalo, a Linate, alla Torre Velasca, al Pirellone, alla Torre Galfa, al Bosco Verticale, al Politecnico, alla Bocconi, alla Cattolica, alla Bovisa, alla Rotonda della Besana, al Parco Lambro, al Giambellino, alla Comasina, a Quarto Oggiaro, a Lorenteggio, alle banche, agli uffici, alle fabbriche, a Rocco e i suoi fratelli, a Miracolo a Milano, al Generale Della Rovere, a Teorema, a La notte, a La vita agra, a Romanzo popolare, a Totò, Peppino e la malafemmina, al Design, a Pierino Busnelli, alla B&B, a Ettore Sottsass, a Mario Bellini, a Vico Magistretti, a Bruno Munari, a Bob Noorda, a Marco Zanuso, a Enzo Mari, a Franco Albini, a Ernesto Nathan Rogers, ad Alberto Rosselli, al magistero inestinguibile di Gillo Dorfles, all’alta moda, a Ermenegildo Zegna, a Giorgio Armani, a Gianni Versace, a Gianfranco Ferré, al Martini, al Campari, al Cynar, all’amaro Ramazzotti, a tangentopoli, a quello che Montale chiama «l’enorme conglomerato di eremiti», a quello che Lucio Dalla chiama «lo sguardo maligno di Dio».
Mi si nomina Milano e io penso a tutto questo, tutto insieme — e tutto questo insieme ci sta eccome, è un blocco unico e coerente, ed è solo quel blocco, ed è più che genius loci, più che Dna, è più che luogo comune: è destino, cioè è — poiché abbiamo postulato che esista — il canone milanese. Ma anche se non esistesse, i fratelli Beretta ne sarebbero ugualmente un frutto purissimo: «per privilegio d’anagrafe», come dice Pasolini, e per l’intreccio fittissimo tra il respiro della loro città e la loro autobiografia — che alla fine «è ciò che ha più valore», come dice Gio Ponti.





