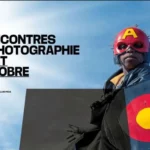LA CURA
“La montagna incantata” usciva lo stesso anno della “Psicologia delle masse” di Sigmund Freud Due geni, un’unica diagnosi: il crollo dell’Occidente
di Massimo Recalcati
Ogni “ sanità superiore”, come scrive Thomas Mann, per essere davvero tale, deve attraversare la conoscenza della malattia e della morte. È il grande tema che egli sviluppa in profondità ne La montagna incantata. È questa anche la sua estrema prossimità alla lezione di Freud. L’Europa nel suo insieme è chiamata in causa nella sua decadenza, riunita nella sua condizione morbosa, raccolta a pezzi nell’elegante sanatorio svizzero dove si svolge il racconto. Il Berghof non è, infatti, un semplice scenario narrativo, ma un vero e proprio universo che racchiude in un microcosmo le patologie di un continente condannato all’autodistruzione. L’operazione alchemica della trasformazione del dolore in rinascita non può essere, infatti, mai scontata. La montagna incantata viene pubblicata, non a caso, poco dopo la celebre
Psicologia delle masse e analisi dell’Iodove Freud descriveva i processi inconsci più torbidi che stavano portando l’Europa verso l’abisso dei totalitarismi e della Seconda guerra mondiale. Se nel sanatorio manniano sono raccolti i resti e i detriti di una borghesia e di una aristocrazia senza più avvenire, frammentata, malata, ridotta ad atomi melanconici, Freud, a sua volta, mostrava il carattere infatuato, esaltato della massa come corpo d’acciaio, espressione di una salute che non sorge affatto dall’attraversamento della malattia, ma dal suo feroce ripudio.
Mentre Mann indugia sull’umanità sofferente, la stagione del totalitarismo, nella sua versione fascista e nazista, esalterà la politica come un programma di biologia applicata finalizzata ad emendare ogni genere di impurità nel nome della creazione di una nuova razza di uomini che non conoscono sconfitta, malattia e morte. Mann aveva intuito tutto ciò che Freud teorizza: i fascismi storici non nacquero solo da circostanze economiche, ma dall’illusione che la ragione – come quella celebrata retoricamente nel sanatorio della Montagna incantata dall’umanista Settembrini la cui parola è sempre significativamente interrotta da una tosse persistente – potesse davvero salvare l’umanità dalla maledizione seduttiva di Thanatos.
Anche nel nostro tempo i nuovi populismi sovranisti sembrano agire come l’illusionista Cipolla, protagonista inquietante diMario e il mago: ipnotizzatori e seduttori delle masse si sostituiscono alla ragione critica grazie all’offerta di un’obbedienza estatica capace di rendere la vita individuale e collettiva priva di lacerazioni e sofferenze. Egli, come avviene per lo più nei leader populisti, non agisce più attraverso la forza bruta, ma per via di una seduzione perversa. È l’applicazione manniana dello schema freudiano della regressione di massa e dei suoi effetti catastrofici: l’illusione primaria è scongiurare il pericolo della contaminazione, eliminare dalla vita l’elemento spurio, il dolore e la malattia, l’inesorabilità insondabile della sofferenza. In questo senso il pensiero critico – la sua verticalità tragica – viene sostituito dall’adesione securitaria alla massa.
È quello che emerge anche nel linguaggio politico contemporaneo: l’odio per il migrante come nuovo “ ebreo”, la nostalgia dei confini inviolabili come fantasia di un corpo integro e incontaminato, la solidificazione dell’identità nazionale come effetto dell’individuazione di un nemico assoluto esterno, la sfiducia nelle istituzioni nel nome del popolo esaltato come entità mitica. La crisi geopolitica attuale e il trionfo delle spinte illiberali e nazionaliste che attraversano l’Occidente democratico ha la stessa radice che Mann e Freud diagnosticarono di fronte alla marea montante dei nuovi fascismi. Le masse hanno “nostalgia del padre”, rimpiangono i tiranni che promettono l’impossibile: cancellare l’incertezza e la mancanza dall’orizzonte della vita. In questo senso la democrazia, come Mann aveva ben colto, è per sua natura un corpo malato, un sistema che deve accettare la propria incompiutezza per non sconfinare verso forme di totalitarismo. È quello che paradossalmente accadrebbe se essa giungesse al suo definitivo compimento. In questo senso lo scrittore ha il compito di custodire le ferite senza pretendere di sanarle una volta per tutte. La tubercolosi che accomuna gli ospiti del Berghof non è una semplice affezione polmonare, ma la manifestazione di un male ben più profondo: l’incapacità dell’Europa di fare i conti con la propria incompiutezza necessaria, con l’esperienza virtuosamente spaesante della democrazia.
Non a caso l’ultimo Mann, quello di Giuseppe e i suoi fratelli,sosteneva la necessità della traduzione, del divenire stranieri a se stessi, della contaminazione di culture, perché la salvezza sta nel meticciato delle identità e non nel perseguimento di un fantasma fanatico di purezza. La morte delle grandi narrazioni del Novecento (la Razza, il Progresso, la Classe, la Storia), implica il crollo delle sue illusioni di onnipotenza e la necessità di unlavoro del lutto inedito. Altrimenti, come Freud ha indicato con precisione, il risultato può essere solo la ripetizione compulsiva del trauma sotto forma di nazionalismi sempre più aggressivi, di fondamentalismi religiosi terroristici o di tecnocrazie senza anima. Non a caso i “nuovi fascismi” non indossano camicie nere, ma parlano il linguaggio rassicurante della pulsione securitaria promettendo di sanare la ferita della globalizzazione con il mito della comunità chiusa, di curare l’angoscia di fronte alla crisi e alla guerra con l’irrigidimento dei confini e il loro presidio protezionistico.
Contro i nuovi illusionisti alla Cipolla che promettono paradisi identitari, dobbiamo ricordare con Freud e con Mann che la civiltà sopravvive solo se accetta il carattere inguaribile della sua malattia: la democrazia è quel sanatorio aperto sull’abisso dove, come Hans Castorp, dobbiamo imparare innanzitutto ad ascoltare la verità inquieta dei nostri sintomi.