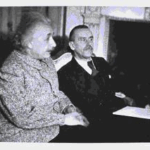bernard-henry lévy
È una voce emersa dalla parte oscura e luminosa della mia gioventù. Luminosa perché Ivan Butel, l’autore del romanzo De silence et d’or, è figlio di Michel Butel, uno dei miei più cari amici fino alla sua morte, avvenuta nel 2018. Oscura perché con Pierre Goldman, suo fratello d’anima, è stato tra gli ispiratori del protagonista del mio primo romanzo, Il diavolo in testa, la cui carica scura mi terrorizza ancora oggi, quando lo rileggo.
Ma non è questo il momento della memoria. È del figlio che si tratta e di questo libro particolare e bello che, pochi mesi fa, ha pubblicato con l’editore Globe. Il protagonista, Cha, ha fatto parte di Grapo, un’organizzazione maoista spagnola di sinistra che, a differenza dei suoi equivalenti francesi, andò oltre e passò al terrorismo. Diventato tetraplegico dopo uno sciopero della fame in carcere, si è trasformato in campione di nuoto e ha vinto numerose medaglie ai Giochi paralimpici di Sydney, nascendo così una seconda volta.
Ma ecco che a Vigo ( città della Spagna affacciata sull’Atlantico, da lui mai lasciata e quindi teatro delle sue due vite consecutive) emerge un narratore che si guadagna la fiducia e indaga su quel passato di cui aveva creduto di potersi disfare come ci si disfa di un anello gettandolo in acqua.
Rimpianti? Naturalmente sì, rimpianti. E anche un disgusto per quella che all’epoca, con una leggerezza criminale, si chiamava la “lotta armata”. Nessun ravvedimento, però. Nessuna richiesta di perdono. E un mutismo sfuggente e indecifrabile che sembra quello di una Pizia impedita. Abbiamo la sensazione che si tratti di un uomo gentile, rimasto celatamente radicale. Formidabile dialettico, ma ormai così schivo da negare alla giustizia degli uomini, che del resto non la esige, la commedia della contrizione.
Con Michel abbiamo conosciuto personaggi siffatti. Li abbiamo frequentati quando erano latino-americani, un po’ dostoevskiani, e avevano i poliziotti alle calcagna. Li abbiamo sostenuti, quando non passavano all’azione, per il loro tremendo desiderio di assoluto. Ed eccoli che, mentre l’inchiesta del figlio insegue le fantasie del padre, salgono dall’oltretomba e confondono di nuovo tutte le tracce.
Ivan Butel racconta, ma io sento la voce di Michel. Ivan ascolta il silenzio di Cha, ma è Michel che vedo, là in alto, con la chioma bianca degli ultimi tempi della sua vita, mentre annuncia un’epoca di luci nere che la nostra generazione ha visto arrivare ma non ha saputo scongiurare. L’orologio del tempo è definitivamente impazzito? E quando? Per saperlo, sarebbe necessario leggere insieme i romanzi del padre e del figlio.
Ho conosciuto Marie-Laure de Decker nel 1974, quando con Michel Butel demmo vita al quotidiano L’Imprévu, di cui lei divenne la fotografa. È morta esattamente due anni fa, a Tolosa, ed è alla pietà di un figlio, Pablo Saavedra de Decker, che anche lei deve la sua nuova nascita in un’esposizione alla Maison europe?enne de la photographie.
Marie-Laure de Decker era coraggiosa e bella. Senza compromessi. Immensamente affascinante. Fu fotografa di guerra in Vietnam ma, in precedenza, era stata indossatrice per Madame Grès. Trascorse un anno presso i Toubou d’Hissène Habrè, ma non disdegnò di frequentare Giscard d’Estaing quando volle ottenere i documenti per i suoi amici delle Pantere Nere. Era innamorata di un attivista cileno che avrebbe potuto essere il fratello di Cha di Ivan Butel ma, il giorno in cui il “traditore della società” Mitterand (che era stato sconfitto da Giscard ma intendeva riprendere il sopravvento in tutti gli ambiti della vita) accettò di farmi avere un testo per il primo numero dell’Imprevu a condizione che a ritirarlo fosse lei, Marie-Laure, amica del giovane Giscard, ebbene quel giorno lei si mise in marcia ridendo e andò a Latche, dove Mitterand aveva una casa. Poi, venuto il tempo di ritornare sobri e di congelare le rivoluzioni, quando l’antimperialismo pavlovizzato cedette il posto a un umanesimo concreto, quando infine si sostituì all’amore fanatico del genere umano l’amore di questi o quegli umani, lei scelse i Woodabe (Bororo) e andò a fotografarli nel sud del Ciad ogni anno, fino alla fine dei suoi giorni.
Perché la cosa principale, naturalmente, era il suo occhio. Vedeva tutto. Capiva tutto. Pochi fotografi sono riusciti, come lei, a penetrare la purezza riservata di un volto umiliato di Soweto. Pochi hanno conosciuto, come lei, l’arte di riuscire a mostrare, senza dirla, la verità nascosta di una scena funebre guidata da Augusto Pinochet. Il suo potere era talmente grande che in lei c’era – ne sono stato testimone, una volta – la paura del “pittore di battaglie” che vede tornare lo spettro dei prigionieri di un campo di rieducazione in Mozambico il cui supplizio lei aveva reso, per così dire, eterno.
Apparteneva alla razza di Lee Miller, con il suo gusto di esserci quando c’è un evento storico dalle conseguenze profonde. Apparteneva alla razza di Margaret Bourke-White, con l’inaspettata resistenza fisica di quel suo delizioso corpo da elfo. E i suoi ritratti di Orson Welles, Duke Ellington o Man Ray avevano la qualità di quelli di E?douard Boubat, che con lei condivideva l’incarico di fotografo ufficiale del nostro Impre?vu.
Grazie a Pablo e Balthazar, suoi amati figli, il nome di Marie-Laure de Decker non sarà dimenticato. —
Traduzione di Anna Bissanti