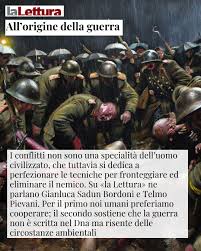Saragiolo: Domenica 3 Agosto, 𝐆𝐈𝐑𝐎𝐕𝐀𝐆𝐎 𝐄 𝐑𝐎𝐍𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀
26 Luglio 2025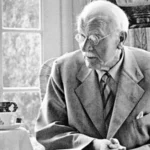
Glen Slater “Torniamo a sognare con Jung”
27 Luglio 2025I conflitti non sono una specialità dell’uomo civilizzato, che tuttavia
si dedica a perfezionare le tecniche per identificare, fronteggiare ed eliminare il nemico. «La Lettura» ha chiesto a un filosofo del diritto e a un filosofo della scienza di dialogare: Gianluca Sadun Bordoni, che al tema ha dedicato un libro, nota come,
in realtà, noi umani preferiamo cooperare; Telmo Pievani osserva che, se nella preistoria
già ci si ammazzava,
il combattimento non è scritto nel Dna ma risente di circostanze ambientali
Antonio Carioti
I conflitti bellici non sono una specialità dell’uomo civilizzato. Esistevano nella preistoria e anzi appartengono allo sviluppo evolutivo della nostra specie e forse anche dei nostri antenati preumani. È la tesi che Gianluca Sadun Bordoni, professore di Filosofia del diritto all’Università di Teramo, avanza nel saggio Guerra e natura umana (il Mulino), sul quale lo abbiamo chiamato a confrontarsi con Telmo Pievani, docente di Filosofia delle scienze biologiche dell’Università di Padova.
TELMO PIEVANI — Il conflitto tra gruppi fa parte del nostro retaggio evolutivo e della natura umana. Ma lo stesso vale per la cooperazione, l’altruismo, i comportamenti solidali. C’è un’ambivalenza di fondo. Uno scienziato extraterrestre che osservasse noi umani rimarrebbe colpito dalle guerre, ma anche dal fatto che sappiamo convivere in grandi città tra milioni di estranei, rispettiamo delle regole, siamo tendenzialmente gentili e tolleranti gli uni verso gli altri. Se invece mettete degli scimpanzé estranei fra loro in un vagone della metropolitana, succede un macello.
Quali prove abbiamo di stragi tra esseri umani avvenute nella preistoria?
TELMO PIEVANI — Ci sono due casi in cui un gruppo ne ha sterminato un altro, documentati dai ritrovamenti di ossa a Nataruk, in Kenya, e Jebel Sahaba, in Sudan. Però sono due episodi che risalgono il primo a 10 mila e l’altro a 13 mila anni fa. Il genere Homo ha 2 milioni e mezzo di anni, l’Homo sapiens ne ha 300 mila. Se l’aggressività deliberata di coalizione è radicata nell’evoluzione, perché ne troviamo solo tracce così recenti, in una fase già di transizione verso fasi di maggiore complessità delle gerarchie sociali? Non mi sembrano prove decisive per concludere che la violenza di gruppo è un tratto dominante della nostra specie, anche se di certo esiste come aspetto di quello che chiamiamo «paradosso della bontà».
In che cosa consiste questo paradosso?
TELMO PIEVANI — Come già osservava Charles Darwin, la socialità umana si è organizzata a lungo per piccoli gruppi tendenzialmente in competizione tra loro. Abbiamo quindi sviluppato una solidarietà benevola nei riguardi dei membri della nostra comunità ristretta. Ma questo «altruismo parrocchiale» ha un lato oscuro: ci aiutiamo reciprocamente all’interno del gruppo per opporci meglio ai gruppi rivali. Quindi il paradosso è che la cooperazione ha la stessa radice del conflitto.
GIANLUCA SADUN BORDONI — Ai ritrovamenti di Nataruk e Jebel Sahaba se ne stanno aggiungendo altri, uno anche in Italia, risalente a 15-20 mila anni fa. D’altronde più si va indietro nel tempo e più è difficile rinvenire resti ossei. Di certo nella nostra specie c’è un’ambivalenza tra conflitto e cooperazione. Ma la cooperazione stessa risulta ambigua: si collabora per prestarsi aiuto reciproco, ma anche per uccidere i nemici.
Ma fino a quando risale tutto questo?
GIANLUCA SADUN BORDONI — La mia indagine va all’indietro nel tempo. Tutte le civiltà storiche, indipendenti le une dalle altre, conoscono la guerra: la troviamo in Mesopotamia, in America, in Cina. Se retrocediamo alla preistoria, gli indizi etnologici e archeologici circa la presenza diffusa di conflitti presso i nostri antenati cacciatori-raccoglitori si sono di recente moltiplicati. La possibilità di estrarre il Dna dai fossili ha fornito ulteriori prove di violenza letale tra esseri umani, non sappiamo se individuale o coalizionaria, compresi casi di cannibalismo, che risalgono a 800-900 mila anni fa. Del resto gli esploratori europei hanno sempre testimoniato l’esistenza di guerre tra gli indigeni. Lo fece per esempio un forzato inglese deportato in Australia, William Buckley, che nel 1803 era sfuggito alla detenzione ed era vissuto trent’anni in una tribù rimasta allo stato di natura.
Ciò basta a sancire l’onnipresenza della guerra?
GIANLUCA SADUN BORDONI — In realtà noi umani cooperiamo molto più che combattere. Ma di fatto abbiamo sempre combattuto. E non sembra che questa attitudine tenda a sparire. Se poi facciamo un altro passo indietro nel tempo, constatiamo che presso altri primati e in particolare gli scimpanzé, che sono i nostri cugini più prossimi, esistono forme di violenza organizzata. Jane Goodall, celebre primatologa, assistette attonita in Africa tra il 1974 e il 1978 alla «guerra di Gombe», lo scontro tra due gruppi di scimpanzé che si concluse con lo sterminio di uno di essi e la conquista del suo territorio da parte dell’altro.
E questo che cosa dimostra?
GIANLUCA SADUN BORDONI — Nel caso di omologie comportamentali tra le specie, generalmente gli studiosi le riconducono a un progenitore comune. Se è così per la violenza di coalizione praticata da noi e dagli scimpanzé, essa va fatta risalire a milioni di anni fa. È solo un’ipotesi, ma mi pare plausibile.
E l’idea che Homo sapiens abbia prevalso sui Neanderthal, oggi estinti, eliminandoli fisicamente?
TELMO PIEVANI — Quando i nostri antenati sono usciti per l’ultima volta dall’Africa, tra 60 e 70 mila anni fa, nel giro di alcuni millenni hanno contribuito sicuramente all’estinzione di tutte le altre specie umane, non solo dei Neanderthal. E 40 mila anni fa siamo rimasti l’unica presenza umana sulla Terra. Secondo alcuni studiosi ciò è avvenuto perché li abbiamo soppressi con la violenza. Ma a me non pare un’ipotesi probabile.
Perché?
TELMO PIEVANI — Se ci fosse stata una guerra tra specie, dovremmo trovare evidenze sistematiche di uccisioni almeno nell’ultima fase di esistenza dei Neanderthal. Invece ci sono solo due casi in cui si osservano nei loro resti delle ferite che potrebbero essere state inferte da Homo sapiens. A fronte di questi ritrovamenti, ci sono centinaia di siti neanderthaliani in cui l’ipotesi dell’estinzione violenta non trova riscontro. Inoltre nell’evoluzione i conflitti di gruppo tra specie diverse sono rarissimi, rispetto a quelli assai più frequenti all’interno della stessa specie. I gruppi di scimpanzé lottano tra loro, ma non si è mai visto che organizzassero spedizioni per ammazzare i bonobo. Quindi se rinveniamo le spoglie di Neanderthal soppressi in modo violento, l’ipotesi più logica è che gli uccisori appartengano alla stessa specie e non a Homo sapiens.
E allora come sono scomparsi i Neanderthal?
TELMO PIEVANI — Sappiamo che hanno convissuto con Homo sapiens per decine di migliaia di anni in vasti territori. Le due specie si sono anche ibridate. Tutto ciò è poco compatibile con uno scenario di guerra. Lo squilibrio si è verificato, ma è stato tardivo. Potrebbe averlo provocato una pandemia, alla quale gli uni hanno resistito e gli altri no, ma Neanderthal ci ha messo 13 mila anni per estinguersi e il contagio di solito va ben più veloce. Probabilmente è un caso di competizione demografica. Quando due specie molto simili vivono nella stessa nicchia ecologica, se una acquisisce un vantaggio demografico, l’altra è perduta. Homo sapiens ha presumibilmente sommerso i Neanderthal con la forza dei numeri e un po’ si è fuso con loro, fino a farli scomparire. Un processo ben diverso da una guerra.
GIANLUCA SADUN BORDONI — Io non sostengo che ci sia stato uno sterminio sistematico dei Neanderthal da parte di Homo sapiens. Non ne abbiamo le tracce e peraltro sarebbe difficile trovarle a decine di migliaia di anni di distanza. Però l’ingresso della nostra specie nei territori dominati dai Neanderthal determina in alcuni millenni la loro estinzione secondo il meccanismo di esclusione competitiva descritto da Pievani. Per quanto ne sappiamo, i vantaggi dell’ Homo sapiens erano due. Innanzitutto la superiorità tecnologica, con lo sviluppo di un’arma, un propulsore che scagliava frecce a lunga distanza, il cui uso corrisponde alle ferite riscontrate sui resti di alcuni Neanderthal. Inoltre i nostri antenati formavano gruppi più numerosi, quindi più potenti e organizzati, rispetto a quelli della specie concorrente. Entrambi questi fattori generano una maggiore capacità offensiva di Homo sapiens che qualche ruolo nell’estinzione dei Neanderthal deve averlo giocato. Vorrei poi aggiungere qualcosa sul «paradosso della bontà».
Di che si tratta?
GIANLUCA SADUN BORDONI — In fatto di violenza, bisogna distinguere tra quella reattiva a caldo, praticata dallo scimpanzé molto più che dall’Homo sapiens, e quella proattiva, organizzata e pianificata, in cui a primeggiare è la nostra specie. Secondo lo scienziato Richard Wrangham gli esseri umani hanno sviluppato, specie attraverso il linguaggio e la condivisione di un’intenzionalità, il potere della coalizione. Ciò ha mandato in crisi il sistema del maschio alfa tipico degli altri primati, per cui un individuo dominante diventa il tiranno assoluto del gruppo. Nell’Homo sapiens invece, sostiene Wrangham, gli altri maschi si alleano ed eliminano il despota: quindi nella nostra specie la diminuzione della violenza reattiva sarebbe il prodotto di una intensificazione dell’aggressività proattiva di coalizione. Un’ipotesi già prefigurata nei suoi studi da Sigmund Freud.
Pensate che nel determinare l’aggressività della nostra specie abbia influito anche la sua fragilità? È la tesi sostenuta sullo scorso numero de «la Lettura» dallo scrittore giapponese Uketsu.
TELMO PIEVANI — C’è chi sostiene che l’inadeguatezza delle sue difese naturali abbia contribuito a sviluppare le capacità offensive dell’uomo. Ma è semplicistico dire che ci siamo muniti di armi per supplire alla mancanza di artigli. In effetti nell’Homo sapiens c’è una selezione verso la docilità, ma sempre all’interno di un gruppo che poi, proprio per la solidarietà tra i suoi membri, diventa più efficiente nella caccia e nella competizione con altre comunità. L’uomo è fragile: per esempio i suoi cuccioli rimangono inermi e vulnerabili per molti più anni rispetto ad altre specie. Ma paradossalmente questo si è rivelato un punto di forza, perché così i cuccioli hanno più tempo per l’educazione, il gioco, la sperimentazione, insomma l’evoluzione culturale.
GIANLUCA SADUN BORDONI — È un fatto che Homo sapiens ha supplito alla carenza di mezzi difensivi con l’organizzazione. Per centinaia di migliaia di anni siamo stati prede e predatori, quindi abbiamo sperimentato con successo il potere della cooperazione nella caccia. Una volta acquisito il dominio ecologico, i rivali più pericolosi diventano gli appartenenti alla nostra stessa specie, nella lotta contro i quali si adottano i mezzi già utilizzati nella predazione.
TELMO PIEVANI — Prima della domesticazione di piante a animali con l’agricoltura e l’allevamento, quando eravamo cacciatori-raccoglitori, il conflitto tra gruppi umani aveva una funzione di controllo sul territorio e di riproduzione, con la lotta per l’acquisizione delle donne. La guerra ha dunque un aspetto adattativo, ma è anche una pratica rischiosa e costosa, determina un’alta perdita di vite. Quindi si scatena solo in presenza di certe condizioni ambientali riguardanti la densità di popolazione e le risorse disponibili. Inoltre pesa anche l’esistenza di un’asimmetria di forze che convince uno dei due gruppi di poter sconfiggere l’altro. Conflitti del genere sono documentati anche tra le comunità di cacciatori-raccoglitori tuttora presenti sulla Terra. Però di solito sono scontri brevi, incursioni, raramente diventano conquiste con l’annientamento del gruppo avverso.
Quando abbiamo cominciato a fare la guerra?
TELMO PIEVANI — Secondo me è avvenuto con le ultime ondate di Homo sapiens uscite dall’Africa, 60 mila anni fa. Si nota all’epoca un mutamento nell’organizzazione umana. Ma ben più radicale è la successiva trasformazione nel Neolitico, quando cambia il modo di gestire il territorio, agli ecosistemi viene fatto produrre un surplus di risorse, le società diventano sedentarie, nasce l’esigenza di difendere confini e proprietà, cresce la popolazione e si pone l’esigenza di colonizzare altre zone, entrando in conflitto con gli autoctoni. È una rivoluzione che moltiplica i conflitti. C’è chi sostiene che il cromosoma Y umano, quello maschile, ha una variabilità genetica bassa perché tra 5 e 7 mila anni fa il numero dei maschi che si riproducevano era molto inferiore alla loro totalità, in quanto molti perivano in guerra.
Da allora non abbiamo mai smesso di combatterci?
TELMO PIEVANI — Qui il problema riguarda la storia, materia in cui non mi avventuro. Però mi lascia dubbioso la testi esposta nel libro di Sadun Bordoni, secondo cui la guerra ha una razionalità. Il fatto che un nostro comportamento abbia una radice biologica non significa che sia razionale continuare a praticarlo. Ci portiamo dietro tanti adattamenti evolutivi utili nel passato, per esempio in campo alimentare, che ora ci fanno male.
GIANLUCA SADUN BORDONI — La guerra è molto rischiosa, bisogna capire perché resta tuttora un’attività frequente. Di solito la si intraprende quando si ritiene che il rapporto costi-benefici sia vantaggioso per quanto riguarda la conquista di territorio, risorse, opportunità riproduttive. Qui risiede la razionalità della guerra. Tutto cambia se si passa dalle bande di cacciatori-raccoglitori alle società stanziali, che costruiscono fortificazioni e sono in grado di sostenere conflitti prolungati. Però rimane un dato strutturale: i capi militari tendono ad approfittare dell’asimmetria di potere, della possibilità di attaccare a sorpresa con forze superiori. A tal proposito si possono commettere anche clamorosi errori di valutazione, ma decisivo resta il venir meno della deterrenza, che sembra funzionare da detonatore sia per gli scontri tra bande preistoriche sia per i conflitti attuali.
TELMO PIEVANI — L’analogia vale anche per gli scimpanzé, dediti a compiere raid cruenti sui gruppi rivali. L’analisi contenuta nel libro di Sadun Bordoni sulle vicende storiche, circa la deterrenza e il fallimento delle ambizioni pacifiste, mi pare convincente. Chiedo però: è necessario cercare una conferma di queste tesi realistiche, di per sé solide, nell’evoluzione biologica? In che senso possiamo tracciare una continuità tra una banda di cacciatori-raccoglitori e uno Stato moderno, con tutte le differenze immense che esistono tra le due realtà?
GIANLUCA SADUN BORDONI — Ho messo insieme le due parti del saggio — quella storico-politica e quella paleo-antropologica — perché a mio avviso stanno crollando assieme l’assetto politico e quello culturale del dopoguerra. Nella prima parte cerco di dimostrare come si stia dissolvendo l’illusione di una pace post-storica, coltivata soprattutto dopo il crollo dell’impero sovietico. E nella seconda illustro come stia svanendo il mito della pace preistorica. A mio avviso i due fenomeni si tengono insieme nel confermare la guerra come dimensione costante dell’esperienza umana.
C’è chi però ha teorizzato il declino della violenza.
GIANLUCA SADUN BORDONI — Lo psicologo Steven Pinker ha osservato che il tasso di omicidi è crollato negli ultimi secoli e le nostre società sono molto più pacifiche rispetto al passato. Se abbiamo ridotto la violenza tra individui, ha concluso, supereremo anche quella tra gli eserciti. Ha interpretato le due guerre mondiali come il rigurgito di un passato destinato a scomparire. Ma è stato smentito, perché la diminuzione della violenza all’interno di vari Paesi si deve all’azione repressiva dello Stato, ma nelle relazioni internazionali non c’è un’autorità mondiale capace d’imporsi alle singole nazioni e di fare da pacificatrice. Il fatto che la guerra tra grandi potenze si ripresenti come un’eventualità possibile mi ha spinto a esplorare le radici remote del fenomeno.
Però non tutti gli studiosi sono concordi sulle origini biologiche della guerra.
GIANLUCA SADUN BORDONI — Nell’antropologia postbellica ha prevalso a lungo l’indirizzo di Margaret Mead secondo cui la guerra è solo una «cattiva invenzione culturale», tesi ribadita anche da una dichiarazione dell’Unesco: chi dissentiva era considerato eretico. Ma da trent’anni gli studi hanno registrato una svolta, soprattutto grazie al lavoro di Lawrence Keeley uscito nel 1996, per cui oggi si ritiene che i conflitti bellici abbiano radici nella storia naturale di Homo sapiens.
TELMO PIEVANI — In effetti Pinker ha sbagliato molte previsioni. Quanto all’orientamento degli studi, se l’antropologia era sbilanciata nel senso di ritenere l’uomo una specie pacifica, la biologia evoluzionista ha invece oscillato molto fra tesi opposte, Homo sapiens di volta in volta scimmia assassina o scimmia empatica.
Sadun Bordoni scrive nel libro che la guerra è radicata, ma non innata. C’è speranza di superarla?
TELMO PIEVANI — Di certo la guerra non è un istinto, non è scritta nel Dna. Si modula in base alle circostanze ambientali. Ciò vuol dire che il conflitto armato di gruppo è una struttura culturale umana che ha delle basi evolutive. Il fatto è che noi Homo sapiens di oggi, a parte bisogni primari come il sesso e il cibo, non abbiamo più schemi comportamentali innati con una base genetica definita. La guerra si può considerare una propensione naturale: un retaggio evolutivo che ci fa preferire certi atteggiamenti, ma non è scolpito nella pietra una volta per tutte. Si può reprimerlo e contenerlo.
Ma come?
TELMO PIEVANI — Qualche anno fa la neuroscienziata Elizabeth Phelps ha monitorato il cervello di persone a cui veniva mostrato all’improvviso su uno schermo il volto di un individuo di etnia diversa. In tutti scattava l’amigdala, che si attiva quando si avverte un senso di minaccia. Subito dopo scattavano le aree corticali che interagiscono con l’amigdala, razionalizzano la situazione e attenuano l’allarme. Poi è stata introdotta una variante: il volto che veniva mostrato era sempre di etnia diversa, ma appartenente a una persona famosa, uno sportivo o un musicista. In quel caso l’amigdala non reagiva. La differenza tra il primo esperimento e il secondo è culturale, ma in grado di produrre effetti biologici. Questo è il punto: la propensione alla guerra è naturale, ma nella storia della specie si mescola a elementi ambientali e culturali che possono contenerla. Anche Darwin ipotizzava che la solidarietà di gruppo si potesse allargare all’intero genere umano, anzi a tutta la biosfera, ma temeva anche che qualcuno potesse riattizzare sotto la cenere la brace del tribalismo conflittuale.
GIANLUCA SADUN BORDONI — Se scomparissero la cause più frequenti dei conflitti cruenti — dispute territoriali, scarsità di risorse, minacce di vario tipo — probabilmente la guerra sparirebbe. Invece se venissero meno le fonti alimentari di certo non svanirebbe la fame, anzi moriremmo d’inedia. È quindi evidente la differenza tra un istinto incoercibile come la fame e la guerra, che è sempre legata a un calcolo costi-benefici.
C’è quindi il modo di eliminarla?
GIANLUCA SADUN BORDONI — L’ipotesi di superarla integralmente a me sembra irrealistica. È molto improbabile che scompaiano tutte le sue ragioni. Immanuel Kant sperava nella pace, ma non nella nascita di uno Stato mondiale, che a suo parere avrebbe determinato un dispotismo assoluto e si sarebbe poi frammentato in entità rivali. Se la divisione del pianeta in una pluralità di Stati non risulta superabile, è ben difficile che si possano eliminare le guerre. La cultura può aiutare, ma non dimentichiamo che un Paese civile e colto come la Germania ha prodotto il nazismo. Ciò non significa che non ci sia nulla da fare. Ma a me pare che l’unico modo di limitare la guerra sia assicurare la deterrenza. La pace non è una condizione naturale di convivenza tra gli uomini, va costruita rendendo il costo della guerra superiore ai suoi possibili benefici.
https://www.corriere.it/la-lettura/