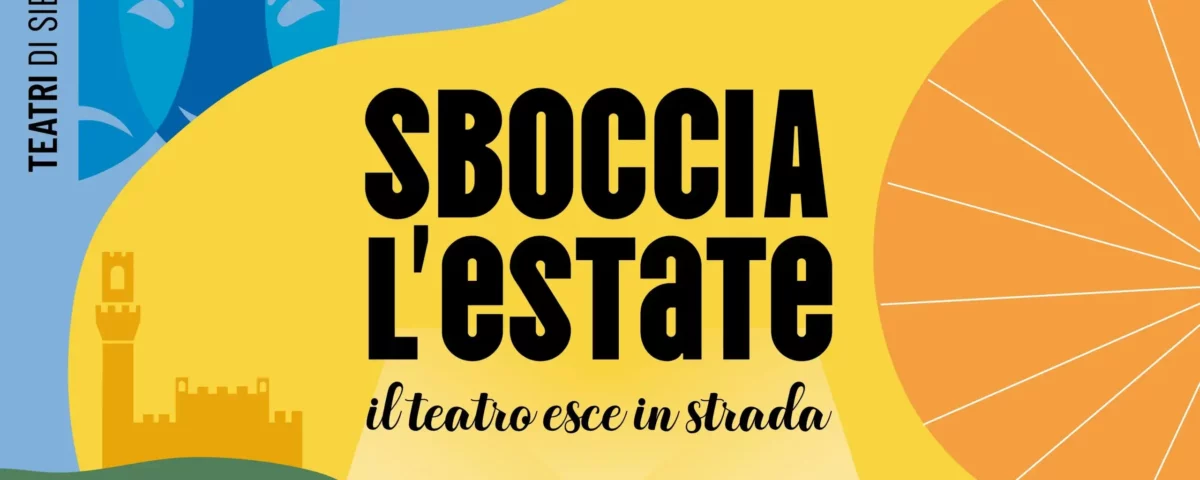Reindustrializzazione dell’area Beko: il Comune tra legittimità, responsabilità e governance
30 Luglio 2025
Piancastagnaio celebra Francesco di Valdambrino. Avviato ufficialmente il progetto per una grande mostra dedicata allo scultore e castellano amiatino.
30 Luglio 2025Cosa significa oggi programmare cultura in una città come Siena? Quali responsabilità comporta l’uso di uno spazio simbolico come Piazza del Campo? E cosa implica, nel lungo periodo, la trasformazione dei luoghi della memoria civica in contenitori per eventi spettacolari e gratuiti? L’iniziativa Sboccia l’estate, promossa dall’amministrazione comunale, ha portato in dieci giorni otto spettacoli e – secondo stime ufficiose – circa quarantamila presenze. Numeri importanti, che testimoniano senza dubbio un’esigenza di ritrovarsi, di partecipare, di abitare nuovamente gli spazi pubblici con leggerezza e curiosità. Tuttavia, al di là dell’entusiasmo, credo sia necessario interrogarsi sul significato culturale più profondo di queste scelte.
La decisione di allestire stabilmente un palco in Piazza del Campo per diversi giorni consecutivi non è solo una questione logistica o estetica: è una scelta culturale e politica che ridefinisce la funzione stessa della Piazza. Da luogo della ritualità civica – dove si celebra la sovranità popolare attraverso il Palio, le cerimonie, i cortei – la Piazza diventa scenografia neutra per uno spettacolo da consumare. È una trasformazione che incide sulla percezione collettiva e sull’identità della città, e lo fa spesso senza una riflessione pubblica approfondita.
Molte delle dichiarazioni rilasciate dai responsabili della programmazione si muovono in una direzione chiara: andare incontro al pubblico, superare l’elitarismo, proporre eventi accessibili e facilmente comprensibili. Sono obiettivi legittimi, e largamente condivisibili. Ma accessibilità non può diventare sinonimo di semplificazione. Una cultura pubblica matura non si limita a intrattenere: deve saper interrogare, provocare domande, offrire strumenti critici. Non basta riempire la piazza per avere una città culturalmente viva. Occorre costruire percorsi di senso, immaginare narrazioni, progettare momenti in cui la cittadinanza si riconosca non solo come spettatrice, ma come soggetto culturale. In assenza di questo lavoro, il rischio è che la cultura venga ridotta a evento decoroso, funzionale, leggero, che non lascia tracce.
Anche la questione della gratuità, così spesso presentata come un atto di apertura, merita qualche riflessione. Chi garantisce la sostenibilità di questa scelta? E con quali implicazioni per l’autonomia artistica e per il rapporto tra cultura e cittadinanza? In molte città europee si stanno sperimentando modelli più partecipativi, capaci di coniugare inclusività e responsabilità. Si pensi, ad esempio, al principio del “pay what you want”, dove lo spettatore è invitato a contribuire secondo le proprie possibilità, oppure alla creazione di fondi civici per la cultura sostenuti da microdonazioni e partecipazione attiva. Sono strade che non risolvono tutto, ma pongono una questione fondamentale: la cultura pubblica non può essere solo offerta dall’alto, né trasformarsi in una serie di eventi da consumare passivamente. Deve fondarsi su un patto reciproco.
Lo stesso vale per la gestione degli spazi urbani. La scelta di spostare il cinema dalla Fortezza allo stadio per far posto a una programmazione più ampia di spettacoli è figlia di una logica di massima funzionalità. Ma la cultura urbana non è solo logistica. I luoghi pubblici – Piazza del Campo, la Fortezza, lo Stadio – portano con sé storie e significati che non si possono trattare come contenitori intercambiabili. Riutilizzarli, riassegnarli, riorganizzarli è sempre un atto culturale e politico, e come tale andrebbe discusso con la cittadinanza.
Non metto in discussione l’impegno di chi lavora alla programmazione culturale. Ma da queste scelte emerge con chiarezza una visione precisa della cultura, dello spazio pubblico e del ruolo dell’amministrazione. Una visione che non giudico, ma di cui prendo atto, perché dice molto non solo di una rassegna estiva, ma della direzione intrapresa nella gestione della cosa pubblica. Sta ai singoli decidere se, e come, prenderne parte. Oppure no.