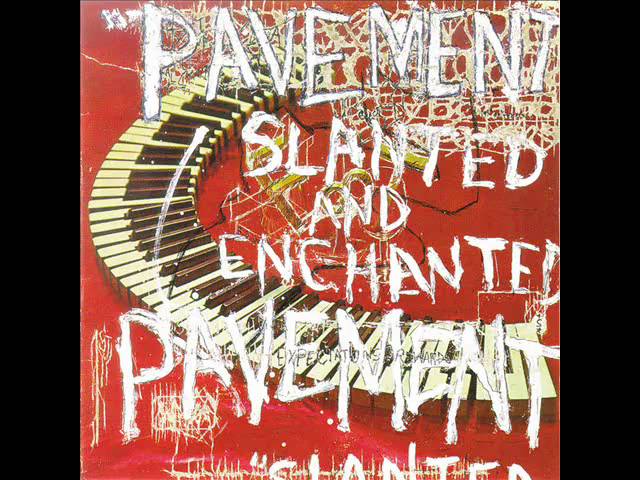Domani (ore 21) nel Cortile di Palazzo Strozzi la cantautrice apre il ciclo del Gabinetto Vieusseux con un reading sul poeta
di FULVIO PALOSCIA
Amara è sincera: «Conoscevo Mario Luzi, ma non avevo mai letto le sue poesie». Ha scelto il suo nome tra una lista di nomi che il Gabinetto Vieusseux le ha proposto quando l’ha invitata ad aprire, con un reading tra suoni e parole, domani nel Cortile di Palazzo Strozzi (alle 21, ingresso libero), la rassegna “La musica dei poeti. I poeti della musica”: «Ho imparato a non vergognarmi delle cose che non so — racconta la cantante e autrice pratese, al secolo Erika Mineo, che ha scritto successi per tanti artisti, uno su tutti:Che sia benedetta, Fiorella Mannoia — perché è proprio grazie al non sapere che si è terra fertile. Per Luzi è scattata un’attrazione quasi d’istinto, poi ho studiato e ho capito che mi somiglia. In tante cose».
Quali?
«L’attenzione all’umano, alla relazione dell’uomo con l’invisibile. La ricerca del senso e del significato dell’esistenza quotidiana. L’accettazione della nostra impotenza e la rivelazione che dentro l’umano si nasconde qualcosa di indecifrabile che si svela quando entri in contatto, appunto, con l’invisibile».
Una rivelazione che avviene, dice Luzi, attraverso la parola.
«Infatti: mi sento vicina a Luzi proprio per il valore che dà alla parola, intesa come tramite tral’umano e il divino, la parola che immerge nel flusso del tutto.
Anche io, come lui, chiedo un senso per il tempo, per lo scorrere della vita, per l’amore e per la morte».
Luzi non teme di definire l’invisibile come fede. Come mistero della fede.
«Ho provato una profonda emozione quando, in alcune interviste, il poeta ha raccontato la naturalezza, la tenerezza del suo approccio alla religione cattolica.
Gli è stata tramandata da sua madre, attraverso le opere di carità e di attenzione al prossimo.
Una donna che viveva nella fiducia della fede, e quella fiducia l’ha tramandata a Luzi, che ne ha fatto il centro del suo pensiero poetico.
Dove non manca la domanda delforse».
La sofferenza, diceva, è un pedaggio necessario.
«Io vedo il corpo come una macchina, un’astronave in cui sono installate le emozioni.
Compresa la sofferenza, che ci fa entrare in contatto con la nostra forza. Nella sofferenza c’è la solidarietà, l’accoglienza, l’empatia verso il prossimo. La sofferenza è una delle cose che ci accomuna tutti».
Per Luzi il dramma della seconda guerra mondiale fu determinante. Con quel conflitto, la sua parola fa un passo avanti verso il lettore. Davanti all’uomo che uccide l’uomo, non è più tempo di ermetismo. Anche noi oggi viviamo un tempo di terribili conflitti.
«Il passaggio di Luzi credo sia naturale quando chi fa arte si trova a vivere situazioni atroci.
L’astratto non è una freccia che arriva diretta, ma raggiunge solo chi frequenta quella visione in relazione al vivere. L’arte è l’unico spazio in grado di trasformare il dolore in poesia, è come una guarigione per l’umanità. E il compito del poeta, ci dicono i versi di Luzi, è di ricordare all’uomo la sua umanità. Un compito simile a quello dello scienziato o del religioso. Infine quando all’uomo si toglie la carezza del linguaggio, disse ancora, si compie un crimine contro l’umanità: lo sappiamo bene noi cantautori, che dovremmo essere gli ultimi depositari del coraggio di dire la verità, un coraggio in cui la comunità si riconosce».
Dunque secondo lei esiste un rapporto tra poesia e canzone?
«Rispondo partendo proprio da Luzi, dalla sua prefazione a un libro su De André. Luzi riconosce la matrice poetica dei testi di Faber, e io penso che il collegamento possa essere esteso a tutti i cantautori: come i poeti, siamo anime risvegliate in grado di percepire le stesse vibrazioni del tempo in cui viviamo. Gaber ha raccontato le stesse cose che provava Luzi, e ancora Battiato, Dalla, De Gregori, Vasco Rossi: sarà anche questo il tema del mio reading».
La poesia di Luzi è anche civile.
Come tanta canzone.
«A dei ragazzi che gli chiesero perché negli anni bui lui non fosse sceso in piazza a fare la rivoluzione, Luzi rispose con la sua fede nel potere scardinante della parola. La sua poesia fa molto di più della protesta: lui riesce a rimanere saldo nelle sue affermazioni e nelle sue idee nonostante la barbarie».