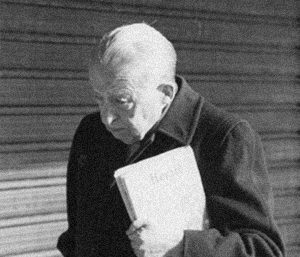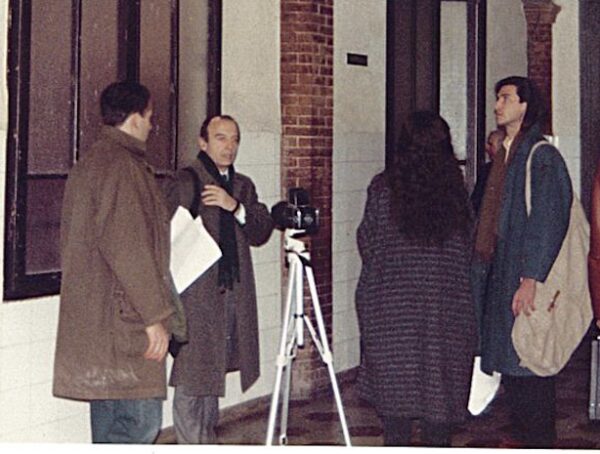Monte dei Paschi e Mediobanca: una questione di numeri, controllo e soglie decisive
5 Settembre 2025
MPS-Mediobanca, un’operazione ad alto rischio
6 Settembre 2025
C’era una volta Piazzetta Cuccia. Per quasi ottant’anni è stata il cuore segreto del capitalismo italiano: un luogo dove contavano i sussurri più dei contratti, le strette di mano più dei comunicati stampa. Oggi quel mondo appartiene al passato. Il segno della svolta è arrivato con l’offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi di Siena, che ha conquistato il 45,8% di Mediobanca.
Alberto Nagel, sessant’anni, guarda a questo epilogo da protagonista. Per diciotto anni ha guidato la trasformazione della banca, spostandola dall’ombra dei salotti finanziari verso il wealth management globale. Ora però non ci sono più battaglie da combattere: il 18 settembre, con ogni probabilità, presenterà le dimissioni. La sua ultima carta, la fusione con Banca Generali, è stata respinta dal 42% degli azionisti. Senza consenso, il fortino non regge. In finanza, come in politica, quando la maggioranza si sfalda, l’uscita di scena è inevitabile.
Il vero terremoto non è stato l’attacco di Mps, ma la resa delle famiglie che per decenni hanno custodito Mediobanca come un’istituzione nazionale. I Doris hanno dato il segnale: prima con la cessione del 3,5% a giugno, poi con lo 0,96% della holding FinProg. «L’operazione si fa», ha spiegato Sara Doris con pragmatismo. Tradotto: nessuna fedeltà, solo convenienza. Hanno seguito la stessa strada i Pittini, i Lucchini, Valsabbia Investimenti. Ognuno ha guardato al proprio bilancio, non alla memoria storica. È la certificazione che il capitalismo familiare italiano ha smesso di concepire sé stesso come custode delle istituzioni.
Dall’altra parte, Luigi Lovaglio ha condotto la partita con freddezza chirurgica. Ex Unicredit, oggi alla guida di Mps, ha saputo sfruttare i malumori interni, offrire un premio contenuto ma credibile, attendere il momento politico giusto. Con lo Stato che controlla l’11,8% di Siena, la copertura istituzionale non è mai mancata. Il rilancio con 0,9 euro cash per azione ha dato il colpo di grazia: più che il denaro, ha contato il messaggio di determinazione.
Il futuro è già scritto nei nomi della nuova governance: Vittorio Grilli, ex ministro ed executive di JP Morgan, per la presidenza; Mauro Micillo, manager proveniente da Intesa Sanpaolo, per l’amministrazione delegata. Figure solide, ma che incarnano un mondo normalizzato, molto distante da quello di Cuccia, Mattioli o Maranghi. Mediobanca diventerà una banca “normale”, parte integrante del sistema italiano ed europeo. Più efficiente forse, più redditizia, ma senza più quell’aura di eccezionalità che la rendeva unica nel panorama europeo.
Questa non è solo una vicenda italiana. È la parabola di molte istituzioni finanziarie storiche europee, assorbite da logiche di mercato e governance globalizzata. Le banche d’affari nazionali, autonome dai governi e radicate in reti relazionali di lungo periodo, lasciano spazio a soggetti ibridi: parte mercato, parte Stato, parte multinazionali della finanza.
La cifra vera di questa vicenda non si misura nei bilanci, ma nella perdita di un modello. Certo, gli advisor di Mediobanca — Centerview, Equita e Goldman Sachs — avevano valutato il titolo a 3,71 euro, contro i 2,618 offerti da Monte dei Paschi. Una differenza di oltre un euro per azione, che moltiplicata per centinaia di milioni di titoli significa miliardi bruciati. Ma la dimensione contabile, pur rilevante, non basta a spiegare la portata della resa.
Il vero prezzo è istituzionale e culturale: Mediobanca rappresentava l’ultimo baluardo di un capitalismo che si voleva indipendente dal potere politico, capace di garantire stabilità industriale anche nei momenti più fragili. Dal dopoguerra agli anni Novanta, Piazzetta Cuccia aveva fatto da mediatore tra imprese, banche e Stato, imponendo regole di sobrietà e competenza che la politica non riusciva a dettare. Con questa operazione, quell’indipendenza si dissolve. Non è solo l’ingresso di Monte dei Paschi, e dunque indirettamente dello Stato, nell’azionariato a segnare la svolta. È l’accettazione da parte delle grandi famiglie — i Doris, i Pittini, i Lucchini — che la logica della rendita immediata prevale sul ruolo di custodia storica. La dismissione non è un atto neutrale: certifica che in Italia il capitalismo relazionale e di lungo periodo non esiste più.
C’è anche un prezzo europeo: Mediobanca era percepita come un unicum, un soggetto capace di dialogare con i grandi investitori internazionali senza esserne subordinato, mantenendo una regia nazionale. Ora diventa una pedina nel mosaico bancario in cui le strategie sono dettate da esigenze di mercato, vincoli regolatori europei e rapporti con la politica. È la normalizzazione di un’eccezione.
Infine, c’è un prezzo generazionale: i manager cresciuti nell’alveo di Cuccia e dei suoi successori erano formati a un’idea di banca come “istituzione del Paese”, non come mero intermediario di profitti. La fuga di talenti che già si intravede rischia di svuotare l’istituto delle sue competenze distintive, impoverendo non solo Mediobanca, ma l’intero sistema finanziario italiano.
Il saldo finale, dunque, non è solo una minusvalenza economica. È la resa culturale e politica di un capitalismo nazionale che abdica al proprio ruolo di mediatore tra mercato e Stato, accettando di ridursi a ingranaggio di un sistema in cui contano soltanto trimestri, dividendi e opportunismi di breve periodo.
Quando l’assemblea del 28 ottobre eleggerà la nuova governance, si chiuderà un capitolo aperto nel 1946. Piazzetta Cuccia continuerà a esistere come indirizzo, ma non come mito. Forse nascerà una banca più moderna, forse più internazionale, forse più utile al mercato. Ma non sarà più Mediobanca. E mentre Alberto Nagel raccoglie le sue cose, la sensazione è che in quella trasformazione si consumi non solo la fine di una carriera, ma la dissoluzione dell’ultima istituzione autonoma del capitalismo italiano.