
Leone a Jarmusch A Venezia vince il cinema-cinema
7 Settembre 2025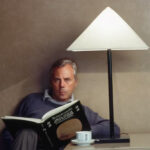
Le mille variazioni del canone Armani
7 Settembre 2025Al castello di Chantilly Il codice dei tre Limbourg per il duca di Berry, vertice del Quattrocento francese: una mostra eccezionale, che ricostruisce l’intero contesto
CHANTILLY
Insieme al Libro di Kells del Trinity College di Dublino e alla Bibbia di Borso d’Este dell’Estense di Modena, le Très Riches Heures del duca di Berry sono senza dubbio tra i manoscritti miniati più celebri al mondo. Più degli altri due, le Très Riches Heures hanno cristallizzato nell’immaginario collettivo l’immagine di una civiltà, quella dell’autunno del Medioevo, i cui demiurgi furono lo stesso committente, Jean de Berry, e tre giovani pittori, i fratelli Herman, Paul e Johan de Limbourg. Non privo di fondamento è che queste miniature stimolarono il giovane Umberto Eco ad «avvicinarsi» al Medioevo.
Oltre alla bellezza delle sue immagini, è proprio la complessa storia di questo libro «mondo», o «cattedrale», come spesso è stato definito, che lo ha reso celeberrimo. Rimaste incompiute alla morte del committente e dei tre pittori nel 1416, Barthélemy d’Eyck, su incarico forse di Renato d’Angiò, o del re di Francia Carlo VII, intervenne intorno al 1446 nelle Très Riches Heures per completare alcuni fogli già abbozzati dai defunti Limbourg. Più tardi, Carlo I di Savoia eredita il codice incompiuto, o dalla zia Carlotta, moglie del re di Francia Luigi XI (morta nel 1483), oppure dalla madre, Iolanda di Francia, figlia di Carlo VII e di Maria d’Angiò, e, verso il 1485, lo affida, per farlo completare, al miniatore di Bourges Jean Colombe. Questi e la sua bottega vi dipinsero una sessantina di scene, di cui ventiquattro a piena pagina, nonché più di trecento iniziali figurate.
Le Très Riches Heures passarono in seguito nelle collezioni di Margherita d’Austria (1480-1530), reggente dei Paesi Bassi nonché grande bibliofila, che aveva sposato nel 1501 Filiberto di Savoia. La reggente le fece poi trasferire a Malines, in Fiandra, dove divennero fonte di ispirazione preziosa per numerosi artisti nordici tra i quali Gerard Horenbout, Alexandre e Simon Bening, miniatori del celebre Breviario Grimani oggi alla Marciana di Venezia. Alla morte di Margherita d’Austria, il manoscritto passò a Jean Raffaut, suo tesoriere, per poi raggiungere Genova nei bagagli di Ambrogio Spinola (1569-1630), comandante delle truppe spagnole. Rimaste nella capitale ligure, le Très Riches Heures furono acquistate nel 1856 dal duca d’Aumale. Quinto figlio del re dei francesi Luigi Filippo d’Orléans e della regina Maria-Amalia di Borbone, il duca d’Aumale, all’epoca in esilio a Londra, poté comprare il codice per la somma di 18.000 franchi grazie alla mediazione di Antonio Panizzi, conservatore capo delle raccolte librarie del British Museum. Giunte nella capitale inglese il 15 febbraio 1856, le Très Riches Heures furono presentate ai conservatori del museo britannico, alla regina Vittoria e poi esposte al Fine Arts Club.

Dopo il rientro in Francia del duca d’Aumale (1871), Léopold Delisle, amministratore della Bibliothèque nationale e grande studioso di manoscritti, collegò nel 1881 il codice ai « plusieurs cayers d’une très riches heures que faisoient Pol et ses frères très richement historiez et enluminez» citati nell’inventario post-mortem del duca di Berry. A partire da questa scoperta, le Très Riches Heures assunsero il loro titolo definitivo, e fu così trovata anche l’esatta paternità dei primi artisti che avevano avviato la secolare campagna: Herman, Paul e Johan de Limbourg.
Confortato dalla bellezza delle pagine miniate e dal prestigio dei suoi miniatori, il duca d’Aumale poté infatti affermare: «Questo libro occupa un posto importante nella storia dell’arte; oserei dire che non ha rivali». Nel 1884 il duca lasciò il castello con tutte le sue terre e le sue collezioni artistiche e librarie all’Institut de France con la clausola che nessun’opera d’arte poteva essere né spostata all’interno del castello né prestata. Sudiate da Paul Durrieu nel 1904, poi da Millard Meiss nel 1974 e da Luciano Bellosi nel 1975, le Très Riches Heures sono state raramente esposte al pubblico: nel 1937 in occasione dell’Exposition universelle; nel 1956 in concomitanza con la mostra sui libri miniati in Francia che si tenne alla Bibliothèque nationale; e infine nel 2004 parallelamente alle rassegne del Louvre, Digione, Blois e Bourges sulle arti in Francia nel Quattrocento.
Il recente restauro della legatura e di alcuni fascicoli, a cura di Coralie Barbe e Florence Malo, permette adesso di presentare al pubblico i fogli sciolti del celeberrimo calendario, esposti come veri e propri dipinti, nonché la parte restante del codice, con un cambio di pagina ogni due settimane, in occasione della splendida mostra che si svolge nel Jeu de Paume del castello di Chantilly fino al 5 ottobre, organizzata in collaborazione con la Bibliothèque nationale de France (BnF) e i musei di Bourges.
Magistralmente orchestrata da Mathieu Deldicque, direttore del museo Condé, in collaborazione con Marie-Pierre Dion, conservatrice della biblioteca, la rassegna è anche l’occasione per riunire tutti i libri d’ore miniati per il duca di Berry (Bruxelles, Chantilly, New York e Parigi), altri capolavori delle sue collezioni nonché numerosi dipinti, codici miniati e sculture che offrono al visitatore la possibilità di immergersi in uno dei capitoli più affascinanti dell’arte europea del Quattrocento. Il denso catalogo, riccamente illustrato, edito in francese, inglese e tedesco, raccoglie numerosi saggi e schede analitiche firmati dai migliori esperti del soggetto e rimarrà senza dubbio una pietra miliare per quanti vorranno continuare a studiare il Quattrocento francese nei suoi rapporti con l’Italia e le Fiandre (Les Très Riches Heures du duc de Berry, a cura di M. Deldicque, Château de Chantilly-In Fine éditions d’art).
La pagina con cui si aprono le Très Riches Heures raffigura un banchetto presieduto dal duca di Berry e permette di cogliere immediatamente il gusto per gli oggetti di lusso e i fasti della vita di corte di questo principe, cui è dedicata un’ampia sezione della mostra. «Figlio, fratello e zio del re», Jean de Berry (1340-1416) era il terzo figlio del re di Francia, Jean II detto il Buono, fratello di Carlo V, re dal 1364 al 1380, nonché zio di Carlo VI, che regnerà dal 1380 al 1422. Il duca si circondò di una folla di artisti stipendiati quali lo scultore André Beauneveu, l’architetto Guy de Dampmartin o, appunto, i fratelli Limburg. Lo scultore Jean de Cambrai, valet de chambre del duca, realizzò il suo monumento funerario, destinato alla Sainte Chapelle di Bourges, poi trasferito nella cattedrale dopo il 1756: il gisant ha lasciato per la prima volta la capitale del Berry per essere esposto a Chantilly in occasione della mostra.
La passione del duca per gli oggetti preziosi è testimoniata dagli inventari del 1401 e del 1403, che elencano ben 1317 oggetti. Come ha scritto Philippe Malgoyres, la lettura di questi provoca vertigini: al di là dei reliquiari, ritroviamo un numero impressionante di oggetti in pietre dure, caraffe, vasi e saliere, di cui alcuni sono oggi esposti intorno al gisant. Un’altra sezione è consacrata al duca bibliofilo, possessore di circa trecento libri di lusso conservati prevalentemente nella sua residenza di Mehun-sur-Yèvre (Berry). In questa collezione, di cui sono stati ritrovati circa 127 pezzi, un posto di rilievo è occupato da Bibbie, libri liturgici e di devozione, affiancati da libri di storia. Stando alla testimonianza di Christine de Pizan, dieci esemplari delle cui opere erano conservati nelle raccolte ducali, Jean de Berry «amava i bei libri di scienze morali e politiche, la storia romana e le letture istruttive». Non mancavano codici bolognesi e lombardi, nonché capolavori offertigli dagli Angioini di Napoli quali la celebre Bibbia oggi a Lovanio e l’Histoire ancienne oggi alla British Library.
Questi inventari sono davvero eccezionali per i tempi perché non solo descrivono minuziosamente i manoscritti con il loro incipit ma indicano a volte il nome degli artisti incaricati della decorazione, come il caso già citato dei pittori dei primi fascicoli delle Très Riches Heures. Originari di una famiglia proveniente da Limbourg, villaggio tra Aquisgrana e Liegi, trasferitasi a Nimega, capitale della Gheldria, i tre fratelli erano nipoti del pittore Jean Malouel, attivo a Parigi per la regina Isabella di Baviera, poi per il duca di Borgogna, al cui servizio li ritroviamo agli inizi del Quattrocento. A Digione, sfavillante capitale del ducato, Herman, Paul e Johan poterono affinare la loro arte sugli esempi del grande scultore Claus Sluter e studiare il celeberrimo polittico Orsini, dipinto da Simone Martini, all’epoca conservato nella certosa di Champmol, pantheon dei duchi di Borgogna. Dopo la morte del loro protettore nel 1404, i tre artisti passarono al servizio di Jean de Berry, fratello del defunto duca.
Tra i primi incarichi ricordiamo il completamento nel 1405-’10 delle Très Belles Heures de Totre-Dame (Parigi, BnF), la realizzazione delle Belles Heures (New York, The Met), illeggiadrito da ben 172 miniature e unico capolavoro da loro integralmente miniato, e ancora un altro completamento, quelle delle Petites Heures (Parigi, BnF).
Tra il 1411 e il 1416, i fratelli Limbourg avviarono la decorazione del celeberrimo calendario delle Très Riches Heures dove vengono minuziosamente immortalati tutti i possedimenti del committente nonché i luoghi da lui amati. Vera e propria summa politica e culturale dell’universo mentale del duca, le miniature dei mesi traducono in immagini il gusto di questo grande mecenate e collezionista. Tuttavia, per la morte nello stesso 1416, e del duca, e dei tre fratelli miniatori, forse falciati da un’epidemia, l’opera rimase incompiuta.
Fu Luciano Bellosi a riconoscere nel 1975, sulla base di considerazioni vestimentarie e stilistiche, la mano di un altro artista, il cosiddetto Maître du Roi René, che intervenne per completare le miniature dei Limbourg, e cioè i fogli con le raffigurazioni dei mesi di marzo, giugno, settembre, ottobre e dicembre. Gli studi successivi hanno poi permesso di riconoscere in questo maestro la personalità di Barthélemy d’Eyck, artista fiammingo originario di Maaseyck (diocesi di Liegi), passato al servizio di Renato d’Angiò. Questi fece con buona probabilità intervenire il suo pittore nel 1446: la miniatura del mese di settembre evocherebbe un torneo organizzato a Saumur durante l’estate di quell’anno dal sovrano angioino in onore del re Carlo VII.
Una mostra da non perdere perché per la prima e ultima volta sarà possibile ammirare gli splendidi fogli miniati dai fratelli Limbourg e completati da Barthélemy d’Eyck in dialogo con dipinti di Malouel o di altri artisti legati alla loro arte. Una volta chiusa la mostra, i fogli del calendario saranno di nuovo rilegati con gli altri fascicoli, e le Très Riches Heures ritorneranno definitivamente al buio della cassaforte nel «Cabinet des livres» del duca d’Aumale.





