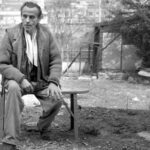Il lavoro nuoce gravemente alla salute: non abbiamo bisogno di tante parole per convincerci di questa verità, espressa fin dalle prime pagine dell’Antico Testamento – quando Adamo viene condannato a una vita di sudore – e confermata ogni volta che una famiglia spinge la propria prole ad eccellere negli studi nella speranza di sfuggire alle occupazioni più gravose.
Eppure sul lavoro sono state effettivamente spese tantissime parole negli ultimi centocinquant’anni, da quando due classi sociali sono irrotte nella Storia quasi simultaneamente: quella degli operai, impegnati a servire la macchina, e quella degli intellettuali, impegnati a osservare e a produrre un discorso sui primi.
Molte parole sul rapporto tra lavoro e salute, ad esempio, le ha spese a partire dagli anni Settanta lo psichiatra francese Christophe Dejours. Perché il lavoro oggi non è più quello dei tempi di Adamo: esso si è modernizzato e nel modernizzarsi è diventato forse meno faticoso ma sicuramente più frustrante. Il contributo di Dejours, che in Italia conosciamo soprattutto grazie all’impegno di Enrico Donaggio e dei suoi colleghi all’università di Torino, è stato quello di spostare l’attenzione dalla fatica fisica alla sofferenza psichica, inaugurando un campo di studi noto come psicodinamica del lavoro.
Il lavoro come oggetto di ricerca
La condizione dei lavoratori impegna la sociologia sin dalla sua fondazione. A ventisette anni il tedesco Max Weber, fresco del suo dottorato in giurisprudenza e ancora lungi dallo scrivere i suoi testi più celebri, si impegna in una ricerca sul campo per indagare la condizione dei lavoratori agricoli tedeschi ricorrendo a centinaia di questionari.
Siamo nel 1892 e lo studioso si scontra con la difficoltà di produrre una teoria universale partendo dalla molteplicità delle esperienze umane. Eppure arriva a due conclusioni importanti, che precorrono le analisi di Dejours: la prima è che i lavoratori non inseguono soltanto gratificazioni economiche ma anche simboliche, legate ad aspettative culturali, e in particolare tentano di soddisfare una certa idea di “felicità” associata alla propria autonomia. La seconda conclusione è che la modernizzazione sta modificando profondamente l’ordine sociale, annientando progressivamente quegli spazi di autonomia.
Un anno dopo Weber, il francese Emile Durkheim pubblica la sua tesi sulla Divisione del lavoro sociale dove propone un’idea rivoluzionaria, ovvero che la società moderna è tenuta assieme dalla fitta maglia dei rapporti di produzione: una solidarietà organica.
Quando però questo tessuto si disarticola, nei periodi di crisi in cui la domanda e l’offerta di lavoro sono disallineate, sorge una situazione di “anomia”, fonte di malessere psicologico che può portare a ogni tipo di devianza – suicidio in primis. Un secolo più tardi, assistendo a una nuova e più ampia epidemia di suicidi, Dejours dirà che oggi forse «abbiamo superato la soglia oltre cui l’organizzazione del lavoro si ritorce contro l’essere umano».
Tutto quello che oggi sappiamo del lavoro è il risultato di decenni di osservazioni, raccolta di dati e sforzi teorici: un capitale di conoscenza accumulato nei centri di ricerca pubblici e privati, da un paese all’altro, attraverso le generazioni. All’alba del Novecento i contributi dei primi sociologi europei nutrono le riflessioni degli studiosi americani, che si confrontano con la diffusione della famigerata «organizzazione scientifica del lavoro» di Frederick Taylor.
Nel 1927 Elton Mayo esamina il funzionamento degli stabilimenti Hawthorne della Western Electric a Chicago e scopre che, contrariamente ai precetti del taylorismo, a determinare la motivazione e il rendimento dei lavoratori sono innanzitutto i fattori sociali e psicologici, come il senso di appartenenza a un gruppo, l’attenzione ricevuta dalla direzione e le relazioni interpersonali. Nasce così la scuola delle Relazioni Umane: il capitale di conoscenze sul lavoro si accresce ancora, permettendo al capitalismo di “umanizzarsi” un pochino.
La critica dello sguardo tecnocratico
C’è qualcosa di ricorrente nel modo in cui – dai questionari di Weber alle ricerche di Mayo, fino a Dejours – è stato prodotto il sapere scientifico sul lavoro: esso è stato estratto dai lavoratori stessi. Come una quota segreta della loro fatica, cristallizzata sotto forma di capitale immateriale e ridotto a titolo di rendita per gli specialisti. In cambio, talvolta, di miglioramenti oggettivi.
Eppure, malgrado le sue buone intenzioni, non ci vuole molto perché Mayo passi dalla parte dei cattivi. Nel popolarizzare in Francia le sue idee nel Dopoguerra, il filosofo Georges Friedmann non esita ad accusarlo di essere l’ennesimo servo dei padroni: un “poliziotto buono” che si premura del benessere degli operai solo per migliorare il funzionamento della fabbrica. Ma non è questo in fondo il destino paradossale di tutti i sociologi del lavoro?
Il contrappasso è rapidissimo: negli anni 1950 Friedmann subisce la medesima accusa da parte dei giovani militanti di una rivista che farà la storia, Socialisme ou Barbarie. Tra i suoi fondatori, un filosofo-psicologo di nome Jean Laplanche: il maestro del nostro Christophe Dejours.
Sul primo numero della rivista figura la testimonianza di un operaio americano, pseudonimo Paul Romano. L’idea dei redattori di Socialisme ou Barbarie, perlopiù borghesi cresciuti alla scuola della sinistra anticomunista e della fenomenologia, è quella di dare la parola direttamente ai lavoratori, così evitando di appropriarsi del sapere operaio nonché di mettersi in una posizione direttiva. Ma per degli intellettuali non è facile trattenersi dall’astrarre e dal collegare, e a furia di glossare l’esperienza proletaria arrivano anch’essi ad alcune teorie generali.
Una in particolare, formalizzata da Cornelius Castoriadis, insiste sullo scarto cruciale tra l’organizzazione formale – le procedure che descrivono come dovrebbe funzionare la fabbrica in astratto – e il lavoro reale, che mobilita l’ingegno dei lavoratori di fronte a situazioni sempre differenti. Alla faccia dei tentativi degli esperti di individuare un “universale astratto”, delle medie e delle regolarità attorno alle quali imporre un modello di razionalità valido per tutti.
Il paradosso del capitalismo
Tre decenni dopo, ritroviamo l’idea di Castoriadis – che poi è l’idea dell’operaio Paul Romano – al cuore del pensiero di Christophe Dejours. Secondo lo psichiatra, sarebbe proprio in questo scarto che si annidano tanto le radici dell’ansia e dello stress quanto le potenziali fonti di piacere e di realizzazione personale, legate al riconoscimento della propria abilità e del proprio contributo. Eppure anche queste sono teorie, a loro volta confluite nel «nuovo spirito capitalismo».
L’utilità delle ricerche di sociologi e psichiatri del lavoro non cancella il paradosso fondamentale di queste attività, ben individuato da ogni generazione di militanti: esse si fondano sull’estrazione di un plusvalore dallo sforzo alla catena di montaggio o dalla sofferenza negli uffici. Così trasformano il lavoro intellettuale vivo in lavoro intellettuale morto, sotto forma di categorie e precetti. Un capitale intellettuale che va a nutrire la rendita della classe degli esperti che si occupano di migliorare l’organizzazione del lavoro. Per questo un grande anarchico polacco di un secolo fa, Jan Wacław Machajski, definiva gli intellettuali come dei «capitalisti del sapere».
Non abbiamo qui, di tutta evidenza, una ragione sufficiente per rifiutare il contributo prezioso di studiosi come Mayo a Dejours. In cambio di piccole quote di pluslavoro estratto, sottomettendo il lavoro vivo al dominio del lavoro morto, essi offrono ai lavoratori dei vantaggi psicofisici reali. Ma non è questo, in fondo, lo scambio ineguale su cui si fonda per sua essenza il capitalismo, e che oltre un secolo fa Weber osservava con orrore e rassegnazione?