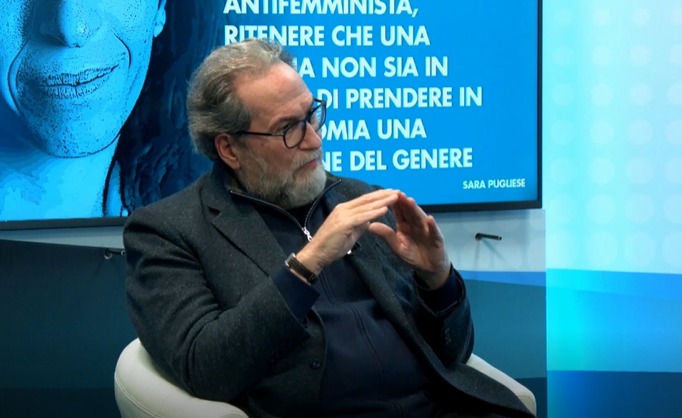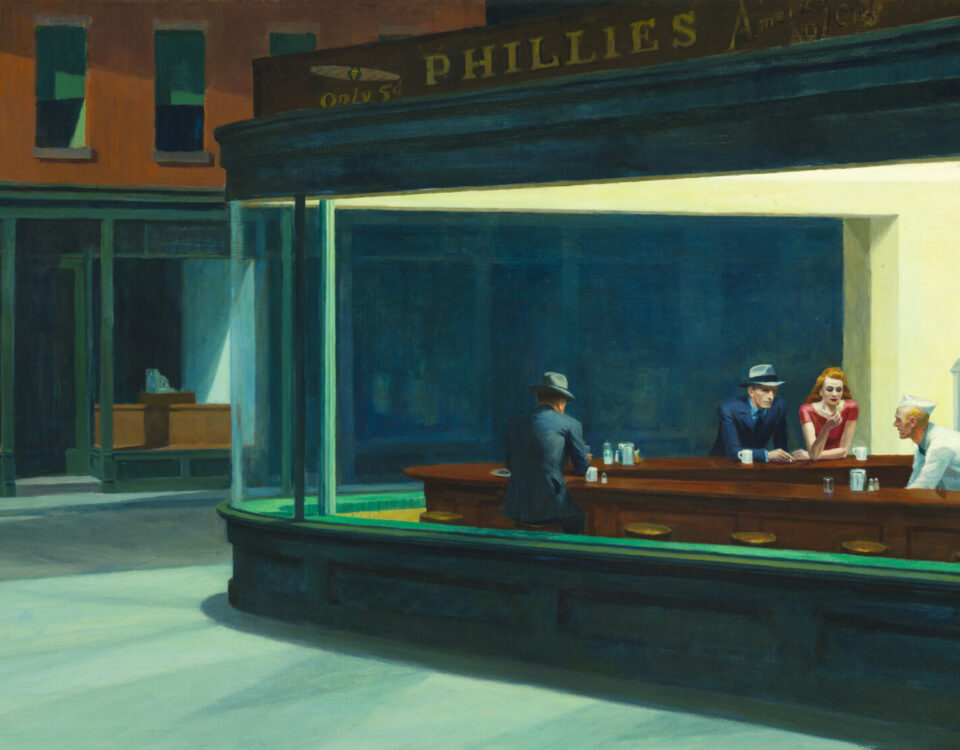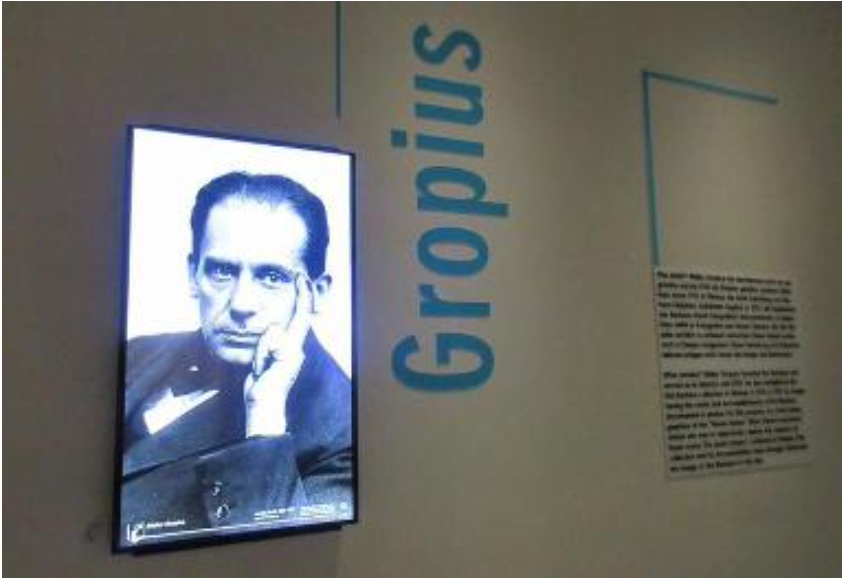Caso David Rossi: Pittelli nega ogni legame con Mussari, il fratello accusa “David fu picchiato prima di morire”
5 Novembre 2025
Digest Strategico del 6 novembre 2025
6 Novembre 2025Verso una politica del vivente
Il mondo che abitiamo porta i segni di una frattura profonda. La crisi climatica, il collasso della biodiversità, le disuguaglianze crescenti non sono fenomeni separati: sono sintomi di un sistema che ha dimenticato di essere parte di qualcosa di più grande. La frammentazione degli ecosistemi è diventata frammentazione sociale, e ciò che era diviso nel pensiero si è fatto divisione nel mondo.
La filosofia, di fronte a questo, non può più limitarsi a osservare. Deve tornare a pensare le condizioni della coesistenza, deve costruire una visione in cui l’essere umano non sia separato dalla natura, né il pensiero dall’esperienza. Spinoza aveva già intuito che mente e corpo non sono due sostanze diverse, ma espressioni di un’unica realtà. Whitehead ci ha mostrato che l’essere non è qualcosa di statico, ma un processo continuo di relazioni. La vita non è un dato: è ciò che accade tra le cose, non nelle cose.
Ma è forse Heidegger che ci offre la diagnosi più radicale della nostra condizione. La sua riflessione sulla tecnica moderna come Gestell, come imposizione calcolante che riduce il mondo a fondo disponibile, coglie il cuore della crisi ecologica. Quando la natura diventa semplice riserva di energia da estrarre, quando perfino l’essere umano è ridotto a risorsa, si compie quella che Heidegger chiama l’oblio dell’essere. La terra cessa di essere physis, quella forza originaria che emerge e si manifesta, per diventare oggetto manipolabile. Il pensiero calcolante sostituisce il pensiero meditante, e con esso perdiamo la capacità di abitare poeticamente il mondo, di stare in ascolto di ciò che si manifesta.
Heidegger ci invita a ripensare il nostro rapporto con la terra non come dominio ma come cura, come quella Sorge che costituisce la struttura fondamentale dell’esserci. Abitare, nel suo senso originario, significa custodire, preservare, lasciare essere. È un’etica dell’attesa e della prossimità, del rispetto per ciò che cresce e per i suoi tempi. La crisi che attraversiamo è anche una crisi dell’abitare: abbiamo costruito senza custodire, prodotto senza ascoltare, calcolato senza pensare.
La dimensione teologica della cura del creato
Questa crisi dell’abitare ha anche una dimensione teologica che non può essere elusa. Il paradigma estrattivo che ha dominato la modernità affonda le sue radici in un’interpretazione distorta del mandato biblico del “dominio” sulla terra. La Genesi parla di amministrazione, non di proprietà assoluta; parla di custodire il giardino, non di sfruttarlo fino all’esaurimento. La teologia cristiana, quando ha dimenticato che la creazione è dono e non possesso, ha contribuito a legittimare quella separazione tra umano e naturale che oggi si rivela catastrofica.
Francesco d’Assisi aveva compreso qualcosa di essenziale quando chiamava il sole “fratello” e la terra “sorella”: il creato non è una scala gerarchica con l’uomo al vertice, ma una comunità di creature legate da parentela ontologica. La Laudato si’ di Papa Francesco riprende questa intuizione con forza profetica: parla di “ecologia integrale”, riconosce che tutto è connesso, che non si può curare l’ambiente senza curare le relazioni umane, che la terra grida insieme ai poveri.
Ma è forse nella teologia ortodossa che troviamo la visione più radicale della sacralità del cosmo. La dottrina della theosis, della divinizzazione del creato, presuppone che la materia non sia qualcosa da trascendere ma da trasfigurare. L’incarnazione stessa è una dichiarazione ontologica: Dio non salva l’umanità dalla materia, ma attraverso la materia. Ogni elemento del creato porta in sé una vocazione alla gloria, una chiamata alla pienezza che passa attraverso la cura umana, non contro di essa.
Anche la teologia della liberazione latinoamericana ha compreso che non si può separare la giustizia sociale dalla giustizia ecologica. Leonardo Boff parla di “ecologia cosmica”, di una spiritualità che riconosce il grido della terra come grido dei poveri. La salvezza non è fuga dal mondo ma redenzione del mondo, liberazione di tutte le creature dall’oppressione e dallo sfruttamento.
Questa prospettiva teologica non è ornamentale: essa rivela che la crisi ecologica è anche, e forse soprattutto, una crisi spirituale. Abbiamo dimenticato che siamo creature tra le creature, che la nostra libertà è dono e responsabilità, che il mondo non ci appartiene ma ci è affidato. Il peccato ecologico è un peccato contro la relazione, contro quella rete di interdipendenze che sostiene la vita. È un tradimento della vocazione umana alla custodia.
Da questa comprensione nasce l’idea di un’economia diversa. Non più estrattiva, ma rigenerativa. Non più fondata sull’accumulo, ma sulla restituzione. Rigenerare significa restituire fertilità alla terra che coltiviamo, dignità al lavoro che svolgiamo, fiducia alle comunità che abitiamo. È un’economia che guarda ai cicli biologici come modelli di equilibrio, che riconosce il valore nelle relazioni più che nelle quantità. Georgescu-Roegen ci ha insegnato che l’economia è vincolata dalle leggi della termodinamica; Ostrom ci ha mostrato che i beni comuni possono essere gestiti senza distruggerli; Benkler ha dimostrato che la cooperazione funziona. Ma è la prospettiva teologica che ci ricorda che ogni atto economico è anche un atto di giustizia o di ingiustizia, di fedeltà o di tradimento verso il creato.
In questo orizzonte, la salute assume un significato politico e spirituale insieme. Riconoscere che la salute umana, animale e ambientale sono inseparabili significa accettare che siamo responsabili non solo di noi stessi, ma di tutto ciò che ci sostiene. Jonas parlava di responsabilità verso le generazioni future; Gilligan dell’etica della cura; Lévinas della responsabilità verso l’Altro. Tutte queste voci convergono: la libertà non è fare ciò che vogliamo, ma prenderci cura di ciò che condividiamo. E in prospettiva teologica, questa cura diventa liturgia cosmica, celebrazione della vita in tutte le sue forme.
Una democrazia all’altezza di questa sfida deve quindi cambiare. Non può più essere solo umana. Latour e Haraway ci ricordano che nel mondo ci sono altri soggetti: gli animali, le piante, gli ecosistemi, persino gli oggetti tecnici. Una politica veramente ecologica deve trovare il modo di ascoltarli, di integrare scienza e saperi locali, di costruire forme di governance che includano la pluralità del vivente.
Anche la tecnologia deve cambiare ruolo. Non più strumento di dominio, ma alleata della vita. Qui il pensiero di Heidegger ci offre una seconda indicazione preziosa: la tecnica non è il male in sé, ma un modo di disvelamento del mondo. Ciò che conta è come ci rapportiamo ad essa. Simondon e Stiegler ci hanno insegnato che la tecnica può essere un prolungamento del vivente; la biomimesi di Benyus ci mostra come imparare dalla natura anziché sfruttarla. La tecnologia può diventare etica, se sceglie di integrarsi invece di controllare, se recupera quella dimensione di téchne che i Greci intendevano come sapere artigianale, come cura attenta alla singolarità delle cose.
Gli ecosistemi sono la prova vivente che tutto questo è possibile. Essi funzionano perché ogni elemento sostiene gli altri, perché il limite non è una privazione ma una condizione di equilibrio. I nuovi materialismi di Bennett, Barad e Braidotti ci ricordano che la materia non è inerte: è attiva, relazionale, capace di agency. Non è qualcosa che usiamo, ma qualcuno con cui abitiamo. E in questa prospettiva, la materia stessa diventa sacramento, segno visibile di una grazia invisibile che permea il cosmo.
La politica della vita, allora, è prima di tutto una scelta di visione. Ogni decisione che prendiamo – economica, tecnologica, ambientale – dovrebbe rispondere a una domanda semplice: quello che stiamo facendo rigenera la vita o la consuma? È questa la misura di un’etica capace di tenere insieme responsabilità e speranza. Ed è anche una domanda teologica: stiamo onorando il dono della creazione o lo stiamo tradendo?
L’economia rigenerativa delle risorse viventi è, in fondo, una politica dell’etica e una pratica spirituale: un modo di stare al mondo fondato sulla reciprocità, sulla giustizia, sulla cura. In essa, il valore non si misura in quantità ma in qualità di relazioni. Gli ecosistemi viventi ne sono insieme il modello e la promessa: la possibilità di un futuro condiviso tra umano, natura e tecnica, nella comune responsabilità del vivere. Un futuro in cui, come avrebbe detto Heidegger, torniamo ad abitare poeticamente la terra, restituendole quella dignità ontologica che il pensiero calcolante le aveva negato. Un futuro in cui, come ci ricorda la sapienza teologica, riconosciamo finalmente che custodire il creato non è un compito accessorio, ma il cuore stesso della nostra vocazione umana.
Pierluigi Piccini