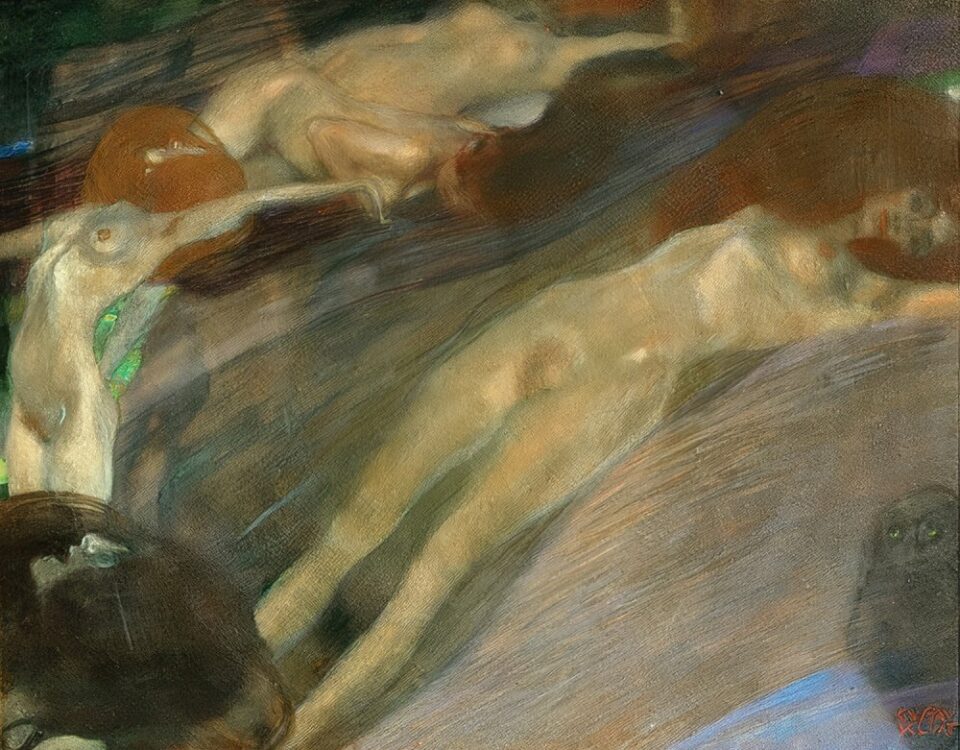L’arte come conversazione, l’arte come qualcosa che mette al centro le strutture invisibili della realtà, l’arte come una forma che sfugge al controllo delle coscienze. Rosalind Krauss, una delle più importanti critiche d’arte viventi, docente alla Columbia, ha contribuito a formare il modo in cui comprendiamo oggi l’arte. Per questo, ovvero «il suo ruolo fondamentale nell’affermazione dell’arte contemporanea come campo di ricerca», è tra i quattro studiosi che hanno ricevuto venerdì 14 novembre i Premi Balzan, uno dei più importanti riconoscimenti accademici a livello internazionale. Abbiamo parlato con lei a Berna, dove si trova per la premiazione.
Qual è il suo primo ricordo legato a un’opera d’arte?
Credo che i primi ricordi abbiano a che fare con un libro che mi ha regalato un amico dei miei genitori: erano riproduzioni di litografie di Matisse, e io sono rimasta incantata da quei disegni. E credo che il mio desiderio di riuscire a verbalizzare il piacere sia derivato da quello.
E il primo ricordo di una galleria o di un museo?
La National Gallery of Art a Washington.
Qual è il consiglio che darebbe a qualcuno che non sa nulla di storia dell’arte e visita una galleria? Come si guarda un’opera?
Penso che sia importante che ci sia una sorta di convinzione o presunzione che l’opera d’arte ti sta parlando e che quel discorso significhi qualcosa. Che non è solo un oggetto carino, ma un oggetto che ha qualcosa da dire a ognuno e quindi bisogna impegnarsi per capire cosa sta dicendo a te. È come quando parli con qualcuno: dai per scontato che quella persona sta parlando con te e che voglia dirti qualcosa. E tu devi interiorizzare ciò che l’altra persona sta dicendo, capirlo e dare per scontato che non stia solo farfugliando senza senso.
Lei in passato ha scritto della funzione e dell’organizzazione dei musei di arte moderna. Oggi qual è secondo lei il principale scopo di un museo?
Ho scritto dei musei nel periodo in cui il Guggenheim Museum, che possedeva un’enorme collezione di opere di Kandinsky, ha venduto i suoi Kandinsky. Ero indignata all’idea che potessero venderli. È come vendere i propri figli. Ho anche un altro esempio, ovvero che il Museum of Modern Art possedeva, dal mio punto di vista, uno dei Picasso più importanti che il cubismo o Picasso abbiano mai prodotto. Si trattava di un’opera del 1909 che Picasso aveva realizzato quando era in Spagna e che, dal mio punto di vista, rappresentava l’inizio del cubismo. Lo ha detto Gertrude Stein. E l’hanno venduto. E io ho pensato: «È come vendere la Gioconda». Perché mai fare una cosa del genere? A un certo punto ho chiesto a uno dei curatori: «Perché lo avete fatto?». E lui mi ha risposto: «Beh, ne avevamo un altro in condizioni migliori». Come se avendo un ritratto in condizioni migliori della Gioconda allora si potesse vendere la Gioconda!
Quindi mi interessava questo aspetto in termini di riflessione sull’economia moderna, ma non sono un’economista ed era molto complesso capire come funzionasse la leva finanziaria. E ancora oggi non saprei rispondere. Ma penso che i musei abbiano la responsabilità di essere i custodi, gli amministratori di ciò che l’arte, gli artisti hanno creato e di ciò in cui una cultura vede riflessa sé stessa. E quindi l’idea di vendere il proprio patrimonio mi sembra inaccettabile.
Lei ha scritto dell’importanza della struttura a griglia per l’arte del XX secolo, facendo riferimento per esempio a Piet Mondrian, ma anche ad altri. Anche oggi quel concetto è rilevante?
Sì, è una struttura eloquente. Lo penso in relazione, ad esempio, a Sol Lewitt e anche a Donald Judd. E dovrei dire anche Frank Stella. Quindi sì, penso che la griglia funzioni ancora per noi e possa parlare a noi. Parla a me.
Al di là dell’arte, è una struttura che ritroviamo in moltissimo contesti del mondo in cui ci muoviamo. Anche ad esempio nei social media, le pagine di Instagram sono organizzate a griglia.
Sì, in un certo senso ci sembra di conoscerla già perché fa parte del mondo in cui viviamo. Penso all’architettura moderna e in particolare a Ludwig Mies van der Rohe e al tipo di grattacieli di vetro in cui si sente la pressione della griglia delle finestre e delle travi d’acciaio. E quindi fa parte del mondo che ci circonda, il che a volte la rende quasi invisibile. E sono gli artisti che sentono la pressione di renderla visibile che, secondo me, stanno lavorando in modi molto importanti.
Lei ha dato un importante contributo allo studio della storia della fotografia. Per lei la fotografia è arte?
Ci sono alcune fotografie che considero assolutamente arte. Un esempio è Edward Weston, che considero uno straordinario fotografo che pensa in modo formale. Quindi sì certo alcune fotografie sono davvero opere d’arte. Ma devono essere intese come opere d’arte. Non possono essere semplici immagini.
Il fatto che negli ultimi vent’anni, con l’avvento degli smartphone, la fotografia sia diventata così integrata nel modo in cui viviamo la realtà ha cambiato la sua percezione?
Direi che è diventata spesso indistinguibile dai media e i media hanno in qualche modo sostituito il nostro modo di pensare alla realtà. Ed è una delle cose che mi deprime della centralità dei media, certamente dei social media. I social media hanno sostituito il nostro modo di pensare alla percezione e alle relazioni tra le persone. L’hanno volgarizzato. Sono un po’ reazionaria su questo.
Il suo approccio alla storia dell’arte è molto interdisciplinare.
Sono interessata alla semiotica. Ritorno all’idea di prima, all’aspettativa che l’arte intenda significare nello stesso modo in cui il linguaggio intende significare, per cui la lingua non è solo rumore. E sono affascinata da questo.
Quanto è importante la nostra conoscenza dell’autore di un’opera d’arte per capirla? Anche in relazione al fatto che oggi tante forme d’arte, la letteratura in primis, sono molto ripiegate sul loro autore.
La storia dell’arte tende a concentrarsi molto sull’arte come espressione biografica. Ad esempio, uno degli amici di Picasso ha detto, e questo è stato ripetuto da diversi studiosi, che per capire Picasso bisogna conoscere sua moglie, la sua casa e il suo cane. Quindi, lo studio di Picasso è ossessionato dalla biografia di Picasso. Ma secondo me questo approccio significa voltare le spalle a Picasso.
Quando pensa a un’opera d’arte che la commuove, cosa le viene in mente?
Il modo in cui si rivolge allo spettatore e in cui, secondo la mia esperienza, reinventa il proprio mezzo espressivo e sul fatto che un’opera d’arte è la memoria dell’intera storia del suo mezzo espressivo. Come Richard Serra, che insisteva sul fatto che qualsiasi opera che realizzava fosse in un certo senso la storia della scultura. Quindi sì, quello e sentire che l’artista si sta rivolgendo a me.
Lei è stata per tanti anni docente universitaria. Cosa pensa della retorica e delle misure che l’attuale governo americano sta usando contro le università nel suo paese?
Mi fa sentire disperata. Metà del premio Balzan va devoluto per un progetto di ricerca che sponsorizzi i giovani. Io sto donando i soldi a una fondazione della Columbia University che sostiene giovani studiosi. Una delle regole del progetto è che si organizzi una sorta di simposio aperto al pubblico in cui poi questi ricercatori presentino i loro lavori.
A me e al direttore dell’istituzione a cui sto donando il denaro è sembrata una buona idea far concentrare tutti questi ricercatori, anche se provenienti da ambiti molto diversi, su progetti con un tema simile e abbiamo scelto quello delle arti a rischio. Perché penso che ora siano a rischio a causa degli interventi del governo federale nelle università e nei musei. La federalizzazione dello Smithsonian Museum è un esempio e corriamo il pericolo di perdere davvero il controllo dell’università.
In quale forma secondo lei l’arte è politica?
Lo è nella misura in cui insiste non sulla “libertà di parola”, ma proprio sulla possibilità stessa dell’espressione individuale. E resiste al controllo della coscienza e dell’intelligenza.
La Fondazione internazionale Premio Balzan, nata nel 1957 a Lugano in memoria del giornalista, assegna ogni anno quattro premi, due nelle lettere, scienze morali e arti, e due nelle scienze fisiche, matematiche e naturali. I vincitori dei Premi Balzan 2025 sono stati premiati ieri a Berna. Oltre a Rosalind Krauss, gli altri vincitori erano Josiah Ober (Usa, Università di Stanford) per le scienze dell’antichità e il lavoro sulla democrazia ateniese, Christophe Salomon (Francia, Laboratoire Kastler Brossel, Parigi) nell’ambito degli studi sugli atomi e la misura ultraprecisa del tempo, e Carl H. June (Usa, Università della Pennsylvania) per gli studi sulla terapia genica o con cellule geneticamente modificate.